La casa dei nomi
«The Times»
«Questo romanzo è un inno a ciò che il romanzo può fare. Ci offre introspezione, dettaglio, e tutto...



Abbiamo incontrato Colm Tóibín a Roma, in occasione della sua partecipazione al festival letterario Libri Come. Tóibín è nato a Enniscorthy, in Irlanda, nel 1955 e ha pubblicato finora undici romanzi, due raccolte di racconti, una raccolta di poesie (Vinegar Hill, Interno Poesia editore, 2024) e quattordici libri di saggistica. Presso Einaudi ha pubblicato La casa dei nomi, Il Mago, Long Island e l’edizione tascabile di Brooklyn.
Molti dei tuoi personaggi sembrano trovarsi in bilico tra due mondi, tra il vecchio e il nuovo, tra il paese natale e l’America, tra i doveri familiari e i desideri personali. Cosa ti attrae di questa dinamica?
Credo che il grande dramma dell’Irlanda nel XX secolo, e forse anche di altri paesi — il sud Italia, per esempio, o molti paesi africani — sia il movimento delle persone, le grandi migrazioni. E questo porta con sé un dramma personale straordinario che spesso viene cancellato dalla storia, perché chi si muove, la prima generazione che emigra in America, per esempio, non ha tempo di scrivere libri: è troppo impegnato a costruirsi una vita. Spesso sono i figli o i nipoti a scrivere di quell’esperienza, ma dalla prospettiva della seconda o della terza generazione. È un tema che trovo molto interessante. E naturalmente non è qualcosa che è capitato solo ai poveri: con l’ascesa del nazismo è successo anche a uno come Thomas Mann. Dopo il 1933 non è più rientrato in Germania, ha perso due case, diversi conti bancari, molti quadri. Aveva costruito tutto un patrimonio: era un grande borghese, aveva due automobili, viveva molto bene. E poi improvvisamente si ritrova in California. Il fatto è che non aveva davvero imparato bene l’inglese. Non ebbe mai un amico americano. È stato in America dal ’37-’38 fino al 1952, ma come molti esuli tedeschi, non strinse legami. Non amavano gli americani. Pensavano semplicemente che non facessero per loro.
Come racconti ne Il Mago! E il tuo recentissimo racconto per il New Yorker, Five Bridges, parla di ritorno — dall’America all’Irlanda.
Sì, credo che oggi la questione dell’essere «illegali» in America abbia una valenza tutta nuova. Nei tre giorni intorno all’insediamento di Trump — diciamo dal venerdì al lunedì — ho lavorato ininterrottamente per scrivere un racconto ambientato proprio in quei giorni. Il mio protagonista è un irlandese che è stato clandestino in America per molti anni e decide di tornare a casa proprio in quel lunedì. Quindi la storia monta nel corso del fine settimana: sabato fa una lunga passeggiata con la figlia, e tutto si accumula fino a quella decisione. Ho scritto mentre quegli stessi giorni stavano accadendo nella realtà: la domenica, mentre scrivevo, sapevo che “domani, lunedì, lui tornerà”. Tutto in tempo reale.
Un po’ come ha fatto Ali Smith nel suo Seasonal Quartet.
Esatto, lei inserisce gli eventi in tempo reale. È molto divertente, perché hai la sensazione non tanto di scrivere narrativa, quanto di essere immerso nel momento storico.
Chi si muove non ha tempo di scrivere libri: è troppo impegnato a costruirsi una vita. Colm Tóibín
Five Bridges è nato come racconto o potrebbe essere l’inizio di un romanzo?
No, è un racconto. Non penso di farne altro. Ho quel personaggio in quel momento. Penso che un racconto debba avere un presente molto intenso, con forse qualche elemento di passato. Ma se rendi quel «presente» abbastanza forte, poi non riesci più a tornarci sopra. Non puoi continuare a giocarci.
E a questo punto saresti già in ritardo per scriverne in presa diretta.
Esatto. A meno che il protagonista del racconto non volesse tornare in America, ma non credo.
Il tuo stile è spesso caratterizzato da un certo riserbo. La tensione si costruisce più sul non detto che su ciò che è esplicitato. Questo è particolarmente evidente in Long Island, dove i momenti chiave — come la scena all’hotel Montrose — restano in sospeso, lasciando molto spazio all’immaginazione del lettore. Diresti che è una degli elementi centrali del tuo modo di scrivere?
È difficile giudicare questo aspetto, sapere quando è giusto lasciar fuori qualcosa. In Brooklyn, per esempio, anche se Eilis parte per la prima volta, la scena in cui dice addio a sua madre non è nel libro. Perché? Perché sarebbe stato un cliché: il lettore sa già che tipo di emozione comporta. Se una scena non serve, non la scrivo e vado avanti. In Long Island c’è stato un caso particolare: Eilis e Jim sono in hotel, ed è evidente che in qualche modo faranno sesso, ma sono entrambi molto riservati. Non ne parlerebbero mai. Quindi ho deciso di chiudere la porta — e lasciarla chiusa su qualunque cosa sia successa. Sappiamo che è successo qualcosa, ma non volevo entrare nei dettagli. Quindi sì, molte scene semplicemente non ci sono.
Invece le scene in cui Eilis nuota, sia in Irlanda che in America, sembrano avere sempre un significato importante, quasi segnano un punto di svolta nei romanzi. Come mai?
Perché se cresci in Irlanda, come è successo a me, e vivi a pochi chilometri dal mare, d’estate ci vai davvero in spiaggia. Affittavamo una casupola direttamente sul mare. L’acqua era fredda. Mia madre era molto tosta: entrava dritta in acqua e nuotava via. Noialtri invece eravamo congelati. Stavamo lì, con l’acqua alle ginocchia, sperando che succedesse qualcosa per non dover entrare del tutto. L’idea di immergersi completamente in quell’acqua… non è ghiacciata, ma è fredda. Semplicemente non riuscivamo a farlo. E per me è sempre stata una cosa enorme. Qualcuno mi ha detto che in tutti i miei romanzi c’è una scena in cui qualcuno deve entrare in mare, nel mare freddo. In ogni libro. Avrei voluto saperlo fin dall’inizio — ma è successo sempre per caso. Non ho mai deciso consapevolmente di includere una nuotata in ogni libro, ma in qualche modo ci è finita sempre dentro. Immagino perché per me è un momento importante, ogni anno. Ho dei veri e propri rituali. Ogni anno, quasi sempre l’ultimo giorno di agosto, vado al mare. Dopo diventa davvero troppo freddo. Ora sono più coraggioso di quanto lo fossi da ragazzo. Devo dire che non rimango più per ore a esitare, sperando di non dover entrare.

In un’altra intervista hai detto che «Dio ha inventato l’adulterio per permetterci di scrivere romanzi».
Sì. In America c’è un problema particolare: i ragazzi, diciamo sui vent’anni, ce l’hanno proprio con chi «tradisce» — usano la parola cheaters. Io associo «cheating» a barare a carte: giochi a poker, prendi una carta e bari. Ma loro usano quella parola con un senso morale molto forte. Quando cerco di parlare di un romanzo, dico: «Mi dispiace, ma se Madame Bovary non tradisce, non c’è il libro. Non abbiamo niente». Quindi, perché esiste l’adulterio? Forse è una cosa orribile, ma Dio l’ha creata per i romanzi, così gli scrittori possono avere una storia. Solo che gli studenti non trovano divertente questa affermazione — soprattutto in America.
E in Long Island c’è Tony, e il suo tradimento è ciò che scatena la reazione di Eilis.
Esatto. Sono cose che accadono. E se non accadono in un romanzo, non accade niente. Se scrivi: «Era felicemente sposata, si alzò la mattina dopo, era ancora felicemente sposata, preparò la colazione, uscì, tornò, lui la baciò, lei disse: “Che bello vederti” e lui: “Che bello vederti anche per me”», non è un romanzo, è noia. E allora Dio deve intervenire per far scorrere la storia.
Enniscorthy è la cittadina irlandese dove sei nato e dove hai vissuto fino al 1976, l’anno esatto in cui si svolgono i fatti raccontati in Long Island. Come hai scritto in un bellissimo saggio su Enniscorthy, i lettori hanno l’impressione di osservare ciò che accade dalla finestra, mentre girano le pagine. Hai mai avuto delle reazioni da parte degli abitanti della città su come la descrivi nei tuoi libri?
Sì, assolutamente. Mai avuto problemi. Credo che gli scrittori irlandesi abbiano avuto qualche difficoltà in passato — negli anni ’50, all’inizio degli anni ’60. Edna O’Brien, per esempio, o John McGahern. Scrivevano da una prospettiva locale e questo creava tensioni. Ma le cose sono cambiate. Anzi, ormai è quasi il contrario: tutti sono molto gentili.
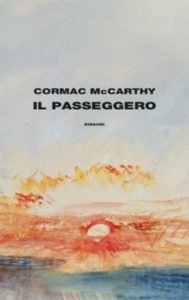
Nel cuore di una fredda notte del 1980, Bobby Western indossa la sua muta da sommozzatore e si tuffa nelle nere profondità della baia del Mississippi. Laggiù scorge il profilo di un aereo con nove corpi in cabina, gli occhi vuoti e le braccia protese verso un gelido abbraccio. Che fine ha fatto il fantomatico decimo passeggero? Quali oscure macchinazioni cela la sua scomparsa? Dolente viandante del mondo da sempre braccato dalla perdita e dalla colpa, ora Bobby deve tornare a fuggire, inseguendo la libertà e il ricordo di una donna per sempre irraggiungibile.
Dopo un silenzio durato 16 anni, Cormac McCarthy ci stupisce e conquista con un’opera di disperata bellezza e apicale bravura. Il passeggero, primo romanzo di una diade che si completerà con la pubblicazione di Stella Maris nel settembre 2023, è stato uno dei libri più attesi dell’ultimo decennio. E l’attesa, secondo la critica e il pubblico, è stata ampiamente ripagata:
«L’inconscio è più antico del linguaggio. Molto più antico. È un concetto su cui Cormac McCarthy torna spesso. Il passeggero è un libro splendido, e a questo tipo di riflessione deve molto».
Nicola Lagioia, «Lucy» (link)
«È pericoloso maneggiare un nuovo libro di McCarthy. Perché porta con sé la pazienza con cui è stato scritto e per il segreto che avvolge questo cowboy delle lettere, forse il più grande degli scrittori viventi. […] Abbiamo tra le mani un libro sugli amori che non si arrendono alla memoria. Ed è un libro di McCarthy, e di Cormac, le due personalità narrative dell'autore che sfiatano una prosa calcificata nella terra e una ricerca di amore sospesa. Si può leggere come una specie di thriller con lunghi dialoghi a disinnescare le tensioni, oppure come un viaggio fisico e spirituale verso la rotta che ci spetta. Se scegliamo la seconda via, dobbiamo sapere che si tratta di ferite a morte».
Marco Missiroli, «la Lettura – Corriere della Sera»
«Cormac McCarthy mostra con questo straordinario romanzo di sapersi inoltrare come pochi nelle pieghe più oscure dell'animo umano, spingendosi lì dove occorre avere un grande coraggio oltre a una scrittura che da tempo ha raggiunto una qualità stilistica tale da elevarlo senza alcun dubbio tra i classici […] McCarthy intesse così un romanzo capace di inchiodarci alla pagina come un thriller e allo stesso tempo di sollevare questioni fondamentali, facendoci interrogare sulla nostra natura, di più: sulla nostra (in)capacità di comprendere il mistero stesso della vita».
Giuseppe Culicchia, «tuttolibri – La Stampa»
«Il Passeggero è una perla preziosa che ogni lettore deve andarsi a prendere, pagina dopo pagina, nelle profondità dell'abisso. Non sarà semplice, talvolta rischierete di perdervi ma alla fine, fra le dita, vi resterà polvere di stelle, residui di vera letteratura».
Francesco Musolino, «Il Messaggero»
«È la profondità dell'oscurità a spaventare Bobby Western, l'uomo tormentato al centro del nuovo straordinario romanzo di Cormac McCarthy […] La scrittura di McCarthy è potente, inebriante […] Questo romanzo è un glorioso canto del tramonto».
Xan Brooks, «Internazionale – da The Guardian»
«La lingua di Il passeggero è qualcosa di nuovo, diverso: più semplice e diretta rispetto alle opere passate, ma in qualche modo evidentemente misurata, calcolata, nella quale nessun segno di punteggiatura è lasciato al caso ma si ha il sospetto che ogni minimo particolare, ogni fluttuazione della voce, abbia un significato a sé stante. “Per ogni accento che manca, sembra esserci un pensiero di giorni”, come scriveva John Jeremiah Sullivan sul New York Times».
Giulio D’Antona, «Domani»
«Come sostiene Raul Montanari, la narrativa di McCarthy è “un inferno darwiniano dove sopravvivere è il fine primario”. Le sue pagine – per richiamare Baricco – “adottano l'orizzonte epico del western” per mostrare l'uomo sedotto dalla violenza eppure affamato di sacro».
Crocifisso Dentello, «il Fatto Quotidiano»
«…Passerà il nostro tempo e noi con esso. Di noi, di noi oggi, resteranno alcune testimonianze, dei lasciti. Uno di questi è Il passeggero di Cormac McCarthy. Potrei scrivere di altro, ma non riesco a pensare ad altro da quando l'ho letto e il motivo non è riassumibile nella trama, ma nelle vette di pensiero che toccano i personaggi del romanzo. La mia copia è tutta sottolineata».
Ray Banhoff, «L’Espresso»
«Il passeggero, cioè, è un romanzo sapienziale, in cui McCarthy convoca i suoi eroi, trasognati «il Kid» e la cricca di felliniani freaks provengono da Meridiano di sangue; Bobby Western, il protagonista, ha la stessa stoffa del John Grady Cole di Cavalli selvaggi; l'amore tra i fratelli ricalca quello, di tenebrosa violenza, narrato in II buio fuori, per redigere una sorta di memorabile, ghignante requiem».
Davide Brullo, «il Giornale»

Martedì 3 maggio, negli studi di Cinecittà a Roma, sono stati assegnati i David di Donatello. Fra i vincitori c’è Donatella Di Pietrantonio, premiata insieme a Monica Zapelli per la miglior sceneggiatura non originale con L'Arminuta.
Dopo il libro quindi, vincitore del Premio Campiello 2017 e tradotto in tutto il mondo, continua il successo anche del film girato da Giuseppe Bonito.
«Non era una scommessa facile mettere in immagini il romanzo L'Arminuta di Donatella Di Pietrantonio [...] E invece la messa in scena sapientemente controllata di Giuseppe Bonito e una bella prova collettiva di recitazione (citiamo almeno le due "mamme", Vanessa Scalera quella naturale ed Elena Lietti quella adottiva) sanno restituire il disagio di chi vede crollare le proprie certezze e deve fare i conti con un mondo che nemmeno immaginava esistesse, ritratto di un'Italia piccolo borghese che aveva sperato di cancellare le proprie origini contadine e invece è costretta a farci i conti».
Paolo Mereghetti, «Corriere della Sera»
«Una delle voci più rilevanti, più significative, più letterarie del panorama italiano. L’Arminuta mi ha commosso».
Michela Murgia
«C’è una scrittrice unica in Italia. Per scrivere si alza molto presto al mattino e fra le cinque e le sette procede per “lampi”, come dice lei. Attraverso questi lampi, Donatella Di Pietrantonio ha scritto romanzi di grande potenza e L’Arminuta è una perla».
Matteo Nucci
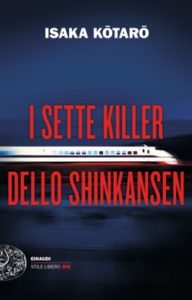
Un treno partito da Tokyo e lanciato a trecento all’ora nella campagna giapponese. Una valigia piena di soldi nascosta in una delle carrozze. E sette assassini pronti a entrare in azione: «È il set del romanzo I sette killer dello Shinkansen del giapponese Isaka Kotaro, maestro del crime. E lo dimostra già dalle prime pagine: negli stessi vagoni, per un motivo che al lettore resta oscuro fino all'ultimo, lo scrittore fa viaggiare coppie di assassini, quattordicenni psicopatici, sgherri della malavita nipponica, padri alcolizzati. Non è un caso che il "thriller sparatissimo", come recita la frase di accompagnamento, stia per diventare un film con Brad Pitt, Lady Gaga e Sandra Bullock» (Annachiara Sacchi - «la Lettura – Corriere della Sera»).
Il giovane Oji, Nanao (a suo dire l’assassino più sfigato del mondo) e gli altri protagonisti danno vita ad un thriller in cui tensione e adrenalina si susseguono fino all’ultimo; per il Times «una miscela di Tarantino e fratelli Coen».
Dialoghi surreali, colpi di scena, una trama che non dà respiro al lettore… Isaka ha creato un romanzo che è «sopraffino intrattenimento. Esilarante e truculento da sembrare un fumetto, veloce come un videogame, ironico, surreale nei dialoghi e parecchio sanguinario» (Annachiara Sacchi - «la Lettura – Corriere della Sera»).
Ho scritto I sette killer dello Shinkansen concentrandomi sull'elemento del divertimento. È questa la forza di gravità del romanzo. Isaka Kotaro
Ma è così facile nascondere una valigia zeppa di soldi in un treno? «Per questo aspetto della trama mi sono fatto aiutare da un redattore. L'ho fatto salire sullo Shinkansen e gli ho chiesto di aprire tutti gli spazi in cui si poteva immaginare di inserire o poggiare oggetti come una borsa. Facendogli scattare fotografie. Chissà cosa avranno pensato i controllori» (Isaka Kotaro intervistato da Giuliano Aluffi, «il venerdì – la Repubblica»).
Il film tratto dal romanzo di Isaka si intitolerà Bullet Train e uscirà nel 2022. Sarà diretto da David Leitch, già regista di Atomica bionda e Deadpool 2; nel cast ci saranno molte celebrità: i già menzionati Brad Pitt, Lady Gaga e Sandra Bullock verranno affiancati da Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Andrew Koji e Michael Shannon.