La casa dei nomi
«The Times»
«Questo romanzo è un inno a ciò che il romanzo può fare. Ci offre introspezione, dettaglio, e tutto...


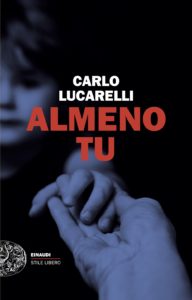
Quella di Vittorio è una vita come tante, che procede evitando squilli e cadute. Un giorno gli accade la più terribile delle tragedie: l’unica figlia, adolescente, muore mentre è con un gruppo di amici. Un incidente, così sembra, poi qualcuno insinua un dubbio. A quel punto l’esistenza di Vittorio, già devastata, si sgretola del tutto. Finché non è proprio la figlia morta, in sogno, a dirgli cosa deve fare: «Devi ammazzarli tutti».
Carlo Lucarelli torna con un thriller scorretto, crudele e doloroso perché, come sottolinea lo stesso autore, «qualche volta scrivere deve fare male, è necessario. Perché il noir è indagine sociale, come amo ripetere, se scava davvero. E perché oggi sono padre di due ragazzine di tredici anni: molto probabilmente qualche anno fa non avrei potuto scrivere questo libro. O forse lo avrei scritto, ma in modo completamente diverso» («7 – Corriere della Sera»).
«Dalla vendetta non si torna indietro, mai. Ho letto il romanzo di Carlo e mi è molto piaciuto quel padre tranquillo, almeno all’inizio, il che rende la vicenda ancora più tragica. Tutto si muove sul margine dell’errore, a volte si arriva a risultati giusti sbagliando clamorosamente. Ho una certa passione per quel tipo di trame, e medito di scriverne una anch’io».
Gianrico Carofiglio, «la Repubblica»
«Carlo Lucarelli, dopo quattro anni di silenzio dalla scrittura, è tornato e stavolta fa – davvero – paura… Stavolta te la porta a domicilio, dentro le mura domestiche, nella tragedia che colpisce un luogo come tanti (nello specifico Faenza), una famiglia come tante, un uomo come tanti: Vittorio. […] Dolore, dubbio, giustizia, verità, silenzi, reticenze: gli elementi per costruire un romanzo teso, dallo sviluppo imprevedibile e dall’esito aperto sono tutti sul piatto e Lucarelli si muove con maestria costruendo una trama avvincente e affidandosi a una scrittura asciutta, levigata, senza fronzoli, tagliente».
Severino Colombo, «La Lettura – Corriere della Sera»
«Carlo Lucarelli, uno dei più grandi scrittori di noir, questa volta ha messo da parte la Storia con la maiuscola – spesso cardine delle sue narrazioni – per addentrarsi in una vicenda che fa stringere lo stomaco sin dalle prime pagine. Almeno tu comincia infatti con uno di quegli annunci che ci tormentano negli incubi: la visita di un maresciallo a una coppia come tante, la notte, lo stupore, lo sgomento, la rivelazione (“c’è stato un incidente... vostra figlia è morta”) e poi l’abisso».
Roberta Scorranese, «7 – Corriere della Sera»
«Tra centri commerciali e caffè di paese, villette, caserme e bordi piscina, Lucarelli descrive con il consueto stile asciutto un’eterna provincia del mondo in bilico tra tranquillità e disperazione, prendendo tutti i punti di vista senza sceglierne alcuno. Nessuno è buono, nel suo universo, ma chiaramente le vittime sono i ragazzi, schiacciati dall’ingordigia, dall’egoismo, dalla vigliaccheria degli adulti. D’altronde se gli adolescenti ci fanno paura è perché sono il nostro sintomo: rivelano con le loro azioni la parte più oscura di noi, mostrano al mondo i nostri fallimenti, le nostre debolezze, la faccia che vogliamo nascondere».
Raffaella Silipo, «tuttolibri – La Stampa»

Mario Vargas Llosa, il grande autore peruviano, è morto a 89 anni a Lima, «in pace, circondato dalla sua famiglia». Nato il 28 marzo 1936, era naturalizzato spagnolo.
Vinse il Nobel per la letteratura nel 2010 «per la sua cartografia delle strutture del potere e per le acute immagini della resistenza, rivolta e sconfitta dell'individuo». Ha scritto capolavori come La città e i cani, La zia Julia e lo scribacchino, La Casa Verde, Elogio della matrigna.
Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate.
«Ho imparato a leggere a cinque anni, nella classe di frate Giustiniano all’Accademia de la Salle di Cochabamba». Così, nel 2010, iniziava il suo discorso di accettazione del premio Nobel per la Letteratura all’Accademia di Svezia. Settanta anni dopo, riconosceva serenamente che il momento magico in cui - decifrando i segni e trasformandoli in parole - aveva abbattuto le frontiere dello spazio e del tempo, «era la cosa più importante che mi è mai accaduta».
Avvenne nel 1941: il piccolo Mario - nato in Perù - cresceva in Bolivia senza padre (gli avevano detto che era morto), con la famiglia della madre: grandi lettori, appassionati di poesia. Anni talmente felici che non proverà mai a raccontarli. La scrittura è una forma di protesta: nasce sempre dal trauma, dal conflitto, dalla rivolta.
Nel suo caso, contro il padre, che nel 1946 riapparve per riprenderlo, riportarlo in Perù e sottometterlo alla propria ferrea disciplina. Nel 1950 lo iscrisse all’Accademia Militare Leoncio Prado. La tirannia familiare duplicava quella nazionale, perché il Perù era allora sottomesso alla dittatura del generale Odría. La letteratura divenne per il ragazzo ribelle il passaporto per la libertà. Il precoce matrimonio con la zia acquisita Julia, dieci anni più grande di lui, il trasferimento in Spagna e poi a Parigi, dove scoprì l’America Latina (e lesse Borges, Paz, García Márquez, Fuentes, Rulfo, Cabrera Infante, Onetti, Cortázar, Donoso) e il viaggio in Amazzonia dove - rifiutando ogni tentazione di esotismo o idealizzazione di una presunta armonia con la natura - scoprì il Perù arcaico dei nativi, esclusi dalla modernità e in balia del dispotismo e dell’ingiustizia, fecero di lui uno scrittore.
Il suo primo amore in verità era stato il teatro (sedotto da Morte di un commesso viaggiatore di Miller al teatro Segura di Lima), e aveva esordito come giornalista e autore di racconti (I cuccioli. I capi, 1959). È stato anche critico letterario (pregevoli i suoi scritti su Flaubert e Borges e sul romanzo - fra cui La verità della menzogna e La letteratura è la mia vendetta, dialogo con Claudio Magris), saggista (articoli e interviste raccolti in Contro vento e marea, 1982-86, mentre Il richiamo della tribù, 2018, è una ricognizione fra i pensatori liberali, come Aron, Berlin e Popper, che hanno anteposto l’individuo alla tribù, cioè alla classe, al partito, alla nazione), e politico.
Da studente marxista e socialista, intellettuale engagé nella maturità, come molti della sua generazione influenzato da Sartre, salutò con favore la rivoluzione cubana, per poi rinnegarla quando essa, divenuta regime, iniziò a reprimere il dissenso. L’invasione russa della Cecoslovacchia nel 1968 sancì la disillusione, e l’inizio di un sofferto percorso di avvicinamento all’umanesimo laico di Camus e al liberalismo. Nel 1987, col Movimiento Libertad, ha guidato le proteste contro il progetto del presidente García di nazionalizzare il sistema bancario: divenuto leader del Frente Democratico, si è candidato nel 1990 alle elezioni presidenziali del Perù. Denigrato come reazionario e conservatore (mentre lui ha sempre sostenuto che nell’America Latina funestata dalle dittature, dal terrorismo, dal nazionalismo, dal misticismo, dal razzismo, essere liberali significa essere rivoluzionari), fu sconfitto al secondo turno da Fujimori, su cui si riversarono i voti della sinistra.
Nel 1992, con un colpo di stato, Fujimori abolì parlamento e democrazia, instaurando l’ennesima dittatura: ma Vargas Llosa si era già trasferito in Spagna, paese del quale è divenuto cittadino. Se ho rievocato questa esperienza (da Vargas Llosa raccontata nell’autobiografia Il pesce nell’acqua, 1993) è perché essa ha fatto di lui il protagonista di uno dei suoi romanzi, svelando l’essenza stessa della letteratura – che dai fatti e dal vissuto nasce, ma insegna a inventare la vita e a trasformarla. La riflessione sulla natura del potere, sulla debolezza e la nobiltà dell’essere umano è del resto il nucleo della sua opera, tanto da figurare nella motivazione del premio Nobel, attribuitogli appunto per «la cartografia delle strutture del potere, per la sua immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell’individuo».
Ma Vargas Llosa è stato soprattutto un romanziere, trascinato dalla «passione, il vizio, la meraviglia della scrittura». Dal primo romanzo, La città e i cani (1962), ispirato alla sua esperienza all’accademia militare di Lima, fino all’ultimo, Tempi duri (2019), non ha mai cessato di credere nel potere del romanzo. Ha riconosciuto come maestri Flaubert, Faulkner, Dickens, Balzac, Conrad, Mann, Orwell, ma sin dal fulminante esordio che lo impose in tutto il mondo (è stato tradotto in 60 lingue), ha cercato di rinnovarlo e reinventarlo, traghettandolo nel XXI secolo. Combinando lirismo e realismo, moltiplicando i punti di vista, stravolgendo i piani temporali, usando il monologo interiore e i dialoghi, la storia, la cronaca, la satira e l’erotismo, ha indagato le miserie del suo paese e dell’animo di tutti.
In Perù – il paese di «ogni sangue» secondo José Maria Arguedas – sono ambientati La casa verde (1966), Conversazione nella cattedrale (1969), Pantaleon e le visitatrici (1973), Zia Julia e lo scribacchino (1977), Avventure della ragazza cattiva (2006), L’eroe discreto (2013), Crocevia (2019) e Le dedico il mio silenzio (2023). Ma le sue storie esplorano l’America Latina tutta, dal Brasile ottocentesco de La guerra alla fine del mondo (1981), alla Santo Domingo di Trujillo in La festa del caprone (2000), al Guatemala di Tempi duri (2019), fino alla Polinesia de Il paradiso è altrove (2003), e al Congo-belga devastato dal colonialismo de Il sogno del celta (2010).
Vargas Llosa non ha mai perso la fiducia nella capacità sediziosa della narrativa di creare un mondo alternativo, senza frontiere di lingua, cultura e religione, nel quale trovare rifugio contro le avversità o la barbarie, dissipare il caos, eternare la bellezza di un istante. Un mondo senza letteratura (o con una letteratura ridotta a svago e passatempo) sarebbe un mondo senza desideri e ideali – ha detto - perché le menzogne della letteratura diventano verità attraverso di noi, e i lettori contagiati dal dubbio metteranno in discussione la realtà mediocre in cui gli tocca vivere. La finzione è un’assoluta necessità affinché la nostra civiltà continui a esistere, si rinnovi e preservi in noi il meglio di ciò che è umano. E per questa utopia visionaria, che si è tradotta in personaggi ambigui e indimenticabili, e in migliaia di pagine trascinanti, sinistre, divertenti, feroci, sempre gli saremo grati.
Pubblicato per gentile concessione di «la Repubblica». Riproduzione riservata.

Clementina, romanzo d’esordio di Giuliana Salvi, è la storia di una donna che, rimasta vedova e con tre figli, deve reinventarsi e caricarsi sulle spalle l’intera famiglia. Mentre la Storia impazza fuori dalla finestra e l’Europa combatte la Prima Guerra mondiale, lei decide di lasciare Roma – dove viveva col marito – e tornare a Lecce, nella casa di famiglia.
Proprio in quella casa, dove da bambina studiava, leggeva e scriveva racconti, sceglie di dedicarsi all’insegnamento. Accettare ragazzini e ragazzine nel proprio salotto e curare la loro istruzione: è nell’insegnamento che Clementina realizza sé stessa, e trova il modo per aiutare i propri figli. Vincendo le proprie resistenze e quelle del suo tempo non immagina che la sua casa possa trasformarsi in scuola: appiglio, salvezza, piccola rivoluzione.
Ispirato alla storia vera della bisnonna dell’autrice, Clementina è un romanzo che non si dimentica, grazie alla forza di un personaggio estremamente contemporaneo. È una storia, secondo Leonetta Bentivoglio che l’ha recensita su Robinson, «fondata sulla resilienza di una donna desiderosa di reinventare il mondo. Narra la sorte dell’autentica bisnonna dell’autrice. Ci sono tante maniere di fare una rivoluzione senza salire sulle barricate, e Clementina realizza la propria sventolando a modo suo, più di pancia che di testa, la bandiera femminista».
La figura che l’autrice ha restituito ai lettori non è quella di un’eroina. La stessa Salvi ammette che «Clementina era ruvida, complicata, come madre a tratti castrante. Ma anche stimolante, attenta. Era una femminista nei fatti, non nelle rivendicazioni, per le quali non aveva tempo. Nell’insegnamento ha messo tanta passione che chi le stava attorno ne è stato invaso» (il venerdì – la Repubblica).
Per Carmen Pellegrino «muovendo dalla personale esigenza di “rendere giustizia” alla figura della sua antenata, Salvi sembra andare in cerca di un grande linguaggio dimenticato, di una pietra, di una foglia, di una porta non trovata. E, continuerebbe Thomas Wolfe, di tutti i volti dimenticati. Un esordio decisamente convincente» (La Lettura – Corriere della Sera).
Clementina ha toccato e commosso molti lettori, che hanno scritto direttamente all’autrice per esprimere i propri pareri e le emozioni provate durante la lettura del romanzo. Ve ne lasciamo alcuni:
«Mentre leggo il suo libro sul treno sto piangendo davanti a tutti. Non pensavo che un libro potesse prendermi così tanto, la ringrazio per avermi fatto sentire parte di una famiglia meravigliosa e forte».
Alice
«Buonasera, scusi l’ora tarda. Sono una libraia, ieri ho divorato e amato il suo romanzo. Volevo ringraziarla per la storia stupenda di questa donna che ha voluto scrivere e tramandarci».
Lydia
«Ho finito di leggere il romanzo ieri pomeriggio. Ho pianto, ho gioito, mi sono appassionata alla storia ed affezionata a ogni singolo personaggio».
Patrizia
«Ho amato Clementina e la sua vita come fosse mia nonna. Grazie. Libro stupendo. Clementina spacca!».
Anna

Roberto De Simone è stata una figura di artista a tutto tondo: pianista di valore, compositore, scrittore, uomo di teatro. Grazie a un affascinante intreccio di filologia e creatività, ha saputo costruire un ponte fra la cultura barocca e la modernità e riformulare una viva tradizione napoletana distante da ogni banalizzazione folkloristica. Esito sommo di questo lavoro è stato ovviamente La gatta Cenerentola, uno spettacolo di enorme successo che De Simone mise in scena come autore e regista nel 1976 con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, da lui fondata. Ma in tutti i suoi spettacoli e i suoi libri c’è la stessa idea di fondo: quella di ritrovare l’unità sostanziale tra l’anima colta e l’anima popolare della tradizione napoletana. Se per gli studiosi romantici ottocenteschi la letteratura popolare era il momento creativo sorgivo, elaborato successivamente dai letterati, e se Benedetto Croce aveva viceversa teorizzato che la letteratura dialettale era sempre una letteratura riflessa, cioè derivata da quella colta, per De Simone l’origine era comune: nella storia letteraria e musicale di Napoli “miseria e nobiltà” erano sempre andate a braccetto. La vera cultura popolare (quella che, secondo lui, va dal tardo Cinquecento al primo Novecento) dava vita a forme raffinatissime così come la letteratura e la musica colte sapevano farsi capire da tutti. In questo sentiva una parentela con la sensibilità di Pasolini, e come Pasolini deprecava l’omologazione del pieno Novecento che aveva inquinato e corrotto questa tradizione e aveva banalizzato la musica, la letteratura, il teatro (Eduardo era sul suo banco degli imputati), la cultura popolare e, in particolare la canzone napoletana.
Con Einaudi ha pubblicato una quindicina di libri in poco più di quarant’anni. Fu Roberto Cerati a chiedergli La gatta Cenerentola subito dopo averla vista a teatro: il libro uscì nel 1977 e ha avuto venti edizioni, più un paio con il video dello spettacolo. Ma è negli anni della maturità che De Simone ha infittito la collaborazione portando a compimento alcuni «Millenni» che sono entrati nella storia della collana: le Fiabe campane (1994), Il cunto de li cunti del Basile con la sua riscrittura in napoletano moderno (2002), La canzone napolitana (2017), sempre con le illustrazioni di Gennaro Vallifuoco. E poi, oltre al fondamentale saggio sul Presepe popolare napoletano (1998), mi piace segnalare due testi teatrali originali degli anni recenti, a testimoniare che la sua vena creativa si era mantenuta viva anche in tarda età: Cinque voci per Gesualdo (2013), dedicato al grande compositore di madrigali che uccise la moglie nel 1590, un testo dove in De Simone convivono il drammaturgo e il musicologo, e L’oca d’oro (2019), una sorta di testamento in cui tutte le sue idee teatrali vengono passate in rassegna al cospetto di un capocomico morente, con un irresistibile cocktail di gag tratte da un repertorio che andava dalla commedia dell’arte a Totò. Ricordo che abbiamo presentato questo libro al Teatro Argentina di Roma con le letture di Isa Danieli, un’attrice della vecchia guardia, molto cara al Maestro, come tutti lo chiamavano. De Simone aveva già molti problemi fisici e, pur sostenuto, raggiunse il palco con fatica, ma poi l’atmosfera di affetto che lo circondava e la forza del suo testo che veniva letto lo rasserenarono completamente facendogli dimenticare tutti i guai.
De Simone era così: a volte un carattere non facilissimo ma, messo in un teatro con gli attori e le musiche giuste, era la persona più gioviale, ironica e generosa. E così lo ricorderanno tutti coloro che hanno lavorato con lui nel corso di tanti anni.

Se vi trovaste a dover costruire il vostro partner ideale a tavolino, quale scelte prendereste? Sarebbe un esercizio semplice? O completamente ozioso? E in fondo: esiste davvero un partner ideale?
Queste domande sembrano assillare anche Lauren, la protagonista del romanzo d’esordio di Holly Gramazio, quando si trova a stilare una lista di ciò che un marito dovrebbe avere. La ricerca della perfezione la condannerà a un loop infinito di mariti?
Una sera, tornata a casa dall’addio al nubilato di un’amica, Lauren trova uno sconosciuto che sta scendendo dalla sua soffitta, solo che quello sconosciuto sostiene di essere suo marito e, incredibilmente, lo è davvero. E quando quel marito risale in soffitta, ecco scendere un altro sconosciuto, e quello sconosciuto è il suo nuovo marito. E così scopre di avere una «soffitta magica», una soffitta che fa e disfa mariti, e coi mariti fa e disfa la sua vita, a ripetizione. È questo l’avvio di una commedia brillante che illumina la natura delle relazioni sentimentali nel nostro tempo.
Gramazio, come ha sottolineato Annachiara Sacchi nelle pagine del Corriere della Sera, ha scritto un romanzo «divertente, doloroso, arguto, straniante, profondo… che da commedia esilarante (solo a tratti romantica) assume toni dark; che è totalmente immaginaria, ma con le radici ferocemente ancorate alla realtà. Quella di una società “social” che però è antisociale, che corre veloce come in un’app di appuntamenti, dove scorrere come in un catalogo infiniti tipi di umanità, dove “un sacco di ragazzi matchano con tutte, fanno swipe, swipe”. Dove la compatibilità tra due persone la decide un algoritmo».
Un libro ironico e pungente, che parte da «una di quelle idee (sfolgoranti) che sanno raccontare questi tempi, le storie sperimentali che sembravano andate perse dopo la rivoluzione del realismo, l’autofiction, e il paradiso delle storie comuni a corto raggio. I mariti è un romanzo di quelli con la tassa d’ingresso e un patto di lealtà: il lettore sospende l’incredulità, lo scrittore in cambio lo accompagna a capire qualcosa di nuovo. L'ultimo esperimento così riuscito lo aveva fatto Ottessa Moshfegh con l’Anno di Riposo e Oblio» (Ester Viola sul Foglio).
Gramazio, oltre ad essere scrittrice è anche una game designer e ha accompagnato l’uscita del libro con un Generatore di mariti: «Un gioco che inizialmente ho creato per aiutarmi a scrivere il romanzo, un modo per immaginare uomini che potrebbero esistere e scendere dalla soffitta di Lauren. Combina casualmente diversi hobby, nomi e abitudini per creare milioni di mariti possibili. Abbiamo pensato di metterlo online, così chiunque può divertirsi a generarne uno proprio».
«L’esperienza di Gramazio come curatrice d’arte e game designer dona a I mariti più profondità e sfumature di quanto ci si potrebbe aspettare dalla sua premessa stravagante… La tua reazione al finale di questo straordinario romanzo potrebbe dipendere dalla tua esperienza della vita di coppia. O, semplicemente, della vita, punto».
«The Washington Post»
«Gramazio di mestiere fa la game designer. E si vede: il suo bel romanzo d’esordio I mariti somiglia a uno di quei videogiochi pieni di mondi paralleli in cui avventurarsi»
«Donna Moderna»
«…Un po' come facciamo tutte noi alle prese con l’eterna commedia della scelta dell’uomo perfetto. E da commedia è infatti il tono di I mariti di Holly Gramazio, un romanzo che sa rendere realistica persino la magia di una soffitta da cui sbucano tutte le possibilità di innamorarci della persona giusta.
Rossana Campisi, «Io Donna»

Abbiamo incontrato Colm Tóibín a Roma, in occasione della sua partecipazione al festival letterario Libri Come. Tóibín è nato a Enniscorthy, in Irlanda, nel 1955 e ha pubblicato finora undici romanzi, due raccolte di racconti, una raccolta di poesie (Vinegar Hill, Interno Poesia editore, 2024) e quattordici libri di saggistica. Presso Einaudi ha pubblicato La casa dei nomi, Il Mago, Long Island e l’edizione tascabile di Brooklyn.
Molti dei tuoi personaggi sembrano trovarsi in bilico tra due mondi, tra il vecchio e il nuovo, tra il paese natale e l’America, tra i doveri familiari e i desideri personali. Cosa ti attrae di questa dinamica?
Credo che il grande dramma dell’Irlanda nel XX secolo, e forse anche di altri paesi — il sud Italia, per esempio, o molti paesi africani — sia il movimento delle persone, le grandi migrazioni. E questo porta con sé un dramma personale straordinario che spesso viene cancellato dalla storia, perché chi si muove, la prima generazione che emigra in America, per esempio, non ha tempo di scrivere libri: è troppo impegnato a costruirsi una vita. Spesso sono i figli o i nipoti a scrivere di quell’esperienza, ma dalla prospettiva della seconda o della terza generazione. È un tema che trovo molto interessante. E naturalmente non è qualcosa che è capitato solo ai poveri: con l’ascesa del nazismo è successo anche a uno come Thomas Mann. Dopo il 1933 non è più rientrato in Germania, ha perso due case, diversi conti bancari, molti quadri. Aveva costruito tutto un patrimonio: era un grande borghese, aveva due automobili, viveva molto bene. E poi improvvisamente si ritrova in California. Il fatto è che non aveva davvero imparato bene l’inglese. Non ebbe mai un amico americano. È stato in America dal ’37-’38 fino al 1952, ma come molti esuli tedeschi, non strinse legami. Non amavano gli americani. Pensavano semplicemente che non facessero per loro.
Come racconti ne Il Mago! E il tuo recentissimo racconto per il New Yorker, Five Bridges, parla di ritorno — dall’America all’Irlanda.
Sì, credo che oggi la questione dell’essere «illegali» in America abbia una valenza tutta nuova. Nei tre giorni intorno all’insediamento di Trump — diciamo dal venerdì al lunedì — ho lavorato ininterrottamente per scrivere un racconto ambientato proprio in quei giorni. Il mio protagonista è un irlandese che è stato clandestino in America per molti anni e decide di tornare a casa proprio in quel lunedì. Quindi la storia monta nel corso del fine settimana: sabato fa una lunga passeggiata con la figlia, e tutto si accumula fino a quella decisione. Ho scritto mentre quegli stessi giorni stavano accadendo nella realtà: la domenica, mentre scrivevo, sapevo che “domani, lunedì, lui tornerà”. Tutto in tempo reale.
Un po’ come ha fatto Ali Smith nel suo Seasonal Quartet.
Esatto, lei inserisce gli eventi in tempo reale. È molto divertente, perché hai la sensazione non tanto di scrivere narrativa, quanto di essere immerso nel momento storico.
Chi si muove non ha tempo di scrivere libri: è troppo impegnato a costruirsi una vita. Colm Tóibín
Five Bridges è nato come racconto o potrebbe essere l’inizio di un romanzo?
No, è un racconto. Non penso di farne altro. Ho quel personaggio in quel momento. Penso che un racconto debba avere un presente molto intenso, con forse qualche elemento di passato. Ma se rendi quel «presente» abbastanza forte, poi non riesci più a tornarci sopra. Non puoi continuare a giocarci.
E a questo punto saresti già in ritardo per scriverne in presa diretta.
Esatto. A meno che il protagonista del racconto non volesse tornare in America, ma non credo.
Il tuo stile è spesso caratterizzato da un certo riserbo. La tensione si costruisce più sul non detto che su ciò che è esplicitato. Questo è particolarmente evidente in Long Island, dove i momenti chiave — come la scena all’hotel Montrose — restano in sospeso, lasciando molto spazio all’immaginazione del lettore. Diresti che è una degli elementi centrali del tuo modo di scrivere?
È difficile giudicare questo aspetto, sapere quando è giusto lasciar fuori qualcosa. In Brooklyn, per esempio, anche se Eilis parte per la prima volta, la scena in cui dice addio a sua madre non è nel libro. Perché? Perché sarebbe stato un cliché: il lettore sa già che tipo di emozione comporta. Se una scena non serve, non la scrivo e vado avanti. In Long Island c’è stato un caso particolare: Eilis e Jim sono in hotel, ed è evidente che in qualche modo faranno sesso, ma sono entrambi molto riservati. Non ne parlerebbero mai. Quindi ho deciso di chiudere la porta — e lasciarla chiusa su qualunque cosa sia successa. Sappiamo che è successo qualcosa, ma non volevo entrare nei dettagli. Quindi sì, molte scene semplicemente non ci sono.
Invece le scene in cui Eilis nuota, sia in Irlanda che in America, sembrano avere sempre un significato importante, quasi segnano un punto di svolta nei romanzi. Come mai?
Perché se cresci in Irlanda, come è successo a me, e vivi a pochi chilometri dal mare, d’estate ci vai davvero in spiaggia. Affittavamo una casupola direttamente sul mare. L’acqua era fredda. Mia madre era molto tosta: entrava dritta in acqua e nuotava via. Noialtri invece eravamo congelati. Stavamo lì, con l’acqua alle ginocchia, sperando che succedesse qualcosa per non dover entrare del tutto. L’idea di immergersi completamente in quell’acqua… non è ghiacciata, ma è fredda. Semplicemente non riuscivamo a farlo. E per me è sempre stata una cosa enorme. Qualcuno mi ha detto che in tutti i miei romanzi c’è una scena in cui qualcuno deve entrare in mare, nel mare freddo. In ogni libro. Avrei voluto saperlo fin dall’inizio — ma è successo sempre per caso. Non ho mai deciso consapevolmente di includere una nuotata in ogni libro, ma in qualche modo ci è finita sempre dentro. Immagino perché per me è un momento importante, ogni anno. Ho dei veri e propri rituali. Ogni anno, quasi sempre l’ultimo giorno di agosto, vado al mare. Dopo diventa davvero troppo freddo. Ora sono più coraggioso di quanto lo fossi da ragazzo. Devo dire che non rimango più per ore a esitare, sperando di non dover entrare.

In un’altra intervista hai detto che «Dio ha inventato l’adulterio per permetterci di scrivere romanzi».
Sì. In America c’è un problema particolare: i ragazzi, diciamo sui vent’anni, ce l’hanno proprio con chi «tradisce» — usano la parola cheaters. Io associo «cheating» a barare a carte: giochi a poker, prendi una carta e bari. Ma loro usano quella parola con un senso morale molto forte. Quando cerco di parlare di un romanzo, dico: «Mi dispiace, ma se Madame Bovary non tradisce, non c’è il libro. Non abbiamo niente». Quindi, perché esiste l’adulterio? Forse è una cosa orribile, ma Dio l’ha creata per i romanzi, così gli scrittori possono avere una storia. Solo che gli studenti non trovano divertente questa affermazione — soprattutto in America.
E in Long Island c’è Tony, e il suo tradimento è ciò che scatena la reazione di Eilis.
Esatto. Sono cose che accadono. E se non accadono in un romanzo, non accade niente. Se scrivi: «Era felicemente sposata, si alzò la mattina dopo, era ancora felicemente sposata, preparò la colazione, uscì, tornò, lui la baciò, lei disse: “Che bello vederti” e lui: “Che bello vederti anche per me”», non è un romanzo, è noia. E allora Dio deve intervenire per far scorrere la storia.
Enniscorthy è la cittadina irlandese dove sei nato e dove hai vissuto fino al 1976, l’anno esatto in cui si svolgono i fatti raccontati in Long Island. Come hai scritto in un bellissimo saggio su Enniscorthy, i lettori hanno l’impressione di osservare ciò che accade dalla finestra, mentre girano le pagine. Hai mai avuto delle reazioni da parte degli abitanti della città su come la descrivi nei tuoi libri?
Sì, assolutamente. Mai avuto problemi. Credo che gli scrittori irlandesi abbiano avuto qualche difficoltà in passato — negli anni ’50, all’inizio degli anni ’60. Edna O’Brien, per esempio, o John McGahern. Scrivevano da una prospettiva locale e questo creava tensioni. Ma le cose sono cambiate. Anzi, ormai è quasi il contrario: tutti sono molto gentili.

Due i titoli Einaudi presenti nei dodici selezionati tra i dodici candidati al Premio Strega Poesia 2025: L'intravisto di Elisa Biagini e Il brusío di Tiziano Rossi.
L’intravisto è ciò che osserviamo con difficoltà, per frammenti, «con l’occhio appoggiato alla crepa». Un impedimento che nei versi di Elisa Biagini diventa una forza per conoscere meglio se stessi e l’altro da sé, uno sguardo obliquo che apre orizzonti in cui situare i ricordi.
«Un libro intrigante e profondo, con un modo tutto proprio di sviluppare certi temi, certe attitudini apparentemente familiari ai lettori di Biagini – soprattutto in Da una crepa, 2014 e in Filamenti, 2020 – ma che ora assumono una sorta di forma concentrica e avvolgente, che porta chi legge direttamente al centro del qui, del luogo e del suo mistero: rarefatto, a volte, e paradossalmente così concreto, così fisicamente tangibile da prendere la forma di un materiale ruvido, che raschia dolorosamente la superficie di lettura».
Stefano Colangelo, «il manifesto»
Nei versi di Tiziano Rossi il lettore troverà la consueta passione dell’autore per la varietà del mondo e molti dei motivi presenti nelle raccolte precedenti: ricordi familiari «emersi dall’oceano dei possibili», la «porcheria mondiale» della guerra, frammenti di vita condominiale e istantanee di città, i giochi e le fantasie dei bambini, immersi in un tempo senza misura ma pieno di futuro.
«Rossi, che è nato a Milano nel 1935, ha scritto queste poesie giusto sulla soglia dei novant'anni, e però con una voce fresca e reattiva, persino frizzante. […] Cordialità, affabilità, gentilezza, capacità di comprensione, benevolenza: sembra che Rossi abbia posto un cuscino di raziocinio e di salutare buon senso tra sé stesso e gli accadimenti della propria esistenza, così che anche i ricordi più crudi e dolorosi (nella prima sezione del libro troviamo ad esempio il poeta bambino nel tempo di guerra), o viceversa quelli più toccanti e coinvolgenti (come soprattutto le immagini dei propri cari), non comportano rispettivamente né il senso di una tragedia senza ritorno né lo scivolamento nel sentimentalismo o nella nostalgia».
Roberto Galaverni, «La Lettura – Corriere della Sera»
Qui tutti i libri candidati.

Abbiamo incontrato Paul Murray a Firenze, in occasione della presentazione a Testo de Il giorno dell’ape, il suo nuovo romanzo appena uscito in Einaudi Stile Libero. Prossimamente pubblicheremo anche il secondo romanzo dell’autore irlandese, Skippy muore, uscito la prima volta in Italia nel 2010 per Isbn Edizioni.
«Ma qui per me i giorni migliori sono quando tremo di paura». Il romanzo si apre con un’epigrafe dal Sonetto sacro XIX di John Donne, una poesia sull’incostanza della fede. Ne Il giorno dell’ape, vediamo i personaggi lottare con il senso di colpa, il destino e la redenzione personale, temi con forti connotazioni religiose. Vedi il tuo romanzo come un’opera che affronta idee religiose, in particolare legate al cattolicesimo?
Non credo, almeno non direttamente. A volte, quando ripenso al libro, mi sorprende che ci sia così poca religione. Certo, fino a poco tempo fa l’Irlanda era un luogo fortemente religioso, ma la maggior parte dei personaggi del libro, anche quando le cose gli vanno molto male, non sembra percepire una forza superiore a cui rivolgersi. Sì, c’è un’occasione degna di nota in cui il piccolo PJ prega, ma per il resto, anche quando vanno in chiesa, non credono davvero che qualcosa possa aiutarli, e questo li mette in una situazione difficile. Avevo un’altra epigrafe che volevo usare, presa da John Berger: diceva più o meno così: «Quello che non capivo da giovane è che il passato non scompare, ma si raccoglie intorno a te come una placenta per il morente». Trovo che sia davvero bella. Ma il mio editor pensava che fosse troppo deprimente per il libro. Così ho scelto John Donne, che in fondo dice che quando le cose vanno malissimo, almeno sai di essere vivo. Sei scosso dalla paura, ma almeno sei consapevole della tua esistenza. Invece nei giorni normali sei in una sorta di torpore e non presti davvero attenzione al tempo che passa. I personaggi del libro sono sottoposti a uno stress enorme: tutto ciò in cui credono, tutto ciò che li lega gli uni agli altri e al mondo viene messo in discussione. E così si arriva all’essenza di ciò che sono, nel bene e nel male.
La tradizione dei Sidhe appare sia in Skippy muore che ne Il giorno dell’ape, ma in modi diversi: nel primo confonde i piani della realtà nella scuola in cui è ambientato, mentre nel secondo assume una presenza più cupa e fatalista. Cosa ti attrae di questo aspetto del folklore irlandese e come vedi il suo ruolo cambiare tra questi due romanzi? Pensi che miti come questo influenzino ancora la vita irlandese contemporanea?
I Sidhe, o - se volete - le fate, sono una superstizione molto antica, ma non sono creature graziose e svolazzanti con vestiti eleganti. Sono esseri piuttosto sinistri, il cui mondo si sovrappone al nostro. Il loro mondo e il nostro occupano lo stesso spazio, ma di solito non possiamo vederli. Tuttavia, ci sono punti nel nostro mondo in cui i due piani si toccano: in Irlanda potrebbero essere per esempio un albero o una collina, e lì è più probabile incontrare i Sidhe. Ed è pericoloso, perché sono capricciosi e piuttosto crudeli: potrebbero maledirti, ucciderti le mucche, rubarti il bambino o girarti le orecchie al contrario, cose del genere. Non sono una persona superstiziosa, non credo a queste cose, ma trovo affascinante l’idea di un mondo dentro al nostro, un mondo che a volte lavora contro di noi, altre volte è semplicemente indifferente, ma è sempre lì. Viviamo in un’epoca in cui ci dicono continuamente che tutto è stato capito: gli scienziati, gli economisti e i grandi della tecnologia con i loro computer hanno risolto il problema dell’esistenza. Ma è bello avere una superstizione che ci ricordi che non esiste una soluzione all’esistenza, che non è qualcosa che si può «risolvere». E proprio quando pensi che tutto stia andando alla grande, qualcuno ti gira le orecchie al contrario.
Nei due libri, la stessa storia appare in forme diverse. Facendo ricerche sul folklore irlandese per Skippy muore, ho usato i Sidhe per evidenziare come il passato, ovunque, continui sempre a influenzare il presente. In Irlanda, però, questo concetto si manifesta fisicamente nelle tombe disseminate ovunque nel paesaggio, i tumuli neolitici. Newgrange è il più famoso, ma ce ne sono ovunque. Sono il mondo sotterraneo, quello dei morti. Tendiamo a cancellare la morte dalla nostra vita quotidiana, ci piace considerarci esseri superiori con i nostri telefoni, ma il paesaggio irlandese ci ricorda costantemente che il passato è reale. E questo significa che la morte è reale. Un giorno saremo tutti in una tomba, giusto? Quindi, i Sidhe offrono ai ragazzi nel libro una via di fuga, suppongo. Forse non funziona davvero, ma sembra dare loro un’opportunità per sfuggire a un certo tipo di indottrinamento sulla realtà aziendale a cui sono sottoposti a scuola.
 Ne Il giorno dell’ape il concetto è più esplicito. La storia dei Sidhe racconta di un viaggiatore che si addormenta su una collina magica. Quando si risveglia, entra dentro la collina e si ritrova in mezzo a persone bellissime, con capelli dorati e gioielli sfarzosi, che stanno banchettando in una festa sontuosa. Gli offrono cibo e bevande, fanciulle danzano per lui, e tutto sembra andare magnificamente. Ma poi, il giorno dopo, si risveglia di nuovo sulla collina. Tutto è sparito, svanito nel nulla. Per Imelda, questo diventa un monito, perché lei viene da un ambiente povero, ma incontra questa famiglia ricca. Conosce un ragazzo molto benestante, Frank, il figlio di un concessionario d’auto. Ai suoi occhi, sembrano possedere una ricchezza infinita. Viene attratta in questo mondo, dove le sembra che tutti i suoi problemi possano semplicemente svanire. Per persone come loro, quelle cose non sono nemmeno problemi. Ma poi succede la stessa cosa. Il destino interviene, e tutto scompare. Si risveglia, e non le è rimasto più nulla.
Ne Il giorno dell’ape il concetto è più esplicito. La storia dei Sidhe racconta di un viaggiatore che si addormenta su una collina magica. Quando si risveglia, entra dentro la collina e si ritrova in mezzo a persone bellissime, con capelli dorati e gioielli sfarzosi, che stanno banchettando in una festa sontuosa. Gli offrono cibo e bevande, fanciulle danzano per lui, e tutto sembra andare magnificamente. Ma poi, il giorno dopo, si risveglia di nuovo sulla collina. Tutto è sparito, svanito nel nulla. Per Imelda, questo diventa un monito, perché lei viene da un ambiente povero, ma incontra questa famiglia ricca. Conosce un ragazzo molto benestante, Frank, il figlio di un concessionario d’auto. Ai suoi occhi, sembrano possedere una ricchezza infinita. Viene attratta in questo mondo, dove le sembra che tutti i suoi problemi possano semplicemente svanire. Per persone come loro, quelle cose non sono nemmeno problemi. Ma poi succede la stessa cosa. Il destino interviene, e tutto scompare. Si risveglia, e non le è rimasto più nulla.
All’inizio de Il giorno dell’ape, Miss Grehan dice a Cass che la poesia «fa l’opposto di fingere» e può essere liberatoria. Nel romanzo, la poesia gioca un ruolo silenzioso ma significativo, soprattutto in contrasto con le illusioni dei vari personaggi. Vedi la poesia come un antidoto al rifiuto della realtà nel libro? E, più in generale, pensi che la poesia abbia ancora il potere di dire la verità nella vita contemporanea?
Sì, nel libro Miss Grehan dice che il mondo sarebbe un posto migliore se tutti, una volta al giorno, invece di guardare il telefono leggessero una poesia. In realtà, anche solo se lo facessi io stesso. Vorrei riuscirci. Vorrei avere la disciplina per farlo. Ma sì, credo che il punto sia questo: siccome oggi abbiamo così tante possibilità di scegliere dove rivolgere l’attenzione, non ci rendiamo conto di come si tratti di una scelta illusoria. In realtà, guardiamo sempre le stesse cazzate. E se leggi una poesia, invece, è tutto un altro ordine espressivo, in cui qualcuno scava dentro di sé. La poetessa citata nel libro è Sylvia Plath, ma nei miei romanzi c’è quasi sempre un poeta: nel primo era Yeats, in Skippy muore Robert Graves. Penso che esistano altri modi di vedere il mondo, altri modi di vivere che possono liberarci dalle svariate luccicanti prigioni in cui ci chiudiamo da soli. Sì, ovviamente oggi è un lavoro difficile essere poeti, ma bisogna continuare a crederci.
La domanda sorge spontanea: tu scrivi poesie?
Circa una volta all'anno scrivo una poesia molto brutta. Non ci riesco, no, proprio no. Non riesco nemmeno a scrivere testi per canzoni. Quando ero in una band e provavo a scrivere canzoni mi chiedevo: ma come si fa a scrivere i testi? Ho bisogno di una storia. Posso creare immagini e collegarle a emozioni, ma deve esserci uno sfondo narrativo.
Ne Il giorno dell’ape c’è un passaggio che sembra quasi un non sequitur:
«Il romanzo è stato il primo esempio di quel che sarebbe poi diventata la vasta e tentacolare industria dell’intrattenimento nel XXI secolo, una macchina pressoché infinita progettata per distrarci e indebolirci. Ci viene presentato un mondo virtuale, alimentato in tutto e per tutto dall’incenerimento del reale». Questa frase ha sorpreso Sandro Veronesi che, pur definendo Il giorno dell’ape uno dei migliori romanzi di questo secolo, si è chiesto come mai un’argomentazione spesso usata per screditare il romanzo comparisse in un libro che in realtà dimostra l’esatto contrario. E così si risponde da solo: «Il romanzo è onnivoro ed è nato con anticorpi pronti a resistere a questo tipo di attacchi e persino a nutrirsene».
Perché hai incluso questo passaggio e cosa pensi dell’interpretazione di Veronesi?
Beh, arrivati all’ultima parte del libro, in cui ci sono parecchie scene con Cass all’università, lei ha quest’insegnante molto affascinante e intelligente di nome jj. Nella prima bozza del romanzo, jj aveva molto più spazio e teneva una lunga lezione, ispirata a un mio professore del college che ci disse che un libro non è diverso da una rivista o da una pubblicità di carta igienica, che erano solo parole. Voleva scioccarci con questa visione piuttosto nichilista del romanzo, che io trovai davvero offensiva. Nella prima stesura, quel passaggio che hai citato riguardava più il tema del genere, perché il romanzo, come forma d’arte, fu inventato per essere letto dalle donne. Nel diciottesimo secolo, le donne della classe media rimanevano a casa e i mariti si preoccupavano di cosa avrebbero fatto tutto il giorno senza un lavoro. Così il romanzo divenne un passatempo coinvolgente, un’arte destinata a persone escluse dal potere, offerta loro come intrattenimento.
Oggi non parliamo più delle donne del Settecento, ma abbiamo un milione di ore di Netflix, e intanto sembra quasi che non abbia più importanza per chi votiamo. I miei editor a un certo punto mi hanno detto che ero vicino alla fine del libro e che dovevo far scorrere la narrazione più velocemente, e mi hanno suggerito di tagliare alcune parti. Ma quel passaggio lo volevo proprio tenere. Credo che ogni scrittore del XXI secolo s’interroghi su qual è il senso della scrittura. C’è un diluvio di oscurità nichilista che ci assale continuamente, e finisci per domandarti: «Perché sto facendo tutto questo?» C’è una scena in cui Cass segue un corso di poesia e tutte le poesie che leggono sono nello stile di Seamus Heaney: parlano di more, cigni, querce e così via — tutte cose che, nel frattempo, vengono abbattute e sterminate senza sosta. Ma le poesie non ne parlano, e così lei pensa che i poeti siano bugiardi. Volevo che il libro riconoscesse la situazione in cui ci troviamo: la nostra vita quotidiana si basa sulla distruzione della natura. Questo è un fatto. Non è un proclama politico o un discorso da comizio, è un dato scientifico. La visione nichilista del romanzo è un veleno che ci viene costantemente somministrato, goccia a goccia. Se leggi qualsiasi cosa dica Elon Musk, o l’intero progetto dell’intelligenza artificiale, il messaggio è lo stesso: non c’è nulla di speciale o autentico nell’espressione e nella comunicazione umane. Sono solo parole prive di significato, e un computer potrebbe farlo gratuitamente. Credo che i lettori debbano interpretare il significato del passaggio per conto loro, ma per me il senso era questo.
Quindi volevi lasciare il lettore perplesso?
Beh, Cass è esposta a tutti questi discorsi, ma alla fine del libro riesce a pubblicare una sua poesia sulla rivista dell’università. Questo significa che non ha accettato quel ragionamento. Non crede che la scrittura sia solo intrattenimento. Pensa che scrivere una poesia abbia comunque un valore, anche se è la cosa più insignificante che si possa fare. È come lanciare un sassolino contro un missile nucleare. È una cosa minuscola, ma allo stesso tempo, per un po', le dà senso alla vita.


Dopo Spatriati, vincitore del Premio Strega 2022, Mario Desiati è tornato nelle librerie con Malbianco, il romanzo più lirico, inquieto, ambizioso e maturo dell’autore. Un libro che scava nel rapporto tra l’individuo e le proprie radici e interroga con coraggio il trauma, la vergogna e il rimosso collettivo del nostro Paese.
La storia segue Marco Petrovici, un quarantenne che vive a Berlino e che, a causa di improvvisi svenimenti, decide di tornare in Puglia dai genitori anziani. Ma il suo non è un semplice ritorno: scavando nel passato famigliare, tra le figure della bisnonna Addolorata, del nonno Demetrio e del prozio Vladimiro, Marco si trova a riscoprire una memoria sepolta, che lo conduce dai boschi di Taranto fino ai campi di prigionia tedeschi.
Se in Spatriati il protagonista Francesco cerca un nuovo sé tramite l’allontanamento dalla terra d’origine, in Malbianco Marco lo fa tornandoci. A sottolinearlo è proprio l’autore sulle pagine dell’Espresso: «Questo libro sabota l’idea del ritorno: quindi sì, c'è un viaggio la cui direzione è la terra d'origine però, a differenza di quanto si possa pensare, questa non è la storia dello spatriato che torna a casa. Marco sente la necessità di staccarsi, di prendere il largo, ma per farlo ha bisogno di conoscere, di una consapevolezza maggiore: per essere libero e intraprendere la strada che crede sia la più giusta deve prima comprendere ciò da cui si sta sottraendo».
Il romanzo, dunque, non è solo un’indagine sulle proprie radici, ma anche una profonda riflessione sulla libertà e sulla necessità di fare i conti con il proprio passato.
«A un romanzo che, dopo averlo letto, scelgo di custodire sui ripiani sempre più stipati della mia libreria chiedo almeno una di queste virtù: che sia scritto molto bene, che racconti una storia che mi appassiona, e che questa sia intima ma universale. Malbianco di Mario Desiati le possiede tutt’e tre».
Vittorio Lingiardi, «la Repubblica»
«Se è vero, come è vero, che le storie esistono già prima di noi e che tutto sta, più che nel raccontarle, nel saperle raccogliere, questa qui è stata afferrata dalla mano giusta. Perché Desiati è uno scrittore di carte scoperte, di cose da rivelarsi sempre e comunque, indipendentemente dalla loro stranezza o sconvenienza. Nei suoi romanzi i segreti non esistono, e se esistono non durano, e se durano sono veleno, bisogna allontanarsene, salvarsi».
Nicola H. Cosentino, «Corriere della Sera»
«Un romanzo dove una storia di famiglia in cui ovviamente tu, lettore o lettrice, non c'entri nulla perché non è la tua, ma che a un certo punto del libro (e quel punto lo deciderai tu, lettrice o lettore) ti chiama dentro, prova a dirti che – guarda, potrebbe essere anche la tua, di storia. E forse lo è».
Elena Loewenthal, «tuttolibri – La Stampa»
«Un romanzo bellissimo […] Desiati, attraverso i suoi personaggi, intraprende questo viaggio à rebours con tenerezza e pudore facendoci scoprire una famiglia incredibile e piena di misteri. Il romanzo è una cornucopia di storie e paesaggi sepolti nella memoria che tornano a vivere grazie all'incanto della scrittura».
Serena Dandini, «Io Donna»
«Il romanzo ha due velocità, quella dell’asino e quella delle rondini. C'è grande dolcezza e capacità di carico, tipici dell’animale che non ascolta con le grandi orecchie ma con i dolcissimi occhi; e poi c’è la velocità nervosa, rotta e dura, a tratti amara, degli uccelli dal volo acrobatico nelle fughe che intrecciano traiettorie aeree – e secondo alcune leggende portano le anime dei morti di cui bisogna indovinare il nome, come fa il nonno del protagonista, in una delle scene più liriche del romanzo, quando con la barca raggiunge una del le piccole isole di fronte al golfo di Taranto».
Luca Mastrantonio - «7 – Corriere della Sera»
«Il protagonista di questo romanzo, che cosa ha in comune con me? I tentennamenti, la tenerezza, l’avventatezza, il corpo che gli dice che deve essere più coraggioso per smettere di tremare».
Chiara Valerio, link
«Malbianco di Mario Desiati è un romanzo storico e psicologico di rilievo. Attraverso il racconto dell'io narrante Marco Petrovici, Desiati matura un’intensa riflessione su temi ed eventi decisivi del Novecento […] un esemplare ritratto individuale e collettivo che spazia dalla Puglia e dall’Italia all’Europa, coniugando geografia e storia, prospettive professionali e sentimentali, nel tenace tentativo di uscire dalle gabbie esistenziali della vita “agra” di Bianciardi e della “mediocrità” di Flaiano».
Gino Ruozzi, «Domenica – Il Sole 24 Ore»
«Mario Desiati scrive un romanzo potente dove tutto converge verso un’epica senza esclusioni di colpi tra i non detti di una famiglia e la libertà del virgulto più sensibile».
Marina Valensise, «Il Messaggero»

L’uscita de Il giorno dell’ape di Paul Murray in Italia è stata accompagnata da grandi aspettative, alimentate dallo straordinario successo ottenuto a livello internazionale. Libro dell’anno per «The New York Times», «The Guardian», «The Washington Post», «The New Yorker» e «The Economist», finalista al Booker Prize e acclamato da critici e scrittori di fama mondiale, il romanzo è stato accolto come un capolavoro. Bret Easton Ellis lo ha definito «la più bella lettura dell’anno», mentre il «Times» lo ha paragonato a un classico moderno come Le correzioni di Jonathan Franzen.
E anche in Italia Il giorno dell’ape non ha tradito le attese. I lettori lo hanno accolto con entusiasmo, così come importanti firme della letteratura contemporanea. Roberto Saviano lo ha descritto come «un’apocalisse quotidiana: non ci sono fiamme ma tormenti, apparentemente leggeri. Una puntura che arriva all’improvviso». Sandro Veronesi, nella sua appassionata recensione su «La Lettura», ha ribadito la forza del libro di Murray, definendolo «uno tra i più importanti romanzi scritti in questo primo quarto di secolo».
Al centro della storia ci sono i Barnes, una famiglia sull’orlo del disastro. Dickie, il padre, un tempo brillante imprenditore, passa le giornate a costruire un bunker invece di affrontare la crisi della sua concessionaria. Imelda, la moglie, cerca di salvare le apparenze vendendo di nascosto i suoi gioielli su eBay. Cass, la figlia adolescente, ex studentessa modello, sembra voler sabotare il proprio futuro mentre il dodicenne PJ sta progettando di scappare di casa. Ma cosa è andato storto per i Barnes? Con umorismo, profondità e una scrittura straordinaria, Paul Murray dipinge un ritratto familiare vivido e commovente, intrecciando desideri, solitudini e rovine con un’irresistibile capacità narrativa.
Il giorno dell’ape è un’esperienza letteraria destinata a lasciare il segno.
«Per la qualità e la mutevolezza della lingua l’unico modello possibile per Il giorno dell’ape sono le pagine più felici della Tetralogia di Harry «Coniglio» Angstrom di John Updike».
Luca Briasco, «Alias – il manifesto»
«Le pagine de Il giorno dell’ape brulicano di vita, rabbia, amore. Se poggi le mani sulle parole, si staccano dalla carta e diventano vere. Che magia».
Antonella Lattanzi
«È un romanzo notevole e pervasivo. Un grande romanzo europeo. Gli americani l’avrebbero impalmato cerimoniosamente, se fosse stato loro: siamo nel territorio di Le correzioni di Franzen, per l’architettura e i trambusti familiari, ma c’è la giocosa capacità di proiettare l’umanità nell’immediato futuro partendo dalla tragicità del presente».
Leonardo G. Luccone, «la Repubblica»
«I figli riempiono il silenzio degli adulti. Sanno tutto e sentono tutto. Come Paul Murray».
Greta Olivo
«[…] Murray cuce una voce diversa e distinta per ognuno e il lettore segue le loro lotte interiori, tra bellezza e brutalità, scelte sbagliate e prove di redenzione, disorientamento e speranza. Le api difendono se stesse e la propria colonia anche a costo della morte, lo faranno fino a che non le costringeremo all’estinzione. E i Barnes, come si proteggeranno?»
Carlotta Vissani, «il Fatto Quotidiano»
«Un incipit fulminante, nella migliore tradizione novecentesca. […] Un autore che è stato una grande promessa e con questo romanzo diventa una grande certezza. Congegno narrativo, linguaggio di centratissimo equilibrio tragicomico, profondità di sguardo nell’analisi sociale sembrano la formula del successo di II giorno dell'ape».
Stefania Vitulli, «il Giornale»