
La Malnata è il primo romanzo di Beatrice Salvioni, già vincitrice nel 2021 del Premio Calvino racconti. È la storia di due ragazzine molto diverse tra loro e di un’amicizia indimenticabile nell'Italia del fascismo.
Il libro è diventato fin da subito un caso letterario e ha incantato gli editori di tutto il mondo: l’edizione italiana è uscita in concomitanza a quella francese, spagnola, bulgara, olandese, slovacca, romena e svedese. Attualmente è tradotto, o in corso di traduzione, in più di 30 lingue e arriverà anche negli Stati Uniti e in Germania.
Monza, marzo 1936: sulla riva del Lambro, due ragazzine cercano di nascondere il cadavere di un uomo che ha appuntata sulla camicia una spilla con il fascio e il tricolore. Sono sconvolte e semisvestite. È Francesca a raccontare in prima persona la storia che le ha condotte fino a lì. Dodicenne perbene di famiglia borghese, ogni giorno spia dal ponte una ragazza che gioca assieme ai maschi nel fiume, con i piedi nudi e la gonna sollevata, le gambe graffiate e sporche di fango. Sogna di diventare sua amica, nonostante tutti in città la considerino una che scaglia maledizioni, e la disprezzino chiamandola Malnata. Ma quella sua aria decisa, l’aria di una che non ha paura di niente, la affascina. Sarà il furto delle ciliegie, la sua prima bugia, a farle diventare amiche. Sullo sfondo della guerra di Abissinia, del dolore per la perdita e degli scompigli dell’adolescenza, Francesca impara con lei a denunciare la sopraffazione e l’abuso di potere, soprattutto quello maschile, nonostante la riprovazione della comunità.
La Malnata è un coinvolgente romanzo di formazione che sta conquistando anche il pubblico italiano e la critica:
«La protagonista “nata male”, che vediamo muoversi anzi scatenarsi nel racconto, è una minuscola incarnazione dell’inferno. Una di quelle scomode presenze che nel Medioevo verrebbero piazzate sul rogo […] Maddalena è un personaggio solido e caldo, che emerge dalle pagine con un respiro quasi percepibile in maniera concreta».
Leonetta Bentivoglio, «la Repubblica»
«La Malnata è, come L'amica geniale, un Bildungsroman e un inno all'amicizia e al suo potere dirompente».
Valentina Berengo, «Il Foglio»
«La Malnata, questo romanzo potente, crudele, scritto con una maestria che ha del vertiginoso, ci racconta cose serissime, mostrandoci il mondo degli adulti attraverso gli occhi neri di una ragazzina, piccoli e duri come una pietra scagliata contro il nemico».
Cristina De Stefano, «Elle»
«Ha un incipit sconvolgente ed è una storia di formazione e di amicizia che non risparmia il dolore e non nasconde le debolezze, la paura di schierarsi dalla parte di chi crede di essere il prescelto e perciò nel giusto. Francesca tentenna tra la libertà e la conformità, tra i pregiudizi della società che l'accoglie ma che poi le volta le spalle quando decide di scegliere la strada che ritiene giusta: l'amicizia al fianco della Malnata».
Isabella Fava, «Donna Moderna»
«La giovane scrittrice costruisce con voce inedita e convincente una vicenda di formazione personale e civile, dà vita a un affresco di personaggi dai toni chiaroscuri e a un ben oliato congegno narrativo, connotato da una scrittura affilata e dall'efficacia dei dialoghi».
Marzia Fontana, «Corriere della Sera»
«Attraverso le due amiche l'autrice racconta un popolo succube, un'Italia percorsa da grandi ambizioni ma con modesti risultati e brucianti sfaceli».
Francesco Mannoni, «Il Mattino»
«La Malnata, opera prima di Beatrice Salvioni, è tanti romanzi insieme. È la storia di un'amicizia tra due bambine che stanno per diventare donne, anzi femmine; è il racconto di uno spaccato sociale e politico dell’Italia degli anni Trenta in cui la violenza è alimentata dall'ipocrisia, quella dei piccoli paesi in cui dicerie e pregiudizi sono fonti di informazione qualificate. Ma è soprattutto un’indagine condotta sulle apparenze. Un “reportage”, in narrativa, su un pezzo della nostra storia che andrebbe dimenticato e raccontato allo stesso tempo, per quanto fa male, per quanto è necessario».
Marco Onnembo, «Domenica – Il Sole 24 Ore»
«Un romanzo potente che comincia con uno stupro sul greto del fiume e racconta la difficoltà di essere donna in un mondo sessista, ma anche come un’amicizia aiuti a opporsi all’ingiustizia. L’autrice, diplomata alla scuola Holden, ha una potente vocazione al racconto e nel 2021 ha vinto il Premio Calvino».
Brunella Schisa, «il venerdì – la Repubblica»
«È una storia vicina, ambientata in un fatto lontano ma irrisolto, quindi sempre presente: il fascismo. Salvioni ha usato il fascismo per vedere meglio il presente».
Simonetta Sciandivasci, «La Stampa»
«Questo romanzo si fa voler bene e Maddalena entra nella testa della gente per non uscirne più, come dice uno dei personaggi».
Carlotta Vissani, «il Fatto Quotidiano»

Ci sono cose che non si raccontano perché le parole sono scogli nel mare. Ci sono cose che non si raccontano per vergogna, rabbia, troppo dolore, e perché se non le racconti, in fondo puoi sempre credere che non siano successe. Antonella e Andrea vogliono un figlio: adesso lo vogliono proprio, lo vogliono assolutamente. Ma è come se non ci fosse niente di semplice, nel desiderio più naturale del mondo: tutto ciò che può andare storto andrà storto, anche l'inimmaginabile.
Antonella Lattanzi ha trovato parole esatte per questa storia, che è sua e di tutte le donne - ambiziose, indecise, testarde, libere di scegliere. Un libro emozionante, che non si riesce a smettere di leggere, straordinariamente contemporaneo.
Il libro, uscito il 14 marzo nei Supercoralli, è stato subito accolto calorosamente dalla critica e dal mondo letterario:
«Antonella Lattanzi è una di quelle rare scrittrici che aiutano i maschi a intuire i segreti dell'anima femminile, del desiderio di maternità e del miracolo della riproduzione. Per farlo usa solo la verità, il talento e la lucida spietatezza di chi non teme nessuno».
Niccolò Ammaniti
«La scrittura di Lattanzi ha un ritmo trascinante e feroce, prende per mano il lettore e lo conduce nel suo mondo senza concedergli tregua. La spudoratezza del racconto personale è affiancata in ogni momento da uno stile magnetico che dona forza al magma delle azioni e dei pensieri della protagonista… Cose che non si raccontano è uno di quei libri che si scrive una volta nella vita ed è la conferma di una ottima scrittrice italiana».
Rossano Astremo, «il manifesto»
«Questo non è solo un romanzo: è un pezzo incandescente di vita. Vita nuda, cruda, vera, che ti afferra alla gola e ti toglie tutte le parole. Antonella Lattanzi le ha trovate, con immenso coraggio, con forza straordinaria, e le ha donate a tutti noi».
Silvia Avallone
«Lattanzi assalta il cuore e il cervello con un romanzo sul segreto indicibile di essere una donna che nasconde, rivela, soffre e scrive. E desidera. Quanto desidera! E quanto desidero anche io, grazie a questa donna, insieme a lei e alle sue cose che non si raccontano».
Annalena Benini
«Romanzo necessario e potente, vero e brutalmente onesto, sul desiderio di un figlio che non viene, sulle rotte che prendono certe esistenze, sul dolore di una donna che può essere di tante. Anzi, di tutte».
Chiara Oltolini, «Vanity Fair»
«L'autrice gestisce questa sua materia – gli eventi – in modo naturale ma anche con un forte elemento di thriller, un po' Stephen King ma soprattutto Shirley Jackson, senza bisogno di fare ricorso al soprannaturale».
Raffaella Silvestri, «Domani»
«Letto con l'unico sguardo di cui sono capace, quello maschile, il libro mi è sembrato insopportabile, imprescindibile, straordinario».
Domenico Starnone, «Corriere della Sera»
«Una storia di dolore fisico e mentale che pulsa in ogni rigo e che (cosa magnifica) sprigiona coraggio senza promettere lieto fine… Cose che non si raccontano è un bellissimo libro».
Bruno Ventavoli, «tuttolibri – La Stampa»

Dal 28 marzo saranno disponibili, esclusivamente in eBook e al prezzo di 2,99 euro, i primi tre titoli della nuova collana «Criminali» di Einaudi Stile Libero.
Curata da Beniamino Vignola, raccoglierà storie vere, forti, a volte crude, veicolate attraverso cronache, reportage, biografie, atti processuali, racconti e romanzi brevi.
Sono testi agili che non superano le 100 pagine; opere spesso frutto di ricerche pazienti negli archivi o ingegnose invenzioni d'autore, che giocano tra il vero autentico pulp storico e la memorialistica a volte morbosa.
Ecco le prime tre uscite:
Havelock Ellis, Tipi criminali
Attraverso testimonianze, citazioni e lettere, Ellis ci offre un compendio ricco e dettagliato dei principali risultati dell’antropologia criminale. Una pietra miliare in un campo che, verso la fine dell'Ottocento, era ancora poco esplorato.
Anna Katharine Green, Il dottore, sua moglie e l’orologio
Un uomo ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua stanza e un assassino scomparso nella notte senza lasciare tracce. A indagare sul delitto è Violet Strange, la prima donna detective nella storia del mystery. Un racconto dell'autrice americana che rese popolare il genere poliziesco con un decennio di anticipo su Conan Doyle e diventò un modello per molti scrittori a venire.
Eddie Guerin, Rapina all'American Express
Il resoconto autobiografico (da parte di uno che di mestiere faceva il ladro e non lo scrittore) di una sensazionale rapina all’American Express nei primi anni del Novecento, nonché della vita all’Île du Diable, dove Guerin fu deportato dai francesi quando lo pizzicarono e lo condannarono all'ergastolo, e della successiva, ancor più clamorosa fuga dal carcere.
Dopo questi primi tre lavori, seguiranno:
- Anna Katharine Green, La pagina tredici manca
- Mastro Titta, il boia di Roma. Memorie di un carnefice scritte da lui stesso
- Chas Siringo, Billy the Kid. La sua storia
- Vite da briganti. Gasparone, Musolino, Tiburzi
- Allan Pinkerton, Il borseggiatore. Lezioni sull'iniziazione di un criminale professionista
- Harry Houdini, Il modo giusto di fare le cose sbagliate
-
«Criminali», di Einaudi Stile Libero, curata da Beniamino Vignola, raccoglierà storie vere, forti, a volte crude, veicolate attraverso cronache, reportage, biografie, atti processuali, racconti, romanzi brevi. Testi agili, svelti, che non superano le 100 pagine; opere spesso frutto di ricerche pazienti negli archivi o ingegnose...pp. 78€ 2,99
-
Il dottore, sua moglie e l’orologio
«Criminali», di Einaudi Stile Libero, curata da Beniamino Vignola, raccoglierà storie vere, forti, a volte crude, veicolate attraverso cronache, reportage, biografie, atti processuali, racconti, romanzi brevi. Testi agili, svelti, che non superano le 100 pagine; opere spesso frutto di ricerche pazienti negli archivi o ingegnose...pp. 68€ 9,99 -
Rapina all’American Express
«Criminali», di Einaudi Stile Libero, curata da Beniamino Vignola, raccoglierà storie vere, forti, a volte crude, veicolate attraverso cronache, reportage, biografie, atti processuali, racconti, romanzi brevi. Testi agili, svelti, che non superano le 100 pagine; opere spesso frutto di ricerche pazienti negli archivi o ingegnose...pp. 90€ 9,99

Dal 24 febbraio al 26 marzo tutti gli Einaudi Tascabili costano il 20% in meno (ad esclusione dei titoli pubblicati dalla casa editrice nell'ultimo semestre in conformità all'art. 8 della legge 13 febbraio 2020 n. 15). Ecco alcuni dei titoli in promozione (qui, il catalogo completo).
-
4 3 2 1
«La cosa migliore che abbia mai fatto Auster, e una delle migliori uscite negli ultimi tempi, non solo in America. Che audacia, quale inventiva, quanta profumata carne al fuoco!»
Alessandro Pipernopp. 960€ 14,40€ 18,00 -
Resto qui
«Se per te questo posto ha un significato, se le strade e le montagne ti appartengono, non devi aver paura di restare».
«Una storia di sperdimento e di provvisorietà ben radicata nell'oggi. La letteratura resta qui, come il campanile di Curon».
«la Lettura - Corriere della...pp. 192€ 9,20€ 12,50 -
Il tempo di tornare a casa
Con la sua voce inconfondibile, Matteo Bussola racconta il nostro ostinato bisogno degli altri, malgrado la possibilità di ferirsi, di tradirsi, malgrado le accuse o i rimpianti. Il suo è un inno al potere salvifico delle storie, grazie alle quali ci sentiamo tutti meno soli.pp. 184€ 9,60€ 12,00 -
La misura del tempo
Un romanzo magistrale. Una scrittura inesorabile e piena di compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario - distillato purissimo della vicenda umana - e le note dolenti del tempo che trascorre e si consuma.
«Guerrieri è un personaggio meraviglioso».
«The Times»pp. 288€ 10,00€ 13,50 -
Il talento del cappellano
Un cadavere che scompare, poi riappare. Un duplice omicidio accompagnato da una macabra messinscena. Se poi una delle vittime è un prete, il caso diventa ancora piú spinoso per Vanina Guarrasi.pp. 320€ 10,40€ 13,00 -
Le otto montagne
La storia di Pietro, del suo amico Bruno e del loro amore per la montagna. Un caso editoriale internazionale.pp. 208€ 10,40€ 13,00 -
Queer
«Un libro avvincente, capace di toccare ogni registro dell'esperienza (e della scrittura): epico, tragico, comico, romantico».
Vittorio Lingiardi, «la Repubblica»pp. XII - 384€ 11,20€ 14,00 -
-
I fratelli Karamazov
Con Dostoevskij e il parricidio di Sigmund Freud.pp. XLVI - 1064€ 14,40€ 18,00 -
Una questione privata
«È difficile trovare, nella letteratura italiana degli ultimi cento anni, un romanzo in cui amore e guerra, giovinezza e morte si intrecciano in modo cosí magico».
Nicola Lagioiapp. XX - 206€ 9,60€ 12,00 -
Specchio delle mie brame
La bellezza oggi è qualcosa di ben preciso a cui adeguarsi: un certo modo di vestire, di mangiare, di parlare, di camminare. Non si tratta di una questione puramente estetica, ma di una tecnica politica di esercizio del potere. In altre parole, di una gabbia...pp. 184€ 11,20€ 14,00 -
Le non cose
Abbiamo perso il contatto con il reale. È necessario tornare a rivolgere lo sguardo alle cose concrete, modeste e quotidiane. Le sole capaci di starci a cuore e stabilizzare la vita umana.pp. 120€ 8,00€ 10,50 -
Se i gatti scomparissero dal mondo
Cosa sei disposto a dare al Diavolo per poter vivereun giorno in piú? Attento: ciò che il Diavolosceglierà di prendersi sparirà dal mondo, pertutti. I telefonini? Va bene. E i film, gli orologi...d'accordo, ma i gatti? Sei pronto a rinunciare aigatti?pp. 176€ 8,00€ 12,00 -
Trilogia della città di K.
«Una prosa di perfetta, innaturale secchezza, una prosa che ha l'andatura di una marionetta omicida».
Giorgio Manganellipp. 392€ 11,20€ 14,00 -
Il sistema periodico
«Tutto in questo libro è essenziale, meravigliosamente puro...»
Saul Bellowpp. 248€ 9,60€ 13,00 -
Tomás Nevinson
Una profonda riflessione sui limiti di ciò che è lecito fare, sulla macchia che quasi sempre accompagna la volontà di evitare il male peggiore, e soprattutto sulla difficoltà di determinare quale sarà quel male.pp. 624€ 12,80€ 16,00 -
La strada
«Ce la caveremo, vero, papà?
Sí. Ce la caveremo.
E non succederà niente di male.
Esatto.
Perché noi portiamo il fuoco.
Sí. Perché noi portiamo il fuoco».pp. 224€ 10,00€ 13,00 -
L’isola di Arturo
«Una piccola, criptica Achilleide resuscitata».
Cesare Garbolipp. XVIII - 416€ 10,80€ 14,00 -
Norwegian Wood. Tokyo Blues
Con una nota dell'autore.
***
«La costruzione della scrittura di Murakami è cosí impalpabile e squisitache ogni cosa egli scelga di descrivere vibra di potenzialità simbolica:una camicia stesa ad asciugare, dei ritagli di carta, un fermaglio aforma di farfalla».
«The Guardian»pp. XX - 408€ 11,60€ 14,50 -
Momenti trascurabili vol. 3
Dopo Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità è come se ormai Francesco Piccolo li avesse brevettati, i momenti di cui è fatta la vita: c'è qualcosa, nella qualità del suo sguardo, che dilata il tempo delle nostre giornate, imprestandoci la sua leggerezza...pp. 136€ 8,00€ 10,00 -
Persone normali
«Un grande romanzo su tutto ciò che abbiamo: gli esseri umani che si cercano, e si perdono».
Annalena Beninipp. 240€ 9,60€ 12,50 -
Il giovane Holden
In una nuova traduzione, il libro che ha sconvolto il corso della letteratura contemporanea influenzando l'immaginario collettivo e stilistico del Novecento.pp. 264€ 10,40€ 12,00 -
L’arte della gioia
«Il tempo lavorerà a favore dei libri di Goliarda Sapienza. E questo non è un augurio: è una convinzione».
Cesare Garbolipp. 552€ 12,80€ 16,00 -
Memorie di Adriano
«Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo», dice di sé Adriano, un personaggio cosí raffinatamente calato nella sua epoca, eppure cosí vicino al tormento di ogni uomo, di ogni tempo, nell'accanita ricerca di un accordo tra felicità e logica, tra intelligenza e fato.pp. 344€ 10,80€ 13,50
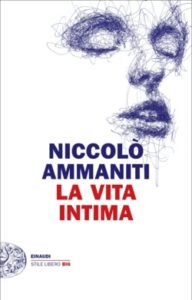
Maria Cristina Palma ha una vita all’apparenza perfetta, è bella, ricca, famosa, il mondo gira intorno a lei. Poi, un giorno, riceve sul cellulare un video che cambia tutto. Nel suo passato c’è un segreto con cui non ha fatto i conti. Come un moderno alienista Niccolò Ammaniti disseziona la mente di una donna, ne esplora le paure, le ossessioni, i desideri inconfessabili in un romanzo che unisce spericolata fantasia, realismo psicologico, senso del tragico e incanto del paradosso.
Dopo un’attesa di otto anni, periodo durante il quale l’autore ha scritto e diretto le serie Il miracolo (2018) e Anna (2021), Niccolò Ammaniti è ritornato più cattivo, divertente e romantico che mai. Critica e lettori hanno accolto con passione questo suo ultimo lavoro:
«Ammaniti possiede il dono più prezioso: l’originalità. La sua scrittura ti prende e ti porta via, dove solo lui può. Ti fa scoppiare a ridere, e alla pagina successiva ti spezza il cuore, restituendoti la complessità comica, drammatica, commovente di chi siamo».
Silvia Avallone, «7 - Corriere della Sera»
«Lo scrittore alterna momenti in cui si lascia guidare dal divertimento portando all’estremo situazioni e personaggi fino a farne esilaranti prototipi, a impennate emotive, commoventi, tradotte in rapidi tocchi descrittivi, spesso resi efficaci dalla metafora biologica, dallo sguardo lucido su tutto ciò che è natura, dal racconto del dolore umano attraverso il dolore animale».
Cristina Taglietti, «Corriere della Sera»
«Niccolò Ammaniti ci mostra con pazienza da entomologo quello che siamo diventati: l'ossessione per l'immagine pubblica, la politica capace solo di inseguire il consenso veloce e fortuito, le decisioni prese in base a intuizioni di presunti guru tecnologici, la difficoltà di fare quel che fa sentire bene davvero, l'inclinazione al sospetto e alla paranoia».
Annalisa Cuzzocrea, «La Stampa»
«Ammaniti mi manda in trance, quando leggo i suoi libri ciò che c'è intorno svanisce, la sua allucinazione si sostituisce al mio mondo. È successo puntualmente anche con La vita intima [...] Niccolò Ammaniti è un inventore di storie imbattibile. Le cura scrupolosamente a tutti i livelli. Prima di tutto, l'idea essenziale; poi l'articolazione della trama; e infine la scrittura narrativa, in tutta la sua vividezza. Leggerlo è una festa, le sue parole hanno il tocco magico, sanno quali pulsanti premere per suscitare immagini in chi legge».
Tiziano Scarpa, «Domani»
«La protagonista del romanzo è la moglie del presidente del Consiglio e di conseguenza, sullo sfondo della strepitosa autobiografia di una nazione che passa dal ritratto di questa donna che a tutti un poco somiglia, comprimario è lui: il marito. La vita di Palazzo, i consiglieri le Bestie i ricatti le trame, le ambizioni e le paure. Il Potere».
Concita De Gregorio, «la Repubblica»
«Niccolò Ammaniti riesce sempre a creare bellissime tempeste. L’ha fatto con tutti i suoi romanzi, in cui il riso, il pianto, la meraviglia, la commozione si mescolano e tracimano l’uno nell’altra senza soluzione di continuità, come se ogni romanzo fosse una serie di vasi che comunicano tra loro e con te e non smettono mai di lasciar fluire quello che hanno dentro, anche tanti anni dopo che li hai letti».
Antonella Lattanzi, «Il Foglio», link
«Dopo avere a lungo scandagliato l'universo degli adolescenti (con Io non ho paura, in primis), Ammaniti torna per focalizzarsi sulla personalità di una madre, circondata da personaggi sinceri o talvolta surreali. Come il Bruco, il potente social media manager, la figura più ipnotica di un libro che diventa un "manifesto dell'autenticità", in una società sempre più dominata dall'apparenza».
Pierluigi Spagnolo, «La Gazzetta dello Sport»
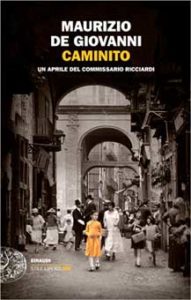
Caminito, il nuovo romanzo del maestro del giallo italiano Maurizio de Giovanni, segna il ritorno dell’amatissimo commissario Ricciardi. I lettori l’avevano incontrato l’ultima volta ne Il pianto dell’alba, uscito nel 2019, e in questi anni di assenza hanno potuto apprezzarne la trasposizione televisiva nella fiction Rai del 2021, diventata già un cult.
È il 1939, sono trascorsi cinque anni da quando l’esistenza di Ricciardi è stata improvvisamente sconvolta. E ora il vento d’odio che soffia sull’Europa rischia di spazzare via l’idea stessa di civiltà. Sull’orlo dell’abisso, l’unico punto fermo è il delitto. Fra i cespugli di un boschetto vengono ritrovati i cadaveri di due giovani, stavano facendo l’amore e qualcuno li ha brutalmente uccisi. Le ragioni dell’omicidio appaiono subito oscure; dietro il crimine si affaccia il fantasma della politica. Con l’aiuto del fidato Maione – in ansia per una questione di famiglia – Ricciardi dovrà a un tempo risolvere il caso e proteggere un caro amico che per amore della libertà rischia grosso. Intanto la figlia Marta cresce: ormai, per il commissario, è giunto il momento di scoprire se ha ereditato la sua dannazione, quella di vedere e sentire i morti.
«Caminito è più di un giallo. È un romanzo ricco di sorprese, trova energia nella profondità dell'anima letteraria dello scrittore napoletano. Un ritorno che danza in tre quarti, il tempo perfetto della musica nell'era classica. Le trame si intrecciano con ritmo impeccabile, per raccontare le pene e le speranze, sino a quando tutti i fili si ricompongono e cala il sipario».
Marco Zatterin, «tuttolibri - La Stampa»
«…Già da questi brevi accenni di trama si capisce che quello dell'indagine poliziesca è solo uno dei sentieri percorsi del romanzo. Le storie di Ricciardi non sono mai state solo casi da risolvere, ma un mondo dove tutto si muove assieme. E in questo romanzo del ritorno dell'amato commissario la dimensione corale è ancora più marcata. E proprio vero, non occorre chiedere il permesso per entrare nell'ufficio di Ricciardi. Neppure per sentirsi di casa tra storie e personaggi di de Giovanni».
Severino Colombo, «Corriere della Sera»
«Caminito è romanzo giallo, politico e d'amore, intriso della consueta umanità che De Giovanni sa infondere nei suoi personaggi, anche quelli "cattivi" come il capo della polizia politica di Napoli. La bella Livia, poi. Che dall'altra parte del mondo, canta il suo dolore con un tango. Caminito, appunto».
Fabrizio d'Esposito, «il Fatto Quotidiano»
«Se da un lato il registro dominante di questo anomalo poliziesco è quello della rilettura storica degli anni del fascismo, più intensamente degli altri romanzi della serie qui la scrittura di De Giovanni vibra di echi e di richiami alle memorie del passato, al tempo perduto, all'amore inespresso, al fluire della vita che trascorre e svanisce lasciandoci solo il suo senso inesplicabile. È il tempo, che unisce e separa, a rendere assurda e insensata ogni vicenda personale. A Ricciardi e alla sua sposa, così come ai due giovani uccisi nell'attimo in cui si giuravano amore eterno, è stata sottratta la felicità dopo averla promessa».
Santa Di Salvo, «Il Mattino»
«Romanzo che conferma quanto de Giovanni ami il suo personaggio al punto da sentirne palpitare cuore, pensieri, mille dubbi: per questo lo riconsegna ai suoi lettori più vivo che mai, più adulto, maturo, disilluso, non fermo nel tempo e identico a sé stesso mentre attorno accadono e continuano a verificarsi senza soluzione di continuità omicidi che solo lui, con il celebre dono del "Fatto" – ascoltare la voce dei morti assassinati negli ultimi istanti di vita – potrebbe risolvere».
Pier Luigi Razzano, «la Repubblica – Napoli»
«Quello che sembra importare sempre di più a de Giovanni è l'analisi e l'introspezione dei personaggi, delle loro storie, delle loro passioni. E se l'autore napoletano si conferma un appassionato tessitore di trame, anche la parte più "intima" del racconto gli è congeniale. Intanto, le ultime pagine lasciano aperta la strada: Ricciardi è tornato e non è affatto intenzionato ad abbandonare i suoi lettori».
Mirella Armiero, «Corriere del Mezzogiorno»

Tasmania di Paolo Giordano, uscito il 25 ottobre nei Supercoralli, si aggiudica il primo posto nella Classifica di Qualità 2022 de «La Lettura – Corriere della Sera» con 304 punti.
Nicola H. Consentino sulla vittoria: «“Scrivo di ogni cosa che mi ha fatto piangere”. La frase che chiude Tasmania di Paolo Giordano mette il punto, infine, all'intero 2022 della lettura in Italia. Un anno consacrato alla rielaborazione di ciò che ci preoccupa, commuove o ferisce in questo «tempo pre-traumatico» di cui il romanzo di Giordano ha saputo indicare grammature esatte e coordinate.
Chi legge Tasmania, infatti, riceve in dono dall'autore uno strumento di decodifica del mondo, utile a tradurre non soltanto la “nuova forma di male assoluto” che è sbocciata “qua e là nel continente come un fiore marcio”, ma le nostre stesse idee su come questo fiore vada estirpato.
Nelle 250 pagine di cui il libro è composto, non c'è paragrafo che non susciti un'intuizione, un sospiro di sollievo; l'istinto di telefonare a un interlocutore con cui non si è stati efficaci e dirgli, testo alla mano: "Ecco, guarda, avrei dovuto esprimermi così. Esistevano parole per spiegarlo"».
Al terzo posto, secondo fra gli italiani, c’è Avere tutto di Marco Missiroli, uscito il 27 settembre sempre nei Supercoralli, con 144 punti.
In Top Ten troviamo al quinto posto Tomás Nevinson di Javier Marías e Oh William! di Elizabeth Strout all’ottavo.
Per quanto riguarda le case editrici, Einaudi, come lo scorso anno, è l'editore più votato con 64 titoli.
-
Tasmania
Un romanzo sul futuro. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo.pp. 272€ 13,00 -
Avere tutto
Un romanzo tesissimo e profondo sulle passioni che ci rendono vivi, sugli amori mai dimenticati, su chi scrive il proprio destino dando fuoco all'anima. Sui padri e le loro eredità nascoste.pp. 168€ 12,00 -
Tomás Nevinson
Una profonda riflessione sui limiti di ciò che è lecito fare, sulla macchia che quasi sempre accompagna la volontà di evitare il male peggiore, e soprattutto sulla difficoltà di determinare quale sarà quel male.pp. 624€ 16,00 -
Oh William!
Un matrimonio ricostruito per ricordi apparentemente casuali, ma capaci di illuminare i sentieri sicuri e i passi falsi di una vita coniugale, dove le piccole miserie e gli asti biliosi convivono con i segni di un'imperitura intimità.pp. 184€ 12,00

Il 25 novembre, all’età di 93 anni, ci ha lasciato il poeta e scrittore tedesco Hans Magnus Enzensberger.
Lo ricordiamo con le parole dell’autrice Antonia S. Byatt, pubblicate dal «New York Times» vent’anni fa e riproposte da «Repubblica» il giorno della scomparsa:
«Il tedesco ironico per eccellenza è Hans Magnus Enzensberger, nato nel 1929 in Baviera, cresciuto nella Norimberga nazista, giovane marxista, anziano umanista. Lo considero per molti versi il mio europeo ideale: poliglotta, poliedrico, scettico e umano, con un forte senso della storia sia nel bene che nel male. La sua poesia, gentile o aspra, è piena di doppi e tripli sensi: quando pensi di ridere comodamente con lui, scopri che sta ridendo aspramente di te; quando pensi che sia leggermente comico, sta diagnosticando l'orrore» (link).
Le opere di Enzensberger nel catalogo Einaudi:
-
Artisti della sopravvivenza
«Innumerevoli sono gli scrittori che, nel corso del Novecento, sonosopravvissuti a terrore di Stato ed epurazioni, con tutte le ambivalenzemorali e politiche che questo ha comportato. Ma come sono andatedavvero le cose? Erano forse troppo saldi per capitolare di fronte alpotere? Devono la sopravvivenza alla...pp. XII - 184€ 19,00 -
-
-
Mausoleum
Testo a fronte
***
Strappa a un gatto dopo il pasto
lo stomaco, cuci l'organo,
mettilo a bagno in acqua calda
e dimostra quindi sul tavolo
la digestione dei cadaveri. Nulla
di piú bello e di piú nuovo.
Un secolo illuminato. Eppure
lo infestano i mosconi.
L'abate è un maniaco. Copula rospi
con salamandre:
mostruose congiunzioni. Dalla femmina
squartata estrae le uova,
indi ammazza i maschi, ne stilla
lo sperma e fa...pp. 288€ 16,00 -
-
-
Il mago dei numeri
«Tutti i bambini sognano di volare. In matematica si vola, eccome».
H. M. Enzensbergerpp. 264€ 14,00 -
-
-
-
-
-
-
-
Musica del futuro
Auch das Ende der Welt
ist vielleicht
nur ein Provisorium
Vorläufig sterben wir
seelenruhig
in unseren Liegestühlen
Dann sehen wir weiter
Anche la fine del mondo
è forse
soltanto un provvisorio
Al momento moriamo
in buona coscienza
nelle nostre sdraio
E poi vedremopp. VIII - 208€ 14,50 -
La fine del Titanic
Rottami, frammenti di frasi, | cassette vuote, grosse buste commerciali, | bruni, fradici, rosicchiati dal sale, | estraggo dai flutti dei versi, | dai cupi, caldi flutti | del mar dei Caraibi, | dove pullulano gli squali, | versi esplosi, salvagenti, | vorticosi souvenirs.pp. 200€ 15,00
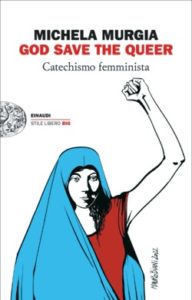
Come fai a tenere insieme la tua fede cattolica e il tuo femminismo? È una domanda che Michela Murgia si sente rivolgere di continuo. È la stessa che si pongono le persone credenti LGBTIAQ+ e che si pone chiunque debba fare compromessi tra la propria coscienza e i precetti dottrinari, per esempio in merito ad aborto, eutanasia, fecondazione assistita. Per rispondere è necessario capire quali aspetti della vita e della fede siano davvero in contraddizione, e soprattutto se certi insegnamenti non siano semplicemente un’eredità storica da ridiscutere ogni giorno alla luce del Vangelo e della propria intelligenza.
God Save the Queer è un audace pamphlet, popolare e coltissimo, che con lucidità ed ironia ci spiega perché si può essere persone femministe e cattoliche nello stesso tempo.
«Quando ho iniziato a scrivere, volevo capire se si può essere femministe e cattoliche. A mano a mano che andavo avanti sentivo la necessità di arrivare alla queerness, cioè alla possibilità che le strutture dell'identità e delle relazioni siano meno rigide di quanto non si voglia o non si pensi».
Michela Murgia in dialogo con Nichi Vendola, «L’Espresso»
«Di Michela Murgia, in God Save the Queer, c'è tutto. Ci sono la fede e la modernità. La capacità di indagare il sacro e quella di rappresentarlo attraverso le parole. Il femminismo, la tecnologia, uno sguardo aperto sulla vita che è, sempre, mutamento. E che per questo nulla può pretendere di fissare. C'è, al fondo, la libertà di una scrittrice che può spaziare dalla Bibbia a Harry Styles a Cenerentola passando per David Bowie e Il giovane Holden, senza smettere di parlare di noi».
Annalisa Cuzzocrea, «La Stampa»
«Lo spieghi bene nel tuo libro, lo stesso concetto che avevo espresso io in Quel che è di Cesare: c'è differenza tra essere cristiani, essere credenti o aderire alla cristianità. L'uso improprio della religione come strumento di potere è il più grande tradimento del Vangelo».
Rosy Bindi, «la Repubblica»
«God Save the Queer è un libro anche molto divertente: uno sta lì che legge una frase dal Vangelo secondo Giovanni e poi spunta Harry Styles… Il bello della scrittura della Murgia è che è molto colta, molto gradevole, lieve, però è anche molto popolare e intima [...] Io credo che questo libro oggi sia ancora più interessante perché, ripeto, con grande leggerezza spiega e indaga cose che ci riguardano tutti».
Daria Bignardi a Radio Capital, link
«Un coraggioso pamphlet, colto e ironico, teologicamente importante e umanamente prezioso».
Sabina Minardi, «L’Espresso»
«Puntando sulla sua vita da credente e attivista Murgia vede un Gesù come Messia che non si fa racchiudere in etichette e genere, un Messia "queer", che sta dove recinti ed etichette saltano».
Monica Bogliardi, «Grazia»

Dopo Divorare il cielo (Supercoralli 2018, in Tascabile dal 2019) e Nel contagio (Vele 2020), Paolo Giordano torna nelle librerie con Tasmania: un romanzo sul futuro. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo.
Il protagonista è un giovane uomo attento e vibratile, pensava che la scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte ma si ritrova davanti un muro di domande. Con lui ci sono Lorenza che sa aspettare, Novelli che studia la forma delle nuvole, Karol che ha trovato Dio dove non lo stava cercando, Curzia che smania, Giulio che non sa come parlare a suo figlio. La crisi di cui racconta questo romanzo non è solo quella di una coppia, forse è quella di una generazione, sicuramente la crisi del mondo che conosciamo – e del nostro pianeta. La magia di Tasmania, la forza con cui ci chiama a ogni pagina, è la rifrazione naturale fra ciò che accade fuori e dentro di noi. Cosí persino il fantasma della bomba atomica, che il protagonista studia e ricostruisce, diventa un esorcismo: l’apocalisse è in questo nostro dibattersi, e nei movimenti incontrollabili del cuore.
Il libro, «tra i titoli più contesi alla Fiera di Francoforte» («Corriere della Sera») e i cui diritti sono stati già venduti in oltre venti paesi, sta ricevendo un’accoglienza straordinaria:
«Tasmania non è solo un romanzo perché è troppo moderno per essere un romanzo classico. Usa il romanzo, cioè quello che ha imparato dal romanzo, come chiave di accesso, ma questo è un libro che contiene in sé altre forme, il giornalismo, il reportage, il saggio, l'autofiction, la riflessione su un'epoca. Senza che il lettore ne esca mai frastornato, ma anzi con l'effetto di tenerlo incollato, bisognoso di continuare perché felice di sentirsi vicino e compreso: felice di essere portato con leggerezza nella profondità dei suoi abissi».
Annalena Benini, «Il Foglio»
«Qual è il peso specifico di una crisi quando sia il passato (come forma di nostalgia) che il futuro (come forma di utopia) sono altrettanto inattingibili? In questo senso, Tasmania – un romanzo lucidissimo e struggente – sembra interrogarsi su ciò che Divorare il cielo lasciava ancora aperto».
Veronica Raimo, «7 – Corriere della Sera»
«Tasmania parla di noi, delle nostre crisi intrecciate alla crisi più devastante, quella del clima, mentre a nessuno che possa davvero fare la differenza pare ne importi veramente qualcosa. Che bello quando uno scrittore scrive un romanzo immerso nel suo tempo: presente, passato e forse anche futuro».
Daria Bignardi, «Vanity Fair»
«Giordano riesce a sovrapporre una frattura interiore a quella collettiva. Tasmania è un libro bello e importante, forse il romanzo definitivo su quel che ci sta succedendo e non riusciamo a spiegarci».
Nicola H. Cosentino, «Corriere della Sera»
«Mi succede con pochi romanzi. Inizio a leggerli e mi ci accomodo dentro come se parlassero la mia stessa lingua. Ma non si tratta soltanto di parole, è roba più profonda, che ha a che fare con l’anima che, come col tocco di un diapason, comincia vibrare nella stessa frequenza. Dico che è un libro bellissimo. Fine».
Luciana Littizzetto, link
«Tasmania è un libro feroce e insieme struggente. Il libro di uno scrittore adulto, che porta addosso i segni di quello che gli è accaduto e ci sta accadendo: in pari misura. Anzi: il suo corpo si fa sismografo, sembra acquisire le stigmate dalle catastrofi. La pandemia, la crisi climatica, la siccità e in generale la crisi della nostra presenza sul pianeta».
Elena Stancanelli, «tuttolibri – La Stampa»
«Paolo Giordano ha smesso di fare il fisico e si è dedicato ai romanzi, senza smettere però di essere uno scienziato. Ha scelto un approccio non lineare a questioni che la matematica non riusciva a dirimere, le parole come strumento più potente dei numeri, ma che vanno maneggiate con altrettanto rigore e precisione affinché producano segnale e non rumore, per usare il gergo degli statistici».
Stefano Feltri, «Domani»
«Giordano firma il suo quinto romanzo, il più bello, perché nichilista e contemporaneo, attestandosi come il narratore più sfaccettato sulla scena italiana, capace di parlare di nuvole e orgasmi, terrorismo e divorzio, gender gap e Lanzarote».
Francesco Musolino, «Il Messaggero»
«Le opere di Giordano si distinguono per un nitore sintattico che non "sporca" mai la pagina e per uno scandaglio psicologico sempre spudorato e meticoloso. In tal senso non c'è parentela con la tradizione italiana. Si avverte l'eco di letture assai metabolizzate di autori feticcio come McEwan o Cunningham, rivelatori anche dell’attitudine a raccontare infanzia e adolescenza».
Crocifisso Dentello, «il Fatto Quotidiano»
«C’è un nodo che vorrei subito raccontare e cioè la capacità del protagonista, di chi parla in questo romanzo, di raccontarci e analizzare con occhi molto acuti i grandi temi del presente».
Giorgio Zanchini, «Quante storie – Rai 3»








































