
Da quasi un decennio la Xylella fastidiosa sta uccidendo gli ulivi in Sud Italia. L'epidemia è scoppiata nella zona di Gallipoli, portata dal mare, da chissà dove, e da lì non ha fatto che allargarsi. Fin dall'inizio, è stato proposto un piano di eradicazione degli esemplari infetti, così come di tutti quelli sani nel raggio di un centinaio di metri, al fine di contenere la malattia: alberi di quattro o cinquecento anni amputati, scalzati dal suolo e bruciati in un pomeriggio come misura di emergenza. Una strage, insomma.
Alberi di quattro o cinquecento anni amputati, scalzati dal suolo e bruciati. Una strage, insomma.
Se non avete mai visto gli ulivi secolari della Puglia, statuari nelle distese di terra rossa, è probabile che non capiate di che cosa io parli, né del perché ne stia parlando. Ma se li avete visti, se vi siete avvicinati anche una sola volta alla loro corteccia tortuosa e grigia, alle fessure e ai nodi del tronco, allora sapete che non c'è bisogno di essere dei mistici o dei fanatici dell'ecologia per accorgersi che in quegli alberi vi è qualcosa di diverso. Che sembrano senzienti, e non in modo vegetale ma come sono senzienti gli animali. Sebbene io non l'abbia mai fatto, non mi stupisce che ci siano persone inclini ad abbracciare quei tronchi per riceverne forza. E tantomeno mi stupisce che, di fronte a una minaccia, non solo gli agricoltori e i proprietari terrieri, ma anche ragazzi di vent'anni, animati da un senso istintivo di ciò che è giusto, possano fare cordone intorno a quelle sculture viventi perché vengano risparmiate.

Era l'estate del 2014 quando ho sentito parlare per la prima volta del presidio di Oria. Mi ero sposato da poche settimane e in quel periodo non mi sentivo attirato dal alcun genere di battaglia. Mi sembrava un intervallo della vita dedicato legittimamente alla calma, alla contemplazione, a un po' di felicità superficiale. Ma il presidio era lì, a pochi chilometri da dove trascorrevo le vacanze, quasi un affronto non considerarlo. Così un pomeriggio, di ritorno dal mare, mi sono inoltrato nelle strade di campagna, lungo gli sterrati protetti dai muri a secco. Il presidio era isolato, c'è voluto un po'. Infine ho trovato una dozzina di ragazzi, accampati tra alcune tende e un rudere, bevevano birra, fumavano, alcuni di loro giocavano a carte. Mi sembravano annoiati eppure in allerta, come pronti ad attivarsi per un'urgenza che prima o poi sarebbe arrivata. All'inizio mi hanno trattato con sospetto, poi devono avermi valutato innocuo e hanno acconsentito a mostrarmi gli ulivi abbattuti, coricati a terra in attesa di essere bruciati, e gli altri intorno, marcati con una X di vernice rossa, in attesa della stessa sorte. Avrebbero difeso quegli alberi a ogni costo.
Avevo intenzione di scrivere un articolo su quella visita, ma alla fine non l'ho fatto. Mi ero già messo a lavorare a un romanzo e tornando verso casa – il sole basso sull'orizzonte e l'immagine insistente di quei ragazzi e degli ulivi condannati –, ho avvertito come l'incontro di quel pomeriggio avesse già modificato l'evoluzione della storia nella mia mente.
Sono passati quattro anni e nel frattempo la situazione in Puglia è precipitata. Il guazzabuglio d'informazioni contraddittorie sull'infestazione, di tesi scientifiche e pseudoscientifiche affiancate senza ritegno, di teorie complottiste, d'interessi economici, d'intimidazioni, d'inefficienza politica e di tipico lassismo italiano, hanno determinato una paralisi che ha lasciato il batterio libero di diffondersi di pianta in pianta, verso nord, come una cancrena inarrestabile. Oggi il Salento è gravemente compromesso. Guidando lungo la superstrada che collega Brindisi a Lecce il disastro è visibile a occhio nudo: alberi maestosi che l'estate prima avevano al più qualche ciuffo di foglie ingiallite sono ormai degli scheletri, gli oliveti delle distese spettrali. È un panorama che stringe la gola di commozione.
Alberi maestosi che l'estate prima avevano al più qualche ciuffo di foglie ingiallite sono ormai degli scheletri. È un panorama che stringe la gola di commozione.
In una certa misura, credo che si possano considerare i presidi corresponsabili del disastro. Senza ostruzionismo il programma di contenimento della Xylella avrebbe funzionato? Se il problema fosse stato affrontato con freddo senso di realtà, senza patetismi, senza un briciolo di cuore, lo avremmo risolto in tempo? E tuttavia, neppure con le conseguenze davanti, le risposte mi sembrano così semplici, univoche. Abbattere degli ulivi per salvare gli ulivi? Oppure, al contrario, proteggere pochi ulivi condannando così tutti gli ulivi? È quel genere di paradosso etico stritolante nel quale la vita ci getta spesso. Un paradosso che tocca le coscienze individuali in modi così diversi che, tenendo conto di tutto, non possiamo che ammutolire. Non a caso, il pasticcio della Xylella ha polarizzato violentemente l'opinione pubblica, spaccandola in due fazioni che si rifiutano anche solo di accogliere le ragioni opposte. Il pensiero nella sua interezza, troppo complicato, viene reciso di netto e ci si lascia prendere da qualcosa di meno razionale: l'indole, le impressioni, ciò che si sente dire in giro. La politica non fa che aggravare la situazione, sposando con la stessa spregiudicatezza una causa o l'altra per pura convenienza, fino a negare, com'è successo a luglio scorso, l'esistenza stessa dell'epidemia. E così, nell'irrigidirsi delle posizioni, nell'alzarsi costante dei toni, il batterio continua silenzioso a riprodursi, a divorare, a soffocare i vasi linfatici degli ulivi.
Scrivendo un romanzo si mettono il più possibile a tacere le proprie opinioni per non corrompere quelle dei personaggi. Quando ho seguito Bern e Teresa e Danco e Giuliana al presidio e poi in cima agli alberi, l'ho fatto con totale disarmo e tuttavia con la consapevolezza sottostante che difficilmente mi sarei trovato insieme a loro in una lotta come quella. Ma il fatto stesso di aver scelto la loro storia fra le infinite intorno tradisce, mi sembra, una possibilità della mia anima: quella possibilità che ho intuito ascoltando, dapprima pieno di scetticismo, i ragazzi di Oria, registrando la loro indignazione per quelle X di vernice rossa. Una possibilità di resistenza, che l'immensità della campagna piatta intorno rendeva ancora più futile, e quindi più romantica, più eroica. Oggi, ogni volta che ascolto qualche aggiornamento a proposito dell'epidemia, oppure qualche storia analoga – la protesta di Hambach, le manifestazioni contro l'aeroporto a Nantes –, quella possibilità si riattiva in me. È sotterranea eppure vigile, e non vuole sentire ragioni, non vuole più ascoltare o negoziare. Scalpita per arrampicarsi sui tronchi invece, su fino ai rami più alti e da lì, in mezzo a questa guerra ambientale persa ormai da tempo, da generazioni che hanno preceduto la nostra, il mezzo della desertificazione che avanza inarrestabile; da lì vuole gridare: «No. Almeno qui no. Questo singolo albero, no».
Paolo Giordano

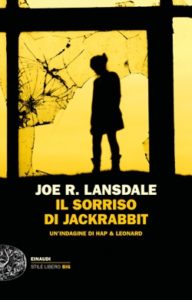
Tornano i detective Hap Collins e Leonard Pine, i due investigatori privati irriverenti e ironici, mai scontati, nati dalla penna di Joe Lansdale. Il sorriso di Jackrabbit è l'ultimo capitolo di una storia iniziata nel 1990 e sbarcata in Italia nel 2006.
In concomitanza con l'uscita del libro è stata aperta la pagina ufficiale italiana dell'autore su Facebook, nella quale verranno presentati i suoi libri e l'autore interagirà in prima persona con il pubblico italiano.
Hap si è appena sposato con Brett e sta preparando il picnic nuziale. Ma durante la festa arriva un pick-up, da cui scendono una donna sessantenne e un giovane tatuato con una scritta inequivocabile sulla maglietta: «BIANCO È GIUSTO».
Pur turbati dal colore della pelle di Leonard, i due ospiti non invitati vogliono commissionare all'agenzia un incarico: ritrovare Jackie, figlia della donna e sorella di Thomas. Se ne è andata da cinque anni, temono che sia morta, vogliono conoscere la sua sorte; aveva spesso offeso il loro onore andando «con quelli di colore». È, o era, una ragazza bella e sexy, nonostante gli incisivi sporgenti, la chiamavano Jackrabbit.
Lansdale, con la solita maestria, «rimesta nel torbido appena può. Mescolando scene pulp con improvvisi colpi di scena, senza tentare, mai, di limitare parole e azioni dei suoi protagonisti. Il risultato è un giallo che cattura come una ventosa, che diverte alla maniera di un monologo di Sacha Baron Cohen, forte come un bourbon distillata illegalmente, in una fattoria di animali» (Riccardo De Palo, «Il Messaggero»).
Il sorriso di Jackrabbit, l’ultimo noir dedicato ai suoi eroi più celebri, è una storia potente che somiglia a un True Detective prima stagione, con tanto umorismo da B-movie, molto più realistica di quanto si possa pensare. Riccardo De Palo, «Il Messaggero»
L'indagine si rivela subito pericolosa e porta i due detective a scontrarsi con fanatici razzisti, individui dalla pistola facile, personaggi bizzarri. «Hap & Leonard si muovono nel white trash della provincia con grande disinvoltura, tra battute fulminanti (spesso salaci), che accompagnano spedizioni temerarie tra killer su commissione, ex cinema diventati rifugi di sette misteriose e discariche di macchine abitate da loschi figuri» (Riccardo De Palo, «Il Messaggero»).
Fonte di ispirazione per questo ultimo episodio della saga è stata anche l'ombra di Trump: «Ho pensato a quello che accade qui oggi con chi dà retta alle sue idee conservatrici: i manifestanti razzisti di Charlottesville. Ma del resto l'antirazzismo nelle mie storie è una costante» (Joe Lansdale, «il venerdì - la Repubblica»).
Insolito e molto bello questo libro di Maria Pace Ottieri. Narrazione tra passato e presente, cronaca viva, poesia, storia, antropologia, reperto archeologico, inchiesta, memoria Corrado Stajano, «Corriere della Sera»
Maria Pace Ottieri ha vissuto da bambina nell'area flegrea, quel paesaggio ha lasciato un segno, pur nella lontananza. Il Vesuvio torna nei suoi pensieri, richiamando sentimenti ambivalenti, «come una scheggia d'infanzia» nascosta nel profondo che riemerge e la chiama a sé.
Inizia un viaggio, si immerge in un’inchiesta in cui il protagonista è Lui, il Vesuvio. La scrittrice sta nell'ombra, raccoglie voci, viviseziona il mondo di uomini e donne che lo popolano. «Curiosità, cocciutaggine indagatrice, ironia, confronti continui tra il vicino e il lontano, sensibilità sociale: ecco gli elementi di questa scrittrice a pieno titolo, spesso travestita da reporter che si ripresenta ai lettori con Il Vesuvio universale. Si tratta di un libro libero e sorprendente, l’avventura conoscitiva di una “camminatrice di ritorno”. Potremmo definirlo un libro-armadietto – il vulcano armadietto è una delle immagini suscitate dal vulcano – dove ad ogni cassetto corrisponde una storia e dove con pudore e nettezza la voce propria si accosta a quella altrui e dove l’arte della descrizione affabulante e sussultoria spesso eccelle e affascina, celandosi a tratti in veri e propri “scatti verbali” simili ad emblemi» (Silvio Parrella, «Il Mattino»).
L’autrice «attraversa i generi della narrazione e del reportage per regalarci un racconto a più voci […] Con occhio estraneo agli scenari, Ottieri si cala in una realtà difficile come un’etnografa» (Fuani Marino, «Corriere del Mezzogiorno»). Il vulcano, con il suo aspetto di «montagna benevola e generosa» sembra far dimenticare la sua violenza e capacità distruttiva; sotto vivono oltre due milioni di abitanti abituati a quella promiscuità, grati ad una terra fecondata dalla sua linfa. Sono irresponsabili? Immemori? Fatalisti o fiduciosi in San Gennaro?
Maria Pace Ottieri indaga, ascolta, raccoglie le paure e l'orgoglio, la rassegnata abitudine a vivere nel pericolo; «non risparmia passione e fatica. Non lascia nulla all’immaginazione, il suo libro è anche una lezione a quei giornalisti, non pochi, che fondano le loro inchieste su quel che gli dice il tassista del posto dove approdano, oltre alle notizie trovate in internet. ’N coppa ’o Vesuvio la scrittrice riempie la sua bisaccia di fatti veri piccoli e grandi» (Corrado Stajano, «Corriere della Sera», link). Vede anche altre devastazioni: quella provocata dall'abusivismo e dalla lontananza dello Stato, dall'abitudine alla trasgressione e dalla potenza della Camorra, ancora più presente dal terremoto del 1980.
«Tra Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Bosco Reale, Torre del Greco, Portici, Torre Annunziata, Anastasia, Pompei, Maria Pace Ottieri ha vivisezionato un mondo. Chissà se da tutti quegli inferni che ha visto è riuscita, alla fine del suo libro, a riveder le stelle» (Corrado Stajano, «Corriere della Sera», link).
Roberta Dapunt, con Sincope, uscito a marzo 2018, è la vincitrice del Premio Letterario Internazionale Viareggio Rèpaci 2018, sezione Poesia. Per la giuria «in questo libro il pensiero si svolge dentro un mondo distante, separato, fatto solo di silenzio e di solitudini tali da cancellare persino le normali possibilità di comunicazione fra gli individui, anche un semplice scambio di parole».
Rispetto ai precedenti lavori, nella nuova raccolta la spinta verso l'inquietudine è decisamente più forte. È la stessa autrice a sostenere che «Sincope racconta un tempo debole, racconta il corpo debole, è uno spostamento di accenti sulla fragilità dell’essere umano. Partendo da me, dunque dalla mia fragilità, del mio corpo, del mio pensiero» (Roberta Dapunt a «Fahrenheit», Radio Tre).
Il tono compassato lascia dunque il posto a un'agitazione interiore, i segni senza tempo della natura non danno più stabilità: «Sincope come ritmo che saltella e ti leva il fiato e ti fa abitante e abitatore e mescola gli istinti con gli estinti» (Silvio Parrella, «Il Mattino»).
Le poesie che compongono questa raccolta «scavano nell’anima come uncini […] In questo libro dove i titoli tracciano già una poetica, si stremisce di affollati particolari. In un continuo andare e venire tra il pagano e il sacro. Il verbo si fa carne, la carne si fa verbo» («Avvenire»):
In questa carne ho radicato gli anni, li ho educati.
In questo corpo la materia dei miei pensieri
e le parole e le domande.
Su questa pelle l’ambiente delle loro risposte,
fino a contrarla, le vocali e le consonanti.
Ho consegnato ad ogni osso della mia struttura una lettera
e da lí le parole, una ad una le ho nutrite e ho appreso,
mentre crescevo la carne si faceva verbo.
Composte membra, ordinate si sono gonfiate,
dilatate le loro cavità e da lí io ho ascoltato,
ed era voce del mio corpo. Che mi chiamava
e io sorda alle sue espressioni, finché
ho appoggiato le labbra alla loro imboccatura,
organica relazione, ho forgiato la lingua
ed essa ha compreso il gusto
e cosí finalmente io le ho parlato.
(Sincope, della carne e della lingua, p. 3)
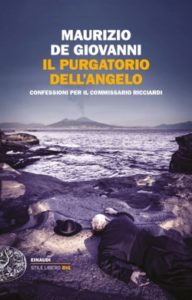
Il cadavere di un gesuita, un segreto che non può più essere nascosto: è tempo di confessioni per il commissario Ricciardi.
«La storia si svolge a maggio con lo scirocco che soffia sale e sabbia, e rende rosso il cielo. È il mese delle rose. A un certo punto de Giovanni sospende il racconto e segue il destino di un fiore. È una rosa che passa di mano in mano, un fiore che insegue la vita, sfiora anche la mano di Ricciardi; dietro ogni mano c’è una persona e c’è una storia talvolta felice, talvolta triste che lo scrittore tratteggia con brevi e rapidi accenni. Maurizio de Giovanni, qui e altrove nei romanzi e nelle serie narrative, prova con caparbietà a raccontare tante storie, a inseguire molte vite. Come fa la rosa».
Severino Colombo, «Corriere della Sera»
Con Il purgatorio dell’angelo Maurizio de Giovanni dà vita ad un altro romanzo dedicato all’amatissimo commissario Ricciardi. Questa volta il protagonista dovrà fare i conti non solo con il ritrovamento di un cadavere, ma anche con i suoi sentimenti per l’amata Enrica a cui non può continuare a nascondere la propria natura, il segreto che a lungo lo ha tenuto lontano da lei.
A Posillipo, vicino alla spiaggetta dell'acqua minerale, riverso sul tufo c'è il corpo di un uomo: indossa la tonaca, ha il viso rivolto verso il suolo, una ferita sulla testa di radi capelli bianchissimi. La vittima è un prete, un gesuita colto, un professore per i seminaristi della comunità di San Luigi, amico e confessore di famiglie influenti, dell'alta società napoletana. Il commissario Ricciardi, giunto lì con il brigadiere Maione ed una recluta, Vaccaro Felice, osserva il cadavere e manda via i presenti. Pochi istanti dopo arriva «il fatto», la voce del morto che gli sussurra poche parole, quelle che lo guideranno in una difficile indagine: «Io confesso, ti confesso, lascialo stare, lascia che viva, io ti confesso».
Per Severino Colombo, in un’appassionata recensione del romanzo sul «Corriere della Sera», ci sono due elementi che «danno la misura di quanto, in questa indagine, la sfida a cui de Giovanni invita il lettore sia raffinata e stimolante, fatta di rimandi interni tra situazioni in divenire e di dettagli coerenti tra i personaggi. Il primo aspetto è il luogo dove il religioso, la testa fracassata da una grossa pietra, viene ritrovato: a Posillipo su un piccolo promontorio che ben dispone alla pace dell’anima e che invece, in questo caso, offre riposo (eterno) a un corpo. L’altro elemento da rimarcare è la (nota) capacità di Ricciardi di vedere i morti (quelli uccisi o raggiunti da morte violenta) e di sentire le loro ultime parole, nel caso di padre Angelo: “Io confesso, ti confesso”. Frasi aperte con una doppia valenza semantica che non sfugge al commissario: poteva essere l’ammissione da parte del religioso di una colpa commessa o “poteva anche essere un riferimento all’attività principale di padre Angelo, e in tal caso sarebbe stato opportuno condurre la ricerca tra coloro che avevano l’abitudine di svelare le proprie anime nere al gesuita”».
Padre Angelo era amato, afferma incredulo il superiore della comunità dei gesuiti, un uomo straordinario, autorevole sì, ma dolce e sereno, fedele al suo compito,insomma quasi un santo. Dove andava la notte in cui è stato ucciso? È stato chiamato per qualche confessione?
Il commissario conosce la difficoltà della confessione, lui stesso sa di dover dire alla sua amata Enrica ciò che lo turba, deve metterla a parte del suo terribile segreto, quello che gli fa percepire il dolore e le parole delle vittime. Deve parlare con lei, che ha rifiutato Manfredi, un ufficiale affascinante e ricco, tedesco per di più, e nel 1933, anno XI del Fascismo. La scelta di Enrica è incomprensibile per la madre, che ora vuole conoscere quel Ricciardi, inspiegabilmente scapolo e solo: «Lacicatrice della solitudine la riconosci subito […] Il racconto della strada – perché noi raccontiamo la strada – non può prescindere dal racconto delle solitudini. Nei nostri libri la solitudine ha anche un’altra funzione, porta alla riflessione e moltiplica i talenti» (Maurizio de Giovanni a colloquio con Ilaria Tuti, «la Repubblica»).
L'indagine dunque si intreccia con le difficoltà e le inquietudini del commissario, con i suoi dubbi: «Essere testimone visionario del dolore del mondo e sopportarne quindi il peso angoscioso lo fa diventare vittima di quello che chiama “il fatto” […] Questa rappresenta comunque, la sua arma investigativa. In un’azione che contempla incontri, interrogatori, ricerche e confessioni. Le sue e quelle dei padri gesuiti, in un intreccio dei piani giudiziario e religioso, uno inquisitorio alla Ricciardi e l’altro mistico alla Sant’Agostino, che costituisce il terreno di più succoso significato su cui de Giovanni si misura, uno scavo nel profondo degli animi che punta allo svelamento del crimini e delle colpe» (Generoso Picone, «Il Mattino»).
Agus Morales segue le orme degli esiliati della terra e dà voce a coloro che sono stati obbligati a fuggire.
«Oggi anche Einstein rischierebbe la vita in un barcone».
Agus Morales, «la Repubblica»
***
Morales, con questo faticoso e importante lavoro di giornalista/narratore, sfida tutti coloro che vogliono soltanto informazioni, che non vogliono sapere, non vogliono essere provocati dalla verità perché hanno paura di sentir franare sotto di sé il terreno delle certezze.
Scrive un libro sui rifugiati, ascolta e racconta le loro storie, fa conoscere i muri, che molti vorrebbero altissimi, che separano noi da loro. Sono migliaia, milioni di persone in movimento, sedentari, non nomadi, che hanno perso la loro casa, i mezzi di sussistenza; esseri vulnerabili che fuggono dalle guerre, che non hanno il tempo di rielaborare lutti e perdite, che varcano confini. La loro sofferenza arriva fino a noi, le loro storie, raccontate con umiltà e pudore, sembrano non finire mai. Per Morales, intervistato da Stefania Parmeggiani, «una cronica deve emanare odore, tatto, gusto; deve avere una precisione linguistica, essere consapevole di se stessa e delle parole che pronuncia. La formula che ho trovato per trasportare il lettore su una nave di salvataggio non era la descrizione impersonale, ma la scrittura di frasi successive che erano come onde, che oscillavano, che cercavano di riprodurre la sensazione che avevo a bordo» («la Repubblica»).
Sono persone, quelle che arrivano e quelle che rimangono intrappolate, in Siria,nel Sud Sudan, in Afghanistan; la loro presenza nell'Occidente testimonia una sofferenza che non è più asettica e lontana ma provoca il nostro sguardo. «Durante la Guerra Fredda la parola rifugiato aveva un’aura di prestigio, riguardava anche scrittori, artisti, scienziati, uomini e donne illustri. Oggi la guerra è stata decentrata e la maggior parte dei rifugiati lascia i paesi poveri e viene accolta dai paesi poveri. Non interessano più così tanto. Oggi Einstein rischierebbe la vita in un barcone» (Agus Morales, «la Repubblica»).
Le storie che vengono raccontate,quelle di chi è arrivato e di chi non arriverà mai, devono essere ascoltate; il destino di Ulet, di undici anni, morto dopo il salvataggio, «quando stava per vincere», sembra riassumere tutti gli esodi del mondo.
Morales ha viaggiato lungo le rotte degli esodi, è entrato nei campi dei rifugiati e negli ospedali che li soccorrono, e lascia al lettore una testimonianza dura e preziosa sulla storia del nostro tempo, con la consapevolezza che «c’è sempre qualcuno più in basso di te, anche tra i rifugiati».
«La vicequestora Giovanna Guarrasi, detta Vanina, ha l’acume, la tenacia e la fantasia di una grande poliziotta».
Giancarlo De Cataldo
«Una storia secca, ritmica, scandita, che ti avvolge e ti stritola pagina dopo pagina, sospesa sul ponte instabile tra un passato che non vuole saperne di farsi seppellire e un presente mai del tutto comprensibile».
Maurizio de Giovanni
«La chiameranno l’antimontalbano, ma non è vero. Cristina Cassar Scalia è lei e basta, e Sabbia nera è un gran bel romanzo».
Carlo Lucarelli, «La Lettura - Corriere della Sera»
***
Cristina Cassar Scalia dà vita ad una nuova serie di serie di gialli, ambientati in Sicilia e con protagonista una donna testarda, scontrosa, tormentata dalla morte del padre e dalla fine di una relazione difficile: il vicequestore aggiunto Giovanna Guarrasi. È donna capace, con un curriculum di tutto rispetto, di metodi spicci e dolorosamente legata ad un passato che non riesce a rielaborare: «Non ha bisogno di fare la dura perché lo è, una dura, e non ricorre a metodi autoritari perché è un personaggio autorevole [...] Ciò non toglie che anche lei, come molte donne oggi, sia in crisi» (Cristina Cassar Scalia intervistata da Giancarlo De Cataldo, «D- la Repubblica»).
La lettura di Sabbia nera ha conquistato tre grandi maestri del crime italiano:
«La vicequestora Giovanna Guarrasi, detta Vanina, ha l’acume, la tenacia e la fantasia di una grande poliziotta».
Giancarlo De Cataldo
«Una storia secca, ritmica, scandita, che ti avvolge e ti stritola pagina dopo pagina, sospesa sul ponte instabile tra un passato che non vuole saperne di farsi seppellire e un presente mai del tutto comprensibile».
Maurizio de Giovanni
«Una storia che inizi a leggere e non molli più, perché è lei che non ti molla, obbligato a percorrerla tutta, senza pause, non col fiato sospeso del thriller, che è quello dei centro metri piani, ma con il respiro intenso, serrato e appassionato del maratoneta, che è quello, appunto, del giallo classico».
Carlo Lucarelli, «La Lettura - Corriere della Sera»
Dopo una giornata ricca di ricordi malinconici, nella sua casa sotto «La Muntagna» appena risvegliata e che ha iniziato a ricoprire la terra di sabbia vulcanica, Giovanna riceve una telefonata dell'ispettore Bonazzoli: in una villa a Sciara è stato trovato un cadavere.
La villa, signorile, è fatiscente e saltuariamente abitata da Alfio Burrano, unico erede del patrimonio di famiglia. È stato lui, per caso, a scoprire il corpo mummificato di una donna, in uno spazio segreto. Giovanna Guarrasi, detta Vanina - o Vannina «per una discreta quantità di corregionali» - si trova davanti una scena da romanzo gotico: il cadavere ha sul capo i resti di un foulard di seta, un cappotto di pelliccia e alcune collane.
Un primo sguardo all'abbigliamento e agli oggetti sparsi intorno al corpo fanno pensare ad un delitto che si perde nell'abisso del passato, «poi, però succedono tante cose, colpi di scena, improvvise inversioni di marcia, anche indietro nel tempo, scoperte inattese che cambiano tutta la prospettiva, nuovi punti di vista e tanta, tantissima tensione» (Carlo Lucarelli, «La Lettura - Corriere della Sera»).
In Sabbia nera, sempre secondo Lucarelli, «l’ultimo pilastro è l’ambientazione. La Sicilia, con tutte le sue bellezze e le sue contraddizioni, è una cornice perfetta, che permette di sporcare il folklore con il dramma giocando su qualcosa che tutti credono di conoscere ma che sempre sorprende. Qui, infatti, inizia con la sabbia nera dell’Etna, che copre, corrode e maschera tutto».
Un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo incontrano un personaggio misterioso che gli regala sette giorni per scoprire come sarebbe il mondo senza di loro. E, se possibile, per innamorarsi ancora della vita Corrado Stajano, «Corriere della Sera»
Il primo giorno della mia vita è il nuovo romanzo di Paolo Genovese, scrittore e fra i più noti registi italiani, vincitore del David di Donatello con Perfetti sconosciuti, film nuovamente sulle prime pagine di tutti i giornali per lo straordinario successo che sta avendo anche in Cina. L'autore «ora riversa il suo humour nero in un libro a tratti esilarante ed esaltante, a volte traboccante di toni bui» (Mirella Serri, «La Stampa»).
Napoleon ha 49 anni, sta invecchiando in modo «morbido» ma ha perso il sorriso; è un grande affabulatore, uomo di teatro che vuole offrire al suo pubblico la possibilità di essere felice. Ora però è sul Manhattan Bridge e sta per buttarsi di sotto, ma un uomo misterioso è lì a rovinargli il «momento più importante della sua vita». Lo invita a fermarsi dandogli la possibilità di vedere come sarà la sua vita dopo e senza di lui. Gli mostrerà cosa accadrà quando non ci sarà più, cosa lascia, cosa perde, quale sarà la reazione di amici e parenti. Con lui, in questo viaggio di sette giorni ci saranno anche due donne sfiancate dalla vita, Emily e Aretha, e un ragazzino, Daniel. Tutti erano pronti a farla finita.
«È un angelo che si scoraggia o entusiasma, ma non ha tutte le risposte, fa casino: come i quattro suicidi. Un traghettatore che non ha chiaro il suo stesso percorso. Tutto molto umano, come vede […] qui un uomo deve fare innamorare della vita persone disperate, totalmente. Lo fa con l'arma della curiosità: cosa succede dopo? Cosa ti perdi se molli? Nessun dogma» (Paolo Genovese, intervistato da Alvaro Moretti, «Il Messaggero»).
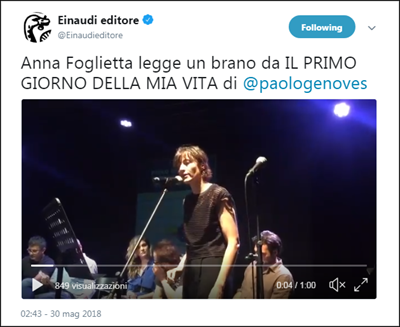
Emily è stata azzannata dal destino, ridotta a sanguinare su una sedia a rotelle, lei che volteggiava acclamata sulla trave. Aretha è una poliziotta travolta da un passato doloroso. La comitiva è strampalata, la situazione fuori da ogni logica ma i tre aspiranti suicidi accettano di vivere altri sette giorni per vedere quel futuro che vogliono rifiutare. Daniel è un piccolo divo della pubblicità, un po' grassoccio e bullizzato a scuola. Sullo sfondo New York e le sue contraddizioni, «la città più irreale, dove tutto può accadere, anche l'imprevedibile o il surreale» (Paolo Genovese intervistato da Mirella Serri, «La Stampa»).
Ogni personaggio di questa storia ha l'anima lacerata da demoni, lati oscuri che hanno ridotto l'esistenza a un cumulo di macerie. Ha senso dire addio alla vita? Si può resuscitare dalla cenere ? «Anche questi personaggi, come i protagonisti dei miei ultimi film, hanno toccato il fondo del dolore. Eppure si rialzano. Per loro c'è un futuro: l'ultimo giorno può anche essere il primo, quello della rinascita e dalla riscoperta di sé» (Paolo Genovese intervistato da Mirella Serri, «La Stampa»).
Philip Roth ha vinto il Premio Pulitzer nel 1997 per Pastorale americana. Nel 1998 ha ricevuto la National Medal of Arts alla Casa Bianca, e nel 2002 il piú alto riconoscimento dell'American Academy of Arts and Letters, la Gold Medal per la narrativa. Ha vinto due volte il National Book Award e il National Book Critics Circle Award, e tre volte il PEN/Faulkner Award. Nel 2005 Il complotto contro l'America ha ricevuto il premio della Society of American Historians per «il miglior romanzo storico di tematica americana nel periodo 2003-2004». Recentemente Roth ha ricevuto i due piú prestigiosi PEN Award: nel 2006 il PEN/Nabokov Award e nel 2007 il PEN/Saul Bellow Award for Achievement in American Fiction.
Roth è stato l'unico scrittore americano la cui opera sia stata pubblicata in forma completa e definitiva dalla Library of America mentre era in vita.
Nel 2011 ha ricevuto la National Humanities Medal alla Casa Bianca, ed è poi stato dichiarato vincitore della quarta edizione del Man Booker International Prize.
Tutte le opere di Philip Roth sono presenti nel catalogo Einaudi: Pastorale americana (1998), Operazione Shylock (1998), Il teatro di Sabbath (1999), Ho sposato un comunista (2000), Lamento di Portnoy (2000),La macchia umana (2001), L'animale morente (2002), Lo scrittore fantasma (2002), Chiacchiere di bottega (2004), Zuckerman scatenato (2004), Il complotto contro l'America (2005), Il seno (2005), L'inganno (2006), La lezione di anatomia (2006), L'orgia di Praga (2006), Everyman (2007), Patrimonio(2007), Il fantasma esce di scena (2008), Il professore di desiderio (2009), Indignazione (2009), L'umiliazione (2010), La controvita (2010), Nemesi (2011), «Ho sempre voluto che ammiraste il mio digiuno» ovvero, guardando Kafka (2011), La mia vita di uomo (2011), Goodbye, Columbus (2012),Quando lei era buona (2012), I fatti (2013), La nostra gang (2014), Il Grande Romanzo Americano (2014) e Lasciar andare (2016).
Nei prossimi mesi uscirà nelle Frontiere Einaudi l'edizione definitiva dei suoi saggi con il titolo Perché scrivere? Saggi 1960-2013, nella traduzione di Norman Gobetti.
Una raccolta di interventi che dialogano incessantemente con l'opera narrativa di Roth e al tempo stesso ci rivelano le sue tante passioni e l'acutezza del suo sguardo sul presente.
***
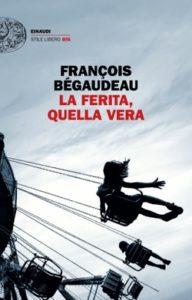
Da questo romanzo, il nuovo film di Abdellatif Kechiche, il regista dello straordinario La vita di Adèle - nelle sale italiane dal 24 maggio.
La ferita, quella vera è il nuovo romanzo di François Bégaudeau. È la storia dei tormenti di un adolescente in bilico sulla vertigine del desiderio ed ha ispirato Mektoub My Love: Canto uno, il nuovo film di Abdellatif Kechiche, il regista vincitore della Palma d'Oro a Cannes con lo splendido La vita di Adele. La trasposizione cinematografica, presentata allo scorso Festival di Venezia, e distribuita da Vision Distribution nelle sale italiane a partire dal 24 maggio, è stata definita «un inno alla libertà» da Repubblica e «un capolavoro» da Express.
In La ferita, quella vera François, stanco di eludere e di imbrogliare se stesso, decide di raccontare, di risalire alla sua ferita, di ritornare all'estate dell'86. È in vacanza nella casa famigliare, in un paesino della provincia francese; lui è il «nantese» che torna ogni anno, il villeggiante che, come tutti gli altri, arriva d'estate ad animare una vita altrimenti monotona.
François ha quindici anni, la voce si sta trasformando, ha qualche brufolo e uno strato di peluria sotto il naso; è comunista dall'83, dall'85 comunista con tendenza leninista. Ha l'urgente bisogno di perdere la verginità. Sente che il tempo passa ma che è complicato iniziare, ha baciato qualche ragazza ma deve passare di livello. Con lui c'è Joe, l'amico che non studia, fuma e abborda le villeggianti con fare sicuro, monopolizzando le migliori. François aspetta con la vertigine del desiderio, sa che nella vita ci sono le incognite e, infatti, arriva Julie, l'incontro che cambia la sua estate.
Bégaudeau ha saputo descrivere le «le gioie fragili e febbrili dei ragazzi, la litania della loro insofferenza e dei loro desideri, raccontati in modo assolutamente perfetto» («Le Monde»).



