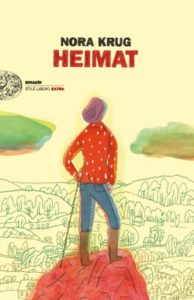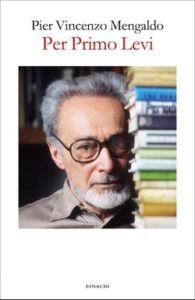Autore: Editor Einaudi

Il 2 giugno 1922, Antonio Gramsci arriva a Mosca, in treno da Berlino, con la delegazione del Partito Comunista d’Italia, capitanata da Amadeo Bordiga, per partecipare agli incontri del Comitato Esecutivo dell’Internazionale. A Torino, ha lasciato una situazione drammatica, con le squadracce fasciste in piena attività, e in Russia non lo attendono mesi di riposo. Sa che Zinov’ev e i bolscevichi, per fronteggiare l’onda nera, chiederanno ai comunisti italiani di tornare insieme ai socialisti, che nel frattempo hanno espulso Turati. Sa che Bordiga non ne vuole sapere, Nenni neppure, e a lui toccherà tentare mediazioni impossibili. Per di più, anche il clima di Mosca non è per niente piacevole: fame per le strade, caldo afoso nell’aria e l’apprensione per la salute di Lenin, che una settimana prima ha avuto un colpo apoplettico.
Il risultato è che s’ammala pure Gramsci, tanto che a luglio lo mandano a riprendersi in un bel sanatorio alla periferia della città. Qui conosce Evgenija Šucht, segretaria di Nadja Krupskaja, figlia di un vecchio amico di Lenin e ricoverata per una paresi alle gambe. Ma soprattutto conosce sua sorella Julja, nata a Ginevra, vissuta a Roma e diplomata in violino al conservatorio di Santa Cecilia.
Sul colpo di fulmine che scocca in quei giorni d’estate tra Antonio e Julja/Giulia sono state scritte decine di pagine, ma soltanto due studiose – almeno a nostra conoscenza – si sono occupate dei risvolti “bogdanoviani” della loro relazione. Sono Maria Luisa Righi (Gramsci a Mosca tra amori e politica (1922-1923), in «Studi Storici», a. 52, 2011, 4, pp. 1005-1008) e soprattutto Noemi Ghetti, nel suo libro La cartolina di Gramsci. A Mosca, tra politica e amori, 1922-1924 (Donzelli, 2016).
 Molti lettori di Proletkult hanno notato una certa somiglianza “di famiglia” tra le idee di Bogdanov sulla “cultura proletaria” e quelle di Gramsci sull’egemonia. Eppure il legame tra i due non è mai stato oggetto di indagini approfondite. Nel 1981 un’altra studiosa, Zenovia Sochor, pubblicò un articolo intitolato Was Bogdanov Russia’s answer to Gramsci? (in «Studies in Soviet Thought», vol. 22, n.1, feb. 1981, pp. 59 – 81). Ecco un breve estratto dalle pagine introduttive:
Molti lettori di Proletkult hanno notato una certa somiglianza “di famiglia” tra le idee di Bogdanov sulla “cultura proletaria” e quelle di Gramsci sull’egemonia. Eppure il legame tra i due non è mai stato oggetto di indagini approfondite. Nel 1981 un’altra studiosa, Zenovia Sochor, pubblicò un articolo intitolato Was Bogdanov Russia’s answer to Gramsci? (in «Studies in Soviet Thought», vol. 22, n.1, feb. 1981, pp. 59 – 81). Ecco un breve estratto dalle pagine introduttive:
«Da un punto di vista cronologico, com’è ovvio, Bogdanov precede Gramsci, ed è del tutto possibile, sebbene difficile da provare, che Gramsci avesse familiarità con le idee di Bogdanov. Le due scuole di Partito organizzate da Bogdanov nel 1909-11 si tennero a Bologna e Capri; di conseguenza, qualcosa del lavoro di Bogdanov era probabilmente noto nei circoli del Partito italiano. Uno specifico punto di contatto si ebbe nel 1920, quando una delegazione italiana prese parte a un incontro, a Mosca, subito dopo il secondo congresso del Comintern, per stabilire un ufficio internazionale del Proletkul’t. Infine, Gramsci visse a Mosca tra maggio 1922 (in realtà giugno – NdWM2) e dicembre 1923, e fu senza dubbio informato di alcune tendenze e dibattiti all’interno del Partito bolscevico».
L’autrice prosegue affermando che il tema del suo articolo non è tanto l’eventuale contatto diretto tra le idee di Bogdanov e il pensiero di Gramsci, quanto piuttosto il loro parallelo sviluppo.
Tuttavia, proprio in quell’anno, compariva un saggio del grande storico italiano Cesare Bermani, dove quell’eventuale contatto veniva ampiamente testimoniato (Breve storia del Proletkul’t italiano, in «Primo maggio», 16, 1981/82, pp. 27-40). Lo stesso autore, già nel 1979, aveva affrontato la “quistione bogdanoviana” – che evidentemente gli stava a cuore – in un articolo su temi solo in apparenza distanti (C. Bermani, “Letteratura e vita nazionale. Le osservazioni sul folclore”, in AA.VV, Gramsci, un’eredità contrastata, Ottaviano, 1979).

Bermani afferma senza mezzi termini che «soltanto ragioni dogmatiche hanno impedito di cogliere appieno il profondo e duraturo influsso del Proletkùlt sull’elaborazione gramsciana, del resto chiaramente avvertibile da chiunque scorra le annate de “L’Ordine Nuovo”, sia settimanale sia quotidiano. Nel periodo 1920-22 l’adesione gramsciana alla tesi del Proletkùlt è infatti totale. Ci sarebbe quindi di che stupirsi che soggiornando in Unione Sovietica dal maggio 1922 al
novembre 1923 Gramsci non avesse cercato di conoscere più da vicino le idee che sorreggevano l’elaborazione del Proletkùlt, tanto più che il dibattito attorno alla cultura borghese e proletaria, alla necessità di avvalersi di specialisti borghesi, assumeva in quel periodo in Urss toni accesi e la polemica tra i fautori del Proletkùlt e lo stesso Lenin tendeva a inasprirsi».
Secondo Bermani, «la simpatia di Gramsci per gli scritti di Lunačarskij è ampiamente documentata. E se non è stato dimostrato che l’opera di Bogdanov abbia avuto su di lui una influenza diretta, tuttavia alcuni studiosi hanno riscontrato nei Quaderni dal carcere una serie di posizioni e argomentazioni coincidenti con l’elaborazione bogdanoviana».
In particolare, argomenti comuni ai due pensatori sarebbero l’organizzazione scientifica del lavoro, la teoria del partito come scienza dell’organizzazione, il superamento della divisione tra “materia” e “spirito”, frutto della divisione del lavoro capitalista, l’importanza di formare intellettuali organici alla classe, l’egemonia come farsi di una nuova cultura, la critica a un certo marxismo “positivista” di stampo ottocentesco e il concetto di “esperienza socialmente
organizzata”. Bermani cita, in proposito, la relazione tenuta da B. Jarosevskij al convegno gramsciano di Mosca (1967) e il libro del tedesco C.Riechers, Antonio Gramsci. Il marxismo in Italia, Thélème, 1975. Quindi riporta alcuni scritti gramsciani del ’17-’18, dove la questione della cultura viene affrontata con affermazioni che sembrano prese pari pari dal compagno Lunačarskij.
Nel dicembre ’17, sulle pagine piemontesi de L’Avanti! si discute la proposta di istituire a Torino un’associazione di cultura socialista. Gramsci interviene sostenendo che «esistono dei problemi filosofici, religiosi, morali, che l’azione politica ed economica presuppone, senza che gli organismi politici ed economici possano in sede propria discuterli. L’associazione sarebbe la sede propria della discussione di questi problemi».
Il 1° giugno 1918, su Il Grido del Popolo, Gramsci ricorda che nel dibattito per «l’istituzione di una Associazione proletaria di cultura […] la redazione torinese dell’Avanti! aveva posto il problema negli stessi termini di Lunačarskij». Il riferimento è a un articolo dello stesso Lunačarskij, pubblicato poche pagine più in là. E dalla sua lettura si deduce che Gramsci era al corrente, almeno in parte, della polemica tra Lenin e i proletkultisti, schierandosi apertamente con questi ultimi.
Di nuovo su L’Avanti!, nel giugno 1920, Gramsci si chiede: «È possibile già da oggi identificare gli elementi che sviluppandosi porteranno alla creazione di una civiltà (e di una cultura) proletaria? Esistono di già elementi per un’arte, per una filosofia, per una morale (per un costume) propri della classe operaia? E’ un perditempo occuparsi di questi problemi?». L’ultima domanda è ovviamente retorica.
Ma ormai Gramsci, da più di un anno, ha fondato una sua rivista, L’Ordine Nuovo (sottotitolo: rassegna settimanale di cultura socialista), ed è su quelle pagine che dobbiamo spostare l’attenzione per proseguire la ricerca.
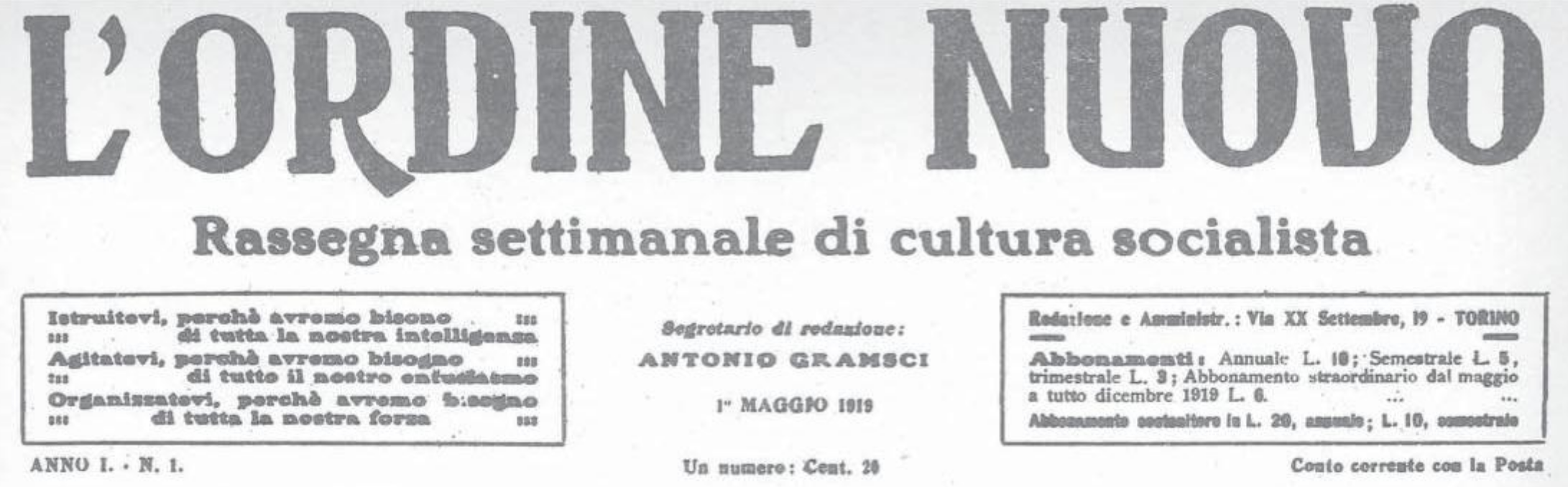
I numeri dell’Ordine Nuovo settimanale si possono consultare on line in formato digitale. Cercando l’espressione “cultura proletaria”, si trovano, nell’ordine:
– un articolo (non firmato) in cui Gramsci propone di creare dei “soviet di cultura proletaria” dove stimolare gli operai a “farsi una concezione del mondo” («Cronache dell’Ordine Nuovo», 12 luglio 1919).
– Un lungo reportage intitolato «Il “Proletkult” russo» e firmato da “un compagno russo” (12 giugno 1920).
– Una testimonianza in cui Gramsci ricorda la fondazione della nuova rivista: «L’unico sentimento che ci unisse, in quelle nostre riunioni, era quello suscitato da una vaga passione di una vaga cultura proletaria» («Il programma dell’Ordine Nuovo», 14 agosto 1920).
– Un testo di Lunaciarski (sic) dal titolo «Cultura proletaria» (28 agosto 1920).
– Il manifesto del Kultintern, l’Ufficio Internazionale di Cultura Proletaria (firmato, per l’Italia, da Nicola Bombacci) («Per la cultura degli operai», 16 ottobre 1920).
– Un articolo di Gramsci (non firmato), dove di nuovo si menziona il Commissario del Popolo all’Istruzione Anatolij Lunačarskij («Cronache dell’Ordine Nuovo», 11 dicembre 1920):
«Il movimento di Cultura proletaria, nel significato rivoluzionario che a questa espressione ha dato in Russia il compagno Lunačarskij […] tende alla creazione di una Civiltà nuova, di un nuovo costume, di nuove abitudini di vita e di pensiero, di nuovi sentimenti: tende a ciò promuovendo, nella classe dei lavoratori manuali e intellettuali, lo spirito di ricerca nel campo filosofico e artistico, nel campo dell’indagine storica, nel campo della creazione di nuove opere di bellezza e di verità».
Nel frattempo, in Russia, sono iniziate le manovre per soffocare l’autonomia del Proletkul’t, trasformandolo in una delle tante istituzioni educative del Narkompros, il ministero dell’Istruzione. Il 1° dicembre 1920, la Pravda ha pubblicato il decreto «Sui Proletkul’t», emesso dal comitato centrale del Partito. L’autonomia dell’organizzazione ispirata da Bogdanov, viene criticata come tentativo piccolo-borghese di creare un istituto estraneo al potere sovietico. Un covo di futuristi, decadenti e idealisti, dove filosofi contrari alle idee di Marx cercano di manipolare i lavoratori con i loro “sistemi” e la costruzione di Dio. Il Partito non è intervenuto prima perché impegnato da altre emergenze, ma ora che la guerra civile è terminata, intende prendere in mano la situazione.
A metà dicembre, si dimette il presidente nazionale del Proletkul’t, Pavel Lebedev-Poljanskij e al suo posto viene nominato Valerian Pletnev, favorevole alle direttive del Partito e all’assorbimento nel Narkompros. Inizia così il canto del cigno del Proletkul’t: con l’avvio della NEP gli vengono tagliati i fondi, gli iscritti diminuiscono, Bogdanov non è riconfermato nel gruppo dirigente e nel novembre del 1921 dà le dimissioni da ogni incarico, poco prima di partire per Londra con il suo vecchio amico Leonid Krasin.
 Quante di queste notizie giungono in Italia, e in particolare alle orecchie di Antonio Gramsci, che come abbiamo visto era già abbastanza informato della diatriba tra bolscevichi sul ruolo (e la priorità) della cultura?
Quante di queste notizie giungono in Italia, e in particolare alle orecchie di Antonio Gramsci, che come abbiamo visto era già abbastanza informato della diatriba tra bolscevichi sul ruolo (e la priorità) della cultura?
Per rispondere, abbiamo sempre le pagine dell’Ordine Nuovo, anche se non possiamo più consultarle in formato digitale, perché la scansione on-line riguarda solo l’edizione settimanale, mentre dal 1° gennaio 1921, la testata si trasforma in quotidiano, e dal 21 gennaio diventa il «quotidiano del Partito Comunista».
Bisogna quindi sfogliare l’edizione anastatica in quattro volumi, pubblicata nel 1972 da Editori Riuniti, per imbattersi, nelle primissime pagine, alla data del 6 gennaio, nel programma dell’Istituto della Cultura Proletaria, steso dal compagno Zino Zini:
«Non basta – si legge nel documento – che la classe lavoratrice maturi la sua coscienza politica nella dura esperienza della lotta quotidiana, diretta e controllata dall’organo adeguato a questo ufficio, che è appunto il Partito socialista. […] Il proletariato non potrà aspirare alla propria redenzione, e molto meno assicurarsi i frutti della sua vittoriosa affermazione politica ed economica, se prima non crea per se stesso un modello nuovo di educazione, che sia l’espressione spontanea, diretta, immediata dei suoi bisogni, delle sue aspirazioni, del suo ideale di civiltà e di umanità».
Il 12 gennaio compare l’annuncio “a tutte le organizzazioni proletarie” dell’assemblea “per la definitiva costituzione dell’Istituto di Coltura Proletaria (sic).” Il giorno seguente si tiene la riunione, nel salone sotterraneo della Camera del Lavoro. I convenuti approvano lo statuto ed eleggono il Comitato provvisorio. Il primo nome dell’elenco è quello di Antonio Gramsci.
 Le prime iniziative sono concerti di musica classica e canto popolare. Il 27 febbraio si tiene “un contraddittorio sul compito e la funzione degli intellettuali”, al quale partecipa Giuseppe Prezzolini, “quale rappresentante degli intellettuali “senza partito”, di coloro cioè che nel caos degli avvenimenti storici credono basti avere come punto d’orientamento l’amore per la verità e la ricerca delle soluzioni tecniche dei diversi problemi che si presentano nell’attività politica degli uomini”. Gli altri relatori sono Mario Montagnana, Giovanni Casale, Luigi Cattaneo e Zino Zini, chiamati a rispondere a domande come: “Esiste una classe degli intellettuali? Esiste una cultura proletaria?”. Il 10 marzo viene pubblicata “la riproduzione del significativo disegno che porterà la tessera del nostro Istituto di Cultura Proletaria”. L’inizio di attività regolari è dato per imminente, suddivise tra educazione fisica (ginnastica) e intellettuale (arte, scienza, politica). Nel frattempo, è prevista una visita al Museo d’Arte Antica e d’Arte Applicata all’Industria, quindi al museo del Libro e al Borgo Medievale del Valentino. Queste
Le prime iniziative sono concerti di musica classica e canto popolare. Il 27 febbraio si tiene “un contraddittorio sul compito e la funzione degli intellettuali”, al quale partecipa Giuseppe Prezzolini, “quale rappresentante degli intellettuali “senza partito”, di coloro cioè che nel caos degli avvenimenti storici credono basti avere come punto d’orientamento l’amore per la verità e la ricerca delle soluzioni tecniche dei diversi problemi che si presentano nell’attività politica degli uomini”. Gli altri relatori sono Mario Montagnana, Giovanni Casale, Luigi Cattaneo e Zino Zini, chiamati a rispondere a domande come: “Esiste una classe degli intellettuali? Esiste una cultura proletaria?”. Il 10 marzo viene pubblicata “la riproduzione del significativo disegno che porterà la tessera del nostro Istituto di Cultura Proletaria”. L’inizio di attività regolari è dato per imminente, suddivise tra educazione fisica (ginnastica) e intellettuale (arte, scienza, politica). Nel frattempo, è prevista una visita al Museo d’Arte Antica e d’Arte Applicata all’Industria, quindi al museo del Libro e al Borgo Medievale del Valentino. Queste
gite sono seguite spesso dall’istituzione di premi per chi ne scriverà una relazione. Nel caso del museo d’Arte, l’Istituto invita i partecipanti a inviare “la fissazione in disegno di un dato oggetto, la riproduzione di uno stile, di un merletto, ecc., ciò che potrà anche venire formando a sua volta una interessante raccolta proletaria di arte moderna applicata, a dimostrazione della nostra forza creativa.”
 Il 15 aprile parte un corso regolare e gratuito di pronto soccorso, in 15 lezioni, con diploma finale. Scopo dell’iniziativa è avere un buon numero di compagni capaci di medicare i feriti negli scontri con i fascisti. Ma i partecipanti non hanno ancora seguito tre lezioni, quando il tornitore Torrero finisce con la testa spaccata per aver difeso Gramsci da un’aggressione (21 aprile), preludio all’incendio della Camera del Lavoro di corso Siccardi 12, oggi Galileo Ferraris (25-26 aprile 1921).
Il 15 aprile parte un corso regolare e gratuito di pronto soccorso, in 15 lezioni, con diploma finale. Scopo dell’iniziativa è avere un buon numero di compagni capaci di medicare i feriti negli scontri con i fascisti. Ma i partecipanti non hanno ancora seguito tre lezioni, quando il tornitore Torrero finisce con la testa spaccata per aver difeso Gramsci da un’aggressione (21 aprile), preludio all’incendio della Camera del Lavoro di corso Siccardi 12, oggi Galileo Ferraris (25-26 aprile 1921).
In questo clima di violenza, con le elezioni di maggio ormai alle porte, le notizie sull’ICP si fanno molto più rare. Se ne riparla il 2 giugno, con la fine della scuola di pronto soccorso e la distribuzione delle tessere, individuali e collettive.
Il 9 e 27 ottobre, il giornale pubblica in due parti un lungo articolo di “A. Bogdanof”, La poesia proletaria (ovvero A. Bogdanov, Cto takoe proletarskaja poezija? [Che cos’è la poesia proletaria?], in “Proletarskaja Kul’tura”, 1, luglio 1918). Nella sterminata bibliografia bogdanoviana, compilata da J. Biggart e altri, questa risulta essere la prima traduzione in italiano di un testo di Bogdanov. Di certo, almeno questo, dev’essere stato tra le letture di Gramsci. Ma non è l’unico, come vedremo…
A metà novembre, viene nominato il nuovo Comitato Centrale dell’Istituto. Con l’occasione, esce sull’Ordine Nuovo un bilancio delle attività e dei programmi per il futuro, che diventa la base di un lungo report sul primo anno di vita, pubblicato a gennaio del ’22 su Gorn (Fornace), l’organo ufficiale del Proletkul’t di Mosca.
È significativo che nelle premesse generali, i proletkultisti torinesi insistano ad affermare che la coscienza dei lavoratori non può formarsi solo nella lotta di classe, che il Partito non è una scuola sufficiente, e che la cultura dev’essere un ambito autonomo, da aggiungere alle altre tre forme di attività del proletariato (politica, lavoro, economia), allo scopo di plasmare quei valori spirituali che danno un senso alla vita e la rendono degna di essere vissuta. Una serie di concetti che sarebbero piaciuti a Lunačarskij e Bogdanov, ma che in Urss – come abbiamo visto – erano stati messi da parte almeno un anno prima, su insistenza di Lenin.
Non si sa chi abbia scritto la relazione per Gorn, ma a prescindere da questo, se ne ricavano informazioni importanti.
– L’ICP ha organizzato una “scuola sindacale comunista”, della durata di un trimestre. Gli iscritti sono stati 50, 20 dei quali hanno retto fino alla fine, in un seminterrato umido e freddo, con scarso materiale didattico e insegnanti poco preparati. Questi erano per lo più “operai diventati organizzatori” e insegnavano “struttura sindacale, controllo dell’industria, salario, carovita, ferie, malattie, disoccupazione, mutualismo, cooperazione, infortuni, storia del movimento operaio, preparazione politica”. Materie che appaiono in effetti molto più “sindacali” di quelle proposte dalle Scuole di Partito vperediste di Capri e Bologna o dai circoli del Proletkul’t sovietico.
 – L’ICP pubblicherà, a partire da gennaio ’22, un bollettino mensile intitolato Proletcult (ma in un altro articolo dell’ON viene chiamato Proletkult o Prolet-Kult) e si dice che “il numero di gennaio è già composto”. Poi però viene annunciato un ritardo “per motivi di organizzazione tecnica”. Infine, non se ne sente più parlare e le testimonianze orali raccolte in merito da Bermani sono discordanti: c’è chi sostiene che ne uscì un solo numero e chi giura che rimase una chimera.
– L’ICP pubblicherà, a partire da gennaio ’22, un bollettino mensile intitolato Proletcult (ma in un altro articolo dell’ON viene chiamato Proletkult o Prolet-Kult) e si dice che “il numero di gennaio è già composto”. Poi però viene annunciato un ritardo “per motivi di organizzazione tecnica”. Infine, non se ne sente più parlare e le testimonianze orali raccolte in merito da Bermani sono discordanti: c’è chi sostiene che ne uscì un solo numero e chi giura che rimase una chimera.
– L’ICP intende sviluppare un programma di educazione fisica, che ancora non è davvero partito.
– Infine, l’Istituto lancerà un concorso letterario, dove i lavoratori potranno presentare le proprie idee in qualunque forma, purché assomigli in linea di massima a una novella (Qualcosa di molto simile al concorso indetto dalla FIOM milanese nel 1963, di cui abbiamo parlato in Meccanoscritto).
Il concorso viene indetto il 17 gennaio. Da articoli successivi, si apprende che i racconti cominciarono ad affluire numerosi e che ancora erano sotto esame nel pieno dell’estate. Non vennero però mai pubblicati e dove siano finiti non lo sa nessuno.
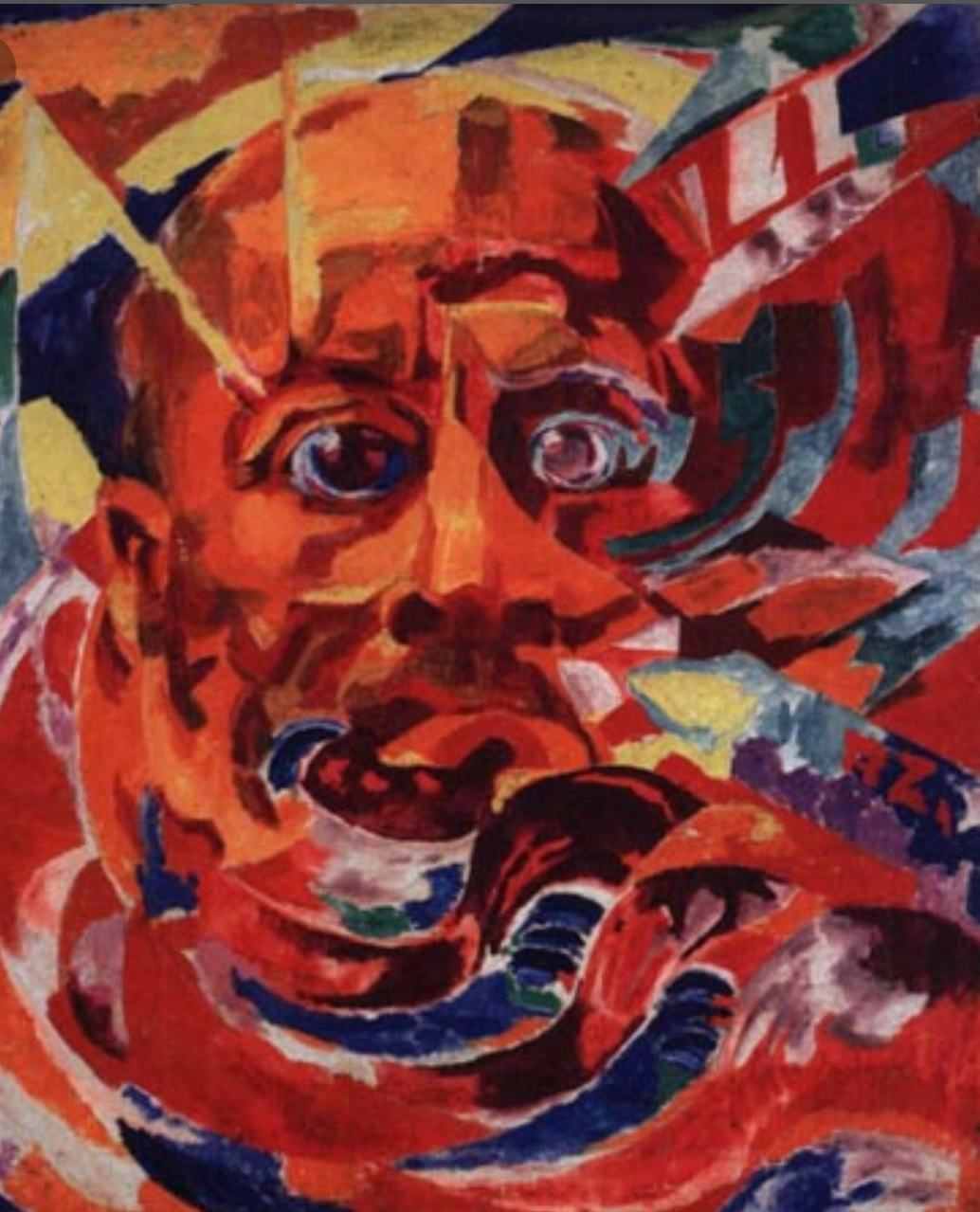
Intanto, sul versante delle “gite d’istruzione”, il 2 aprile 1922, gli iscritti all’ICP visitano la Mostra Internazionale d’Arte Futurista, con una guida d’eccezione: Filippo Tommaso Marinetti, già additato da Lunačarskij come “intellettuale rivoluzionario”. Proprio per questo, Gramsci si era occupato di lui in un articolo uscito in gennaio, dove s’interrogava sul perché “molti gruppi di operai hanno visto simpaticamente (prima della guerra europea) il futurismo”. La sua risposta è che “i futuristi hanno svolto questo compito nel campo della cultura borghese: hanno distrutto, distrutto, distrutto […]; hanno avuto la concezione netta e chiara che l’epoca nostra, l’epoca della grande industria, della grande città operaia, della vita intensa e tumultuosa doveva avere nuove forme di arte, di filosofia, di costume, di linguaggio […] I futuristi, nel loro campo, nel campo della cultura, sono rivoluzionari”. Poco sopra, con toni decisamente bogdanoviani, spiega che una fabbrica, in mano agli operai, verrà riorganizzata, ma continuerà a produrre le stesse cose, mentre non si può dire altrettanto per la poesia, il dramma, il romanzo, la musica. “In questo campo, nulla è prevedibile che non sia questa ipotesi generale: – esisterà una cultura (una civiltà) proletaria, totalmente diversa da quella borghese”. E per vederla sorgere, “cosa resta da fare? Nient’altro che distruggere la presente forma di civiltà”, tenendo ben presente che “in questo campo distruggere […] significa distruggere gerarchie spirituali, pregiudizi, idoli, tradizioni irrigidite, significa non aver paura dei mostri, non credere che il mondo caschi se una poesia zoppica, se un quadro assomiglia a un cartellone, se la gioventù fa tanto di naso alla senilità accademica e rimbambita”.
La visita alla mostra futurista è una delle ultime iniziative pubbliche dell’ICP prima della partenza di Gramsci per Mosca. In una lettera a Trockij del novembre ’22, scritta dalla capitale sovietica, Gramsci ricorda quella giornata, sostenendo che Marinetti espresse “la sua soddisfazione per essersi potuto convincere che in fatto d’arte futurista gli operai hanno molta più sensibilità della borghesia.”
Dopodiché, Gramsci passa la frontiera tra Lettonia e Russia, prende una stanza all’Hotel Lux, lavora negli uffici del Comintern a Villa Berg, sull’Arbat, si ammala, va in sanatorio, conosce le sorelle Šucht.
Tra il 10 e l’11 ottobre ’22, Giulia scrive e riscrive più volte una lettera al “professore”, e infine gliela invia. Le minute sono state pubblicate in appendice all’Epistolario gramsciano, nel 2009, ma è stata Noemi Ghetti, nel suo libro del 2016, a metterne in evidenza un passaggio:
«Ho cominciato a «tradurre» il romanzo di Bogdanoff. Scrivo senza rileggere… che è una tortura. Lei prenderà un’arrabbiatura a maneggiare le «mie» parole. Ma tanto i professori sono fatti per questo ed io, prima di vedere la Sua firma sotto alla traduzione, debbo rassegnarmi ad avere i capelli strappati e… Nasconderò il bastone!»
Quindi Gramsci, appena quattro mesi dopo il suo arrivo in Unione Sovietica, e nemmeno tre mesi dopo aver conosciuto Giulia, già le aveva proposto una traduzione collettiva di Stella Rossa (guarda caso, è a quattro mani anche l’ultima traduzione italiana del “romanzo di Bogdanoff”, a cura del Kollektiv Ulyanov). Come detto, Gramsci non era certo all’oscuro delle polemiche tra Lenin e Bogdanov, e a maggior ragione doveva saperne qualcosa in quel momento. Angelo Tasca, tra i fondatori dell’ON, ricorda di aver assistito insieme a Gramsci, ad “alcune sedute del Proletcult”, ai tempi del IV Congresso dell’Internazionale (novembre 1922).

Nel frattempo, mentre Gramsci è a Mosca, L’Ordine Nuovo continua a dare notizie sull’ICP. Poco dopo la partenza del direttore, esce Dinamite, una raccolta di undici "poesie proletarie", scritte da tre giovani "futuristi" (battezzati collettivamente 1+1+1=1). La plaquette, di 34 pagine, viene pubblicata come "edizione dell'Istituto di Cultura Proletaria" e il ricavato delle vendite è a favore delle "vittime politiche". I tre autori sono Luigi Colombo (che dal '24 si farà chiamare Fillìa), Jean Pasquali e Antonio Galeazzi (due “legionari dannunziani”, come li definì Giovanni Casale in un ricordo affidato a Cesare Bermani). Il libretto riceve una durissima stroncatura sul quotidiano Il Comunista, organo centrale del PCd'I. Eppure, a settembre, lo stesso partito crea ufficialmente la Sezione Italiana del Proletkul’t, e nomina Gramsci - a distanza - nel Comitato Centrale Provvisorio. Ma sebbene l’ON pubblichi in due puntate I principi generali della nuova istituzione, essa non sembra essere andata molto oltre. Un mese più tardi, con la Marcia su Roma, lo spazio per dedicarsi ad attività culturali diventa sempre più angusto. Proprio tre giorni prima della sfilata fascista, Gramsci incontra Lenin in privato, faccia a faccia. Chissà se hanno anche discusso di cultura proletaria...
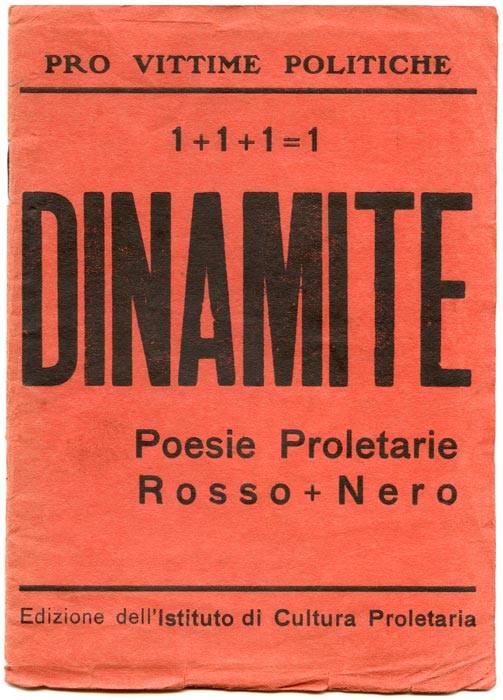
Nel gennaio 1923, Gramsci si prepara a lasciare l’Unione sovietica. Scrive a Giulia un lunga lettera di commiato e tra le altre cose le chiede: “E la sua traduzione? Me la spedisca, se ultimata: la farò pubblicare in Italia.”
A differenza dei curatori dell’Epistolario di Gramsci, Noemi Ghetti è convinta che qui si stia parlando del “romanzo di Bogdanoff”, così come in una lettera del 13 febbraio: “E la traduzione? Perché non me l’ha consegnata? Ho saputo che l’aveva con sé”. Tra le due missive, si inserisce la decisione di Gramsci di restare a Mosca, perché in Italia lo attende un mandato d’arresto.
Si arriva così al 23 settembre 1923, quando Antonio Gramsci e Julja Šucht si sposano (anche se ci sono parecchi dubbi sull’autenticità del loro certificato di matrimonio). A fine novembre, Gramsci lascia l’Unione Sovietica e si trasferisce a Vienna. Eletto alla Camera dei Deputati il 6 aprile 1924, a maggio rientra in Italia, protetto dall’immunità parlamentare. In questo frangente gli scrive da Mosca Umberto Terracini, che l’ha sostituito come delegato al Comintern e ha rintracciato alcune sue carte, tra le quali “il romanzo russo di cui curasti la traduzione colla traduzione”.
Sia Ghetti che Righi, deducono da questo riferimento che l’impresa a quattro mani di Antonio & Giulia doveva essere giunta a compimento.
Chissà poi se Terracini spedì il plico in Italia, o da qualche altra parte, o se lo ritrovò al suo posto lo stesso Gramsci, quando ritornò a Mosca nel 1925, o ancora se glielo portò Giulia, quando passò dall'Italia, insieme al figlio Delio Šucht-Gramsci, nato a Mosca il 10 agosto '24 (e quindi concepito a novembre , poco prima della partenza del padre).

Fatto sta che quei fogli sono spariti, non se ne sa più nulla, e così la prima traduzione italiana di Stella Rossa – parziale o completa – è rimasta nel cassetto. Sarebbe stata una delle prime a occidente dell’ex-impero zarista, dopo quella francese del 1913/14 (pubblicata sulla rivista La Societé Nouvelle) e quella tedesca del 1923 (per le edizioni dell’Internazionale giovanile). Sparita, smarrita o distrutta quella, abbiamo dovuto attendere fino al 1988 per poter leggere Stella Rossa nella lingua di Dante (e di Gramsci).
Eppure il mistero rimane. Dov’è finita la traduzione del «romanzo di Bogdanoff» a cura di Antonio e Julja? (E dove sono finiti i racconti operai del concorso lanciato su L’Ordine Nuovo il 17 gennaio 1922? E dov’è finito il primo numero della rivista Proletcult, che doveva uscire – e forse è uscito – quello stesso mese?)
Domande che forse non avranno mai risposta, se non tra le pagine di un giallo, ma intanto il legame tra Bogdanov, il Proletkult e Gramsci ci appare ben più che una semplice ipotesi narrativa.
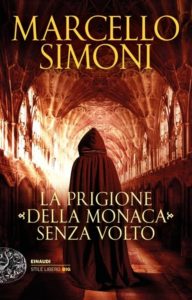
È forse il romanzo in cui mi sono messo più in gioco e questo perché siamo nel Seicento milanese, in un pieno clima manzoniano. Ho dovuto fare i conti con personaggi già nei Promessi sposi. Marcello Simoni
Con La prigione della monaca senza volto, torna nelle librerie l’inquisitore Girolamo Svampa, personaggio creato dal maestro del thriller storico Marcello Simoni: un frate non per vocazione ma per vendetta, che predilige la ragione alla superstizione e che, in questo capitolo, sentirà le sue certezza vacillare.
Lo Svampa si trova nella Milano manzoniana, in piena dominazione spagnola e segnata dalla clausura femminile, anno del Signore 1625. Il protagonista si imbatte in alcuni cadaveri di donna pietrificati. Fra rapimenti, vecchi e nuovi nemici, Simoni decide di confrontarsi anche con due personaggi storici, la Monaca di Monza e il cardinale Federigo Borromeo:
«Nel nuovo thriller storico, La prigione della monaca senza volto, Marcello Simoni coinvolge nella trama i personaggi Manzoniani. Osa, ma il risultato finale è felice, perché l’autore contemporaneo rende omaggio all’illustre predecessore, ma resta Simoni. E fa quello che sa fare meglio: costruisce una narrazione ricca di enigmi e colpi di scena, piena di dettagli storicamente accurati e dal ritmo avvincente, in cui i personaggi dei Promessi sposi diventano pedine, al pari degli altri protagonisti, dell’ingranaggio. Con in più il piacere e la curiosità, per il lettore appassionato del genere, di ritrovarsi, in una veste nuova, figure diventate classiche» (Alessia Rastelli, «la Lettura – Corriere della Sera»).
Una vicenda sconvolgente che metterà a dura prova le capacità dell’inquisitore e i suoi convincimenti, capace di coinvolgere il lettore fino al finale, «ma Simoni disegna un ritratto altrettanto affascinante e documentato di una Milano torbida e decadente, sotto la dominazione spagnola (l’anno dei fatti è il 1652): le porte, la darsena, i bacini, i Navigli allora aperti, tra i quali i personaggi si rincorrono da un nascondiglio all’altro» (Alessia Rastelli, «la Lettura – Corriere della Sera»).
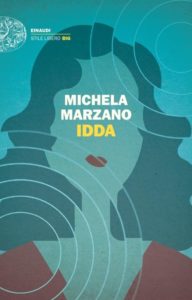
Annie è ricoverata in una residenza protetta, il suo mondo è ormai una stanza, la 315. Il passato sta scivolando via, mescola gli anni, i luoghi, le stagioni. Poco importa se sia Alzheimer o demenza senile, i ricordi stanno sparendo, sembra aver bisogno solo d'amore.
Alessandra, compagna di suo figlio Pierre, la assiste, la ascolta. È professoressa universitaria di Biologia. Ha abbandonato a ventitré anni la Puglia, quando il suo mondo si era sbriciolato: era fuggita, dopo la morte della madre, per non tornare mai più. Ha chiuso la porta ai ricordi, ha costruito la sua vita professionale e affettiva a Parigi, «Punto e daccapo» come diceva sua madre. Si è sempre detta che l'importante è il presente ma, mentre cala il sipario nei ricordi di Annie, mentre con Pierre riordina la sua casa tra oggetti da buttare e altri da conservare, sente riemergere parole e memorie che, né la lingua francese, né il lavoro e l'amore per Pierre sono riusciti a cancellare.
Poco importa che il racconto contenga spunti autobiografici perché poi diventa storia universale che evoca il male di tutti. Simonetta Fiori, «la Repubblica»
In modo toccante l’autrice offre al lettore una storia intensa, affronta il tema della perdita, della rielaborazione dei nostri lutti, del bisogno di portare alla luce ciò che si pensava di aver sepolto per sempre; ma torna ad affrontare anche il tema dell’amore, «fil rouge che lega tutti i miei libri. Perché, se è vero che ognuno di noi è caratterizzato dalle fragilità e dal vuoto, è anche vero che ognuno di noi riesce a sopravvivere grazie alla forza dell’amore. Per me l’amore è il reciproco riconoscimento. Essere riconosciuti dagli altri per quello che siamo e riconoscere gli altri per quello che sono. Così si creano dei legami capaci di darci la forza di attraversare i vuoti della nostra esistenza e curare le ferite che la vita ci infligge» (Michela Marzano intervistata da Brunella Schisa, «il venerdì – la Repubblica»).
Michela Marzano ci consegna il ritratto indimenticabile di due donne che trovano inaspettatamente l'una nell'altra ciò che avevano perduto, «e poco importa che il racconto contenga spunti autobiografici perché poi diventa storia universale che evoca il male di tutti» (Simonetta Fiori, «la Repubblica»).
«Trovare le parole per l’amore, nominare i sentimenti, è la specialità di Michela Marzano […] è quello che fa, testardamente, da anni, nei libri e sui giornali ed è diventata bravissima proprio perché l’amore è una cosa che si impara provando e riprovando, finché non si trova il tono giusto per dire il legame misterioso che unisce uomini e donne o quello profondo, unico e totale che lega madri e figli» (Raffaella Silipo, «La Stampa»).
-
Si può guardare avanti senza voltarsi indietro? Nel caso della Shoah? Metterci una pietra sopra? Dimenticare, riconciliarsi, perdonare? No.pp. 96€ 12,00
-
Il crimine e il silenzio
«Un libro terribile e necessario... sull'oblio, sulla contaminazione della memoria, sul conflitto tra una verità facile e accomodante e la ben piú dura e sgradevole verità».
Julian Barnes
«Uno dei libri piú importanti e drammatici degli ultimi anni».
Ryszard Kapuscinski
«Un capolavoro del giornalismo storico. Una lettura...pp. 544€ 38,00 -
Riflessioni sulla questione antisemita
Uno strumento originale e indispensabileper comprendere e combattere l'odioantiebraico, scritto da una figura carismatica.pp. XVI - 120€ 14,00 -
Heimat
Miglior graphic novel 2018 per «The New York Times», «The Guardian» e «The Comics Beat».
Vincitore del National Book Critics Circle Award nella categoria Autobiografie.
Illustratrice dell'anno per il Moira Gemmill Prize del Victoria and Albert Museum.
Un modo geniale di fare i conti con il proprio...pp. 288€ 19,00 -
Per Primo Levi
Il saggio piú antico, Ciò che dobbiamo a Primo Levi, è del 1989; il piú recente, Il canto di Ulisse, è del 2018. Sono esattamente trent'anni che Pier Vincenzo Mengaldo, noto critico e storico della lingua italiana, studia i testi di Primo Levi, ne analizza...pp. XII - 176€ 20,00 -
I senza memoria
Nel 1938, Karl Schwarz, nonno paterno dell'autrice, approfittando delle leggi razziali naziste, rileva per pochi soldi la piccola azienda di un imprenditore ebreo, Julius Löbmann, e dopo la guerra per molto tempo rifiuta di pagargli il giusto risarcimento. È da questo episodio, taciuto e rimosso...pp. 344€ 21,00
-
Album Auschwitz
L'Album Auschwitz è il piú importante documento iconografico sui campi di sterminio: mostra le fotografie scattate dai nazisti nel maggio del 1944. Sono le immagini della selezione a cui erano sottoposti i prigionieri ebrei. L'album, ritrovato da una detenuta, è stato utilizzato come prova giudiziaria...pp. XII - 268€ 35,00 -
Dizionario dell’Olocausto
Questo dizionario è il lavoro collettivo di oltre cento autori di undici paesi, con l'aggiunta di saggi specifici dedicati alla peculiare situazione italiana.pp. XXXIV - 968€ 30,00 -
Storia degli ebrei
Ripercorrendo gli eventi tragici e i momenti gloriosi di un'avventura millenaria costellata di figure immortali, il volume reinterpreta la storia spesso misconosciuta di un popolo-mondo.pp. XIV - 824€ 34,00 -
Goetz e Meyer
Con questo romanzo di forte impatto emotivo e di evidente matrice autobiografica - anche 35 familiari dell'autore scomparvero nel nulla - David Albahari cerca di ricostruire un passato indicibile, di far fronte alla necessità di dare una figura, un corpo, agli esecutori del Male.pp. 120€ 10,50 -
Come si diventa nazisti
«La distruzione di una comunità politica, la fine della democrazia è sempre possibile - e oggi come allora gli avversari della democrazia stanno anche dentro di noi, nel perenne conflitto, ch'è a un tempo sociale e psichico, tra bisogno di sicurezza e desiderio di...pp. 320€ 13,50 -
-
-
Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia
«Chi sono? Dicono ora: un giudeo, adoperando in modo triviale un terminetanto stolto quanto vano».
Da una lettera di Vittorio Pisapp. LXXXII - 472€ 15,00 -
Voci dal lager
«Il crematorio fuma, non smette piú, fuma tutta la notte. L'odore nauseabondo di carne bruciata ammorba l'aria, prende alla gola, mi strozza, forse stanotte bruciano Ondina o Maria... Non le ho piú trovate».
Dal taccuino clandestino di Lidia Beccaria Rolfi, Ravensbrück.pp. XLIV - 463€ 14,00 -
Perché crediamo a Primo Levi?
«Quando diciamodi credere a Primo Levi, di prestar fede alle sueparole, che cosa esattamente ci sentiamo impegnatia ritenere vero? E, in secondo luogo: quali sonole ragioni del nostro atteggiamento? Su che cosa sifonda il credito che noi gli concediamo?»
Mario Barenghi, Perchè crediamo a Primo Levi?pp. 184€ 16,00 -
Una telefonata con Primo Levi
«Non sarebbe molto facile figurarseli vicini, cosídissimili nella complessione come sono, Primo Levie David Foster Wallace, se non li si vedesse, dischiena, passeggiare per un Lungo Po elisio e conversarein qualche loro lingua altrettanto oltremondanamentre due grossi cani corrono avanti e indietro,saltano, chiedono di giocare e li...pp. X - 208€ 16,00 -
-
-
Il ghetto di Varsavia
Il primo documento completo sulla piú immane tragedia che mai colpì una città nel corso della seconda guerra mondiale.pp. XXII - 316€ 12,00 -
Lo sterminio degli ebrei
Per Bloxham ladistruzione degli ebrei d'Europa è solo il punto di precipitazione finale,abominevole, di una storia di lunga durata dei genocidi e delle biopoliticherazziali e razziste, della polizia e della discriminazione etnica in cuiun'intera civiltà risulta coinvolta.pp. XXX - 410€ 28,00 -
Raccontare per la storia
Durante quarant'anni - l'arco che vada Se questo è un uomo a Il sistema periodico a I sommersi e i salvati -Levi ha affidato alla storia le sue narrazioni e le sue diagnosi eticopolitiche.Le raccoglie una storica, Anna Bravo, che lo intervistò nel1983 e che ci...pp. 224€ 18,00 -
Intervista a Primo Levi, ex deportato
«Nel campo avevo un quaderno,non piú di venti righe. Avevo troppapaura, il fatto stesso di scrivere erasospetto. Non erano appunti, era lavoglia di tenere appunti, tanto sapevoche non avrei potuto conservarenulla. Se non nella memoria».pp. XXVI - 122€ 10,00 -
«Fioca e un po’ profana». La voce del sacro in Primo Levi
Fioco e profano sono aggettivi che ritornano spessoin Primo Levi. «Fioco» non significa debole ofiacco, quanto piuttosto mite; ma anche tenue, sommesso,difficile da intercettare. «Profano» è l'inesperto, chi non ha una lungapratica in certe cose, il non-specialista. Il profanoè vagamente imparentato con il «dilettante», coluiche fa le...pp. XXIV - 240€ 20,00 -
Uomini comuni
Nuova edizione ampliataUno dei libri piú indispensabili mai scritti sulla Shoah, riproposto con una nuova lunga postfazione e numerose fotografie inedite.pp. XVI - 328€ 24,00 -
Esperimento Auschwitz
Narrare Auschwitz come se si trattasse di un esperimento mentale,simile a quelli proposti da Galileo o da Einstein: eccoL'operazione condotta da Primo Levi con Se questo è un uomoe, quarant'anni più tardi, con I sommersi e i salvati.pp. XII - 182€ 16,00 -
I campi del duce
«Un libro utile per sapere e per capire e finalmente per crescerenel segno di una memoria riconquistata».
Frediano Sessi
«Capogreco nel ricostruire il passato fornisce risposte esaurienti.Ma, cosa piú importante ancora, non elude domande».
Giorgio Boatti
«I campi del duce descrive cosa fu e come funzionò l'internamentoin Italia e nelle regioni jugoslave annesse, contro civiliitaliani e stranieri... Una violenza che il clima...pp. X - 344€ 14,00 -
Controllare e distruggere
Un saggio di esemplare chiarezza che ricostruisce in modo semprepreciso ed equilibrato il periodo piú tragico dell'età contemporanea.pp. XII - 244€ 22,00 -
La legge del sangue
Una cartografia integrale dei saperi e delle credenze che fecero da architravealla politica dello sterminio.pp. XII - 504€ 25,00 -
Il nazismo e l’Antichità
Il Terzo Reich nutrí per il mondo classico un'autentica venerazione, arrivando a teorizzare l'identità razziale di Greci, Romani e Germani, uniti in una stessa lotta millenaria. Tutti gli aspetti della falsificazione nazista della storia, alla ricerca di un'antichità immaginaria, monito e modello per plasmare un...pp. 536€ 34,00
-
-
Il complotto
Will Eisner, il padre del «graphic novel», racconta la storia documentata dei Protocolli in questo romanzo per immagini, un capolavoro finito di scrivere e disegnare a un mese dalla morte.pp. X - 146€ 16,00 -
Le regine dello swing
Tulipan, Maramao perché sei morto, Il pinguino innamorato: sono alcune delle canzoni del Trio Lescano, le tre ragazze olandesi che tra il 1936 e il 1943 scatenarono in Italia una rivoluzione musicale, importando lo swing americano vietato dal regime.pp. X - 118€ 12,00 -
Anne Frank – Diario
Un evento internazionale. Il primo graphic novel tratto dal libro che ha fatto conoscere la tragedia dell'Olocausto a milioni di ragazzipp. 160€ 15,00 -
-
Tutti gli scritti
A cura dell'Anne Frank Fonds di Basilea.
***
Storia, memoria e letteratura: per la prima voltain un unico volume tutti gli scritti di Anne Frank,testimone e scrittrice.pp. VI - 886€ 28,00 -
Racconti dell’alloggio segreto
La sensibile fantasia di una giovane scrittrice al cui talento il destino della storia concesse troppo poco tempo.pp. X - 170€ 9,80 -
Qui non ci sono bambini
Thomas Geve è poco più di un bambino quando vienedeportato ad Auschwitz: è uno dei più giovani internatidel campo. È nell'età in cui si inizia a conoscere meglioil mondo e a guardarsi attorno.
Il giorno della liberazione, nell'aprile del 1945, raccogliele poche residue forze per fissare su...pp. 186€ 24,00 -
“Sfacciata fortuna”. La Shoah e il caso
Con il saggio del critico inglese Robert Gordon prendono il via le «Lezioni Primo Levi», ideate dal Centro Internazionale di studi che si propone di promuovere la conoscenza del grande scrittore italiano nel mondo.pp. 136€ 15,00 -
-
Sei milioni di accusatori
Una requisitoria implacabile contro Eichmann.
E una drammatica ricostruzione dello sterminio nazista degli ebrei.pp. XXIV - 216€ 11,50 -
La distruzione degli Ebrei d’Europa
In 3 volumi
***
Il saggio piú importante mai apparso sullosterminio degli Ebreipp. XXXII - 1528€ 48,00 -
Comandante ad Auschwitz
Il volume, oltre alla prefazione di Primo Levi scritta nel 1958, contiene un articolo di Alberto Moravia e un'appendice storico-bibliografica a cura di Frediano Sessi.pp. XII - 278€ 13,00 -
-
-
Shoah
Per la prima volta in Italia l'opera definitiva sulla Shoah, il piú importante film mai realizzato sulla piú tragica esperienza dell'uomo moderno.pp. LIV - 316€ 38,00 -
I sommersi e i salvati
«Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre».
Primo Levipp. 208€ 13,00 -
Se non ora, quando?
Il primo vero romanzo dell'autore di Se questo è un uomo. Le avventure drammatiche di quei partigiani ebrei polacchi e russi che resero colpo su colpo a chi tentò di sterminarli.pp. 352€ 13,00 -
Se questo è un uomo
«Un magnifico libro che non è solo una testimonianza efficacissima, ma ha delle pagine di autentica potenza narrativa».
Italo Calvinopp. 232€ 13,00 -
-
La tregua
«Giunsi a Torino, dopo trentacinque giorni di viaggio: la casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava».
Primo Levipp. 240€ 13,00 -
Opere complete I-II
In 2 volumi
**
Con l'edizione di Se questo è un uomo del 1947, venticinque testi in piú nella sezione «Pagine sparse» e altri otto testi in appendice, fra i quali la tesi di laurea e le note di Levi alle edizioni scolastiche dei suoi libri.pp. CIV - 3496€ 160,00 -
Opere complete III
Nel 1961 Primo Levi risponde a un questionario di «Storia illustrata»: è la sua prima apparizione nella veste di intervistato su un giornale. Da allora al 1987, anno della morte, le sue interviste censite sono state oltre 300. Quelle piú ampie e piú rilevanti (circa...pp. XXXVI - 1384€ 85,00 -
Così fu Auschwitz
Le verità piú precise - e inesorabili perché precise- sulla macchina dello sterminio. Quarant'annidi testimonianze, in gran parte inedite, di essenzialeimportanza storica.pp. VI - 256€ 13,50
-
-
-
-
La lenta nevicata dei giorni
Fernande e André si sono fatti una promessa che è insiemeun gesto d'amore e di speranza: se sopravviverannoalle persecuzioni, torneranno insieme alla casasotto il faro. Non importa se il futuro che li aspetta èdiverso da quello che avevano immaginato. Il futuro èun tempo vivo, a...pp. 256€ 17,50 -
Goebbels
Il volume offre una nuova e importante visione su come il messaggio di odio nazista venne concepito, nutrito e diffuso, ma fa anche a brandelli il mito del genio propagandistico di Goebbels. Ci mostra un uomo perseguitato dalle insicurezze e, sebbene dotato di un controllo...pp. XXVI - 920€ 34,00 -
Verso la soluzione finale
La migliore e piú accurata storia della conferenza di Wannsee del 20 gennaio 1942, che decise la soluzione finale. Un'indagine sulla follia dottrinaria e omicida del nazismo.pp. VIII - 216€ 26,00 -
-
I bambini di Moshe
Una storia tragica e picaresca insieme, un'odissea di lutto e di riscatto, dai confini tanto larghi quanto l'intera storia degli ebrei sommersi e degli ebrei salvati.pp. 408€ 14,00 -
Il corpo del duce
Adorato dai fascisti, fucilato dai comunisti, profanato dalla folla, trafugato dai neofascisti, occultato dai democristiani: vivo o morto, il corpo del duce ha fatto storia nell'Italia del Novecento.pp. XIV - 360€ 14,00 -
L’infanzia nelle guerre del Novecento
«I bambini sono diventati sempre piú vittime, attori e spettatori dei processi sociali, in tempo di pace e di guerra. Non considerare il loro punto di vista, la loro esperienza, la loro memoria significa negarsi la comprensione di una parte importante della storia vissuta dalle...pp. X - 440€ 14,50 -
La Shoah dei bambini
Un libro che riattraversa «con occhi di bambino» le tragiche vicende della persecuzione antiebraica.pp. 344€ 13,00 -
Gli scomparsi
«Epico e intimo, ricco di riflessioni ma anche di tensione, tragico e al tempo stesso ironico. Gli scomparsi è semplicemente un libro meraviglioso».
Jonathan Safran Foerpp. 608€ 16,00 -
Primo Levi e i tedeschi
L'edizione tedesca di Se questo è un uomo avviòuna serie di contatti epistolari tra Primo Levie i suoi lettori in Germania. Lo studio di MartinaMengoni li ricostruisce e ne fa emergerel'importanza.pp. 232€ 20,00 -
Album Primo Levi
A trent'anni dalla scomparsa di Primo Levi, questo volume intende proporre al pubblico un originale ritratto, per testi e immagini, di una tra le figure piú complesse della letteratura e della cultura del Novecento.pp. 352€ 60,00 -
Risvegli nel buio
Quattro storie diverse, un unico destino: l'Olocausto proietta la sua lunga ombra sulle generazioni successive, e i figli delle vittime e degli aguzzini si trovano a fare i conti con un'identità complessa e problematica. Ogni pagina di questi splendidi racconti vibra del pathos della...pp. 264€ 15,50 -
Ausmerzen
Nella storia di uno sterminio non a tutti noto, primae dopo Auschwitz, era annidato il Dna di ognisoppressione di creature umane difettose, indifese,«vite indegne di essere vissute». Marco Paolinisi immerge in quelle tenebre e il suo raccontoporta in piena luce il modello nascosto dell'eliminazionedei deboli.pp. 168€ 11,00 -
W o il ricordo d’infanzia
«W o il ricordo d'infanzia è uno dei libri più profondi e commoventi che io abbia mai letto»
Paul Austerpp. LVIII - 240€ 19,00 -
Il libro della Shoah italiana
Nuova edizione.
***
«L'inferno... qualsiasi persona lo conosce dai libri,noi l'abbiamo vissuto».pp. XVIII - 472€ 16,00 -
Salvarsi
Le toccanti storie e testimonianze sugli ebrei, italiani e no, che riuscirono a salvarsi dalla Shoah in Italia, da soli o con l'aiuto e il soccorso di altri.pp. XX - 590€ 38,00 -
I Frank
«Mirjam Pressler ha trasformato il destino della famiglia Frank inun avvincente romanzo».
Frankfurter Allgemeine Zeitungpp. 406€ 17,50 -
L’Olocausto
Un'efficace storia complessiva dell'Olocausto, dalle prime forme di discriminazione alla Soluzione finale, che combina in modo originale le testimonianze di sopravvissuti, assassini e colpevoli con le ricerche storiografiche piú recenti. Un'opera di riferimento e un best seller internazionale.pp. XIV - 566€ 34,00 -
La Shoah in Italia
Come mai tra il 1943 e il 1945 migliaia di ebrei italiani, dopo essere stati privati dei loro diritti di cittadini e di uomini, furono deportati e uccisi ad Auschwitz?pp. 192€ 12,00 -
Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi
Cosa furono le leggi antiebraiche? Quali effettiebbero? Cosa signifi carono? Quale postohanno occupato nella storia d'Italia?pp. 112€ 11,00 -
-
Il diario di Dawid Sierakowiak
«Per noi non c'è veramente speranza di uscire da qui»: sono le ultime parole del Diario di Dawid Sierakowiak, in data 15 aprile 1943.pp. XXX - 348€ 12,50 -
Maus
La storia di una famiglia ebraica tra gli anni della guerra e il presente, fra la Germania nazista e gli Stati Uniti. Un padre, scampato all'Olocausto, e un figlio che fa il cartoonist e cerca di trovare un ponte che lo leghi alla vicenda indicibile...pp. 292€ 20,00 -
MetaMaus
Con un DVD che contiene una copia digitalizzata di Maus.
**
Con la sua forza visiva ed emotiva Metamaus è un'opera d'avanguardia quanto il capolavoro di cui svela la genesi.pp. 300€ 35,00 -
La liberazione dei campi
Il lento, e spesso impossibile, ritorno alla vitadelle migliaia di superstiti dei campi disterminio nazisti.
Una pagina poco conosciuta di una terribiletragedia, raccontata con profondacomprensione e pietà umana.pp. XXXIX - 312€ 10,99 -
-
L’istruttoria
L'inferno del maggiore Lager, del Lager per antonomasia, è disegnato nella sua estensione e profondità, le sue istallazioni descritte con rigore catastale, l'iter del detenuto, anzi dello Hüftling, se vogliamo conservare, come titolo d'onore, questa qualifica che ha accompagnato nella morte milioni di innocenti, minuziosamente...pp. 257€ 16,00 -
-
Auschwitz spiegato a mia figlia
«Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per mezzo pane
Che muore per un sí o per un no...»
Primo Levi, Se questo è un uomopp. 88€ 10,00 -

Resoconto di Rachel Cusk è uno di quei libri che fanno discutere. Primo di una trilogia, è stato accolto subito con entusiasmo all’estero; il suo stile innovativo ha portato parte della critica a parlare addirittura di «fine del romanzo». La stessa autrice, in un’intervista rilasciata a «la Repubblica», ha dichiarato di aver «cercato di ripensare le convenzioni del romanzo moderno. Ero su una strada da cui era difficile uscire: e io volevo sentirmi libera».
Un trionfo di stile. Con formidabile immediatezza e profondità, Cusk compone un affresco di personaggi indimenticabili; una storia che riecheggia perfino il thriller, almeno per l'avidità con cui costringe il lettore a voltare pagina. The Guardian
Anche in Italia il libro ha ricevuto molta attenzione ed è stato inserito nei migliori dieci libri dell'anno de «la Lettura - Corriere della Sera» e di «Rivista Studio»: «Lo straordinario risultato raggiunto da Rachel Cusk, è che Resoconto è un libro che non si pone il problema di cosa debba essere, pur essendo senza dubbio il prodotto di una profonda riflessione sul senso di fare letteratura in questo momento storico. È un libro perfettamente naturale, che non mostra né gli ingranaggi della teoria né lo sforzo di essere contemporaneo e che finisce per essere un libro molto contemporaneo e non estraneo alla teoria» (Cristiano de Majo).
Per Nadia Terranova «sbaglia chi dice che Resoconto segna la morte del romanzo, anche se vuole fargli un complimento: ogni volta che il romanzo muore vuol dire che è più vivo che mai, talmente vivo che qualcuno non l’ha riconosciuto» («minima et moralia»).
La storia sembra farsi da sé, nasce dall'ascolto e dalla capacita di raccontare e raccontarsi e il lettore, ripercorrendo il viaggio di Faye, cerca e trova se stesso: «È come se Cusk trovasse la forma di ciò che scrive mentre la sta cercando […] E in effetti Resoconto è affascinante, ambiguo, ha pagine ipnotiche» (Paolo Di Paolo, «la Repubblica»).
Sono molto schizzinoso. Quando il mio editore o altri editori amici mi chiedono di dire o scrivere qualcosa per sostenere un nuovo libro in uscita, declino quasi sempre. Tanto premesso: Resoconto di Rachel Cusk è semplicemente un grandissimo romanzo. Gianrico Carofiglio
Faye è una scrittrice, vive a Londra, ha due figli e un matrimonio fallito alle spalle. Chiamata in Grecia per tenere un corso di scrittura, parte per Atene. Il viaggio e la permanenza le fanno incontrare interlocutori occasionali, uomini e donne che vogliono raccontarsi e parlano di se stessi, dei loro matrimoni, delle loro ambizioni, delle difficoltà coniugali. Si vogliono sgravare del peso del passato, cercano di individuare la trama della loro vita.
Faye è un confessore laico che non giudica o condanna, accoglie le storie, ascolta senza dire molto di sé ma svelando, con poche domande, omissioni e contraddizioni di quel passato che ognuno tende a rielaborare a proprio vantaggio, per assolversi: «Cusk ci fornisce così una delle metafore più potenti della letteratura che si possano incontrare nella prosa contemporanea, mettendo in opera una strategia narrativa che rinegozia la distinzione fra autore e personaggio. Non stupisce che abbia suscitato tanta attenzione e dibattito critico nel mondo anglosassone [...] Leggendo Resoconto non si può che essere grati di aver incontrato una scrittrice tanto generosa e convinta che le "le storie chiedano una forma di speranza"» (Alessandra Sarchi, «La Lettura - Corriere della Sera»).
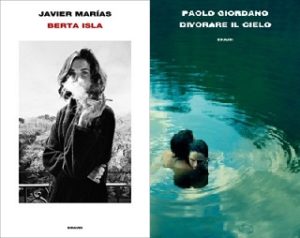
Il 12 dicembre è stato annunciato il libro dell’anno 2018 per la Lettura – Corriere della Sera. La giuria della Classifica di Qualità, presieduta da Marzio Breda (segretario Severino Colombo), composta da 311 membri, redattori, collaboratori, traduttori e amici de «la Lettura», ha assegnato il premio a Berta Isla di Javier Marías, uscito a maggio nei Supercoralli: «Un libro che si addentra nelle pieghe di un amore imperfetto e nel mistero che ogni cuore nasconde, anche a chi crede di conoscerlo a fondo».
Al secondo posto, e primo fra gli italiani, Paolo Giordano con Divorare il cielo.
Sul numero #368 de «la Lettura», che uscirà il 16 dicembre sarà pubblicata la classifica completa. Qui, il comunicato.
-
Berta Isla
«Un capolavoro. Marías è un maestro nel raccontare la mescolanza di grigiore e di passione, di mistero e di banalità, di segreto e di non detto».
Claudio Magrispp. 528€ 15,00 -
Divorare il cielo
Prendersi tutto. Assaltare i sogni. Divorare il cielo. Un romanzo potente e generoso, che restituisce al lettore l'antica meraviglia di una grande storia in cui perdersi.
«Tre ragazzi di notte in una piscina; lo sguardo di una ragazza che dall'alto li scopre, li studia in silenzio,...pp. 440€ 15,00

Il 9 dicembre, Da un altro mondo di Evelina Santangelo è stato premiato come libro dell’anno dagli ascoltatori di Fahrenheit. Un riconoscimento importante per l’autrice che ha raccontato una storia feroce, attuale e amarissima, ambientata in un futuro prossimo, il 2020: «Il romanzo, molto intenso, a riprova che si può raccontare il mondo in poco più di 200 pagine, ha la forma di un thriller, forse di un noir, distopico». (Wlodek Goldkorn, «L’Espresso»).
Khaled è un tredicenne arabo, arrivato a Bruxelles per lavorare ma ora, dopo la tragica morte del fratellino più piccolo, parte per il Sud, portandosi dietro un trolley rosso che, «grazie all’immaginazione dell’autrice diventa un altro protagonista del romanzo, anzi, si trasforma quasi in una specie di dispositivo di narrazione, in un rovesciamento di simboli e segni» (Wlodek Goldkorn, «L’Espresso»). Nel suo viaggio è accompagnato dalla voce della nonna, lasciata in Siria, che con le sue massime aveva guidato i suoi primi anni di vita.
Karolina è una donna di mezza età; la sparizione del figlio, Andreas, l'ha sconvolta e lei, pur abituata ad una vita dura e solitaria, vuole capire come mai lui l'ha sempre esclusa con durezza dal suo mondo. Scopre, nel computer che il figlio ha lasciato, mondi infettati dal neonazismo e dallo jihadismo; trova video deliranti, vaga per siti e blog respirando la stessa aria malsana che ha portato via Andreas.
E c’è il vecchio Orso, «di nome e di fatto», ex guardia giurata che «confidava in poche cose molto concrete. Il basco verde che indossava da quando era ragazzo, la Punto color militare che non lo aveva mai tradito e la Beretta 98 fs, precisa e affidabile…» (Da un altro mondo, p. 98).
C'è poi Palermo e il mistero dei «bambini viventi», che occupano spazi, che hanno uno sguardo che fa paura perché indecifrabile.
Tutte «Vite molto diverse, di valori all’apparenza antipodici, nutrite però da un medesimo dolore, da una stessa precarietà: che Santangelo sa lavorare nella loro sostanza umana profonda, al di là di barriere e differenze, col linguaggio universalizzabile della verità» (Massimo Onofri, «Avvenire»).
«Santangelo ha messo in scena protagonisti in apparenza marginali, ma proprio grazie alla loro marginalità conclamata centrali per l’immaginario contemporaneo […] racconta l’immigrazione per quello che è: tragedia, dolore, perdita di sé per chi è costretto a lasciare la propria casa; fastidio e paura per coloro che ricevono, volenti o nolenti, gli immigrati» (Wlodek Goldkorn, «L’Espresso»).
***
Qui, La mappa di Da un altro mondo dove si trovano immagini, video, luoghi, percorsi, verità insospettate di cui si è nutrito questo mondo di fantasia.
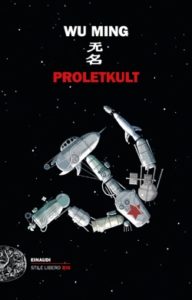
- E i titoli di coda? - ci hanno domandato lettori e lettrici al termine delle presentazioni di Proletkult, - Ve li siete dimenticati?
Detta così, può sembrare che una sezione con quel titolo sia tanto consueta in un romanzo quanto lo è al termine di un qualunque film. O quantomeno che si tratti di un marchio di fabbrica del collettivo Wu Ming.
In effetti, il primo libro che abbiamo firmato con lo pseudonimo cinese - Asce di Guerra, anno 2000 - conteneva quattro pagine dedicate alle fonti, ai libri e agli incontri che ci avevano permesso di costruire la vicenda, impastando spunti d’archivio e finzione narrativa. Li chiamammo appunto “Titoli di coda”.
Anche 54 (Einaudi, 2002) aveva una sezione omonima e pure in qual caso le pagine erano quattro, con un paragrafo dedicato a ciascun personaggio della storia.
Da allora, nessuno dei nostri romanzi collettivi ha più ospitato uno spazio di quel tipo, un “dietro le quinte” che permettesse di assaggiare gli ingredienti della nostra cucina, di accendere fornelli, scaldare alambicchi, scottarsi con le pentole e annusare il profumo degli scarti.
Per Manituana creammo un intero sito zeppo di questi intrugli, ma nel libro di carta c’era solo un minuscolo rimando, in quarta di copertina, all’indirizzo web: www.manituana.com
In Altai niente di tutto questo, mentre L’Armata dei Sonnambuli ha un intero atto - il Quinto - costruito sul genere “Che fine hanno fatto?”, una classica sequenza d’accompagnamento per i crediti finali di un film, con la differenza che, nel nostro caso, il romanzo non è affatto finito e tutte le informazioni contenute in quell’ultima parte sono da considerarsi un misto di storia e finzione, al pari delle pagine precedenti.
Sono quindi almeno 16 anni che ci “dimentichiamo” di inserire nei nostri romanzi collettivi questi benedetti titoli di coda, mentre con i romanzi “solisti” siamo stati più diligenti: Guerra agli Umani (2004) e New Thing (2004) hanno entrambi sezioni con quel nome, per non parlare di Timira, Point Lenana e Un viaggio che non promettiamo breve, che dedicano ai final credits più di trenta pagine.
Ecco il motivo per il quale, da 54 in poi, non ci siamo più arrischiati a pubblicare in volume i titoli di coda dei nostri romanzi collettivi. Sono troppa roba, perché sempre più spesso i materiali che abbiamo consultato per scrivere sono disponibili on line, a un clic di distanza dai lettori. Così, mentre non ha molto senso mettersi a citare faldoni conservati in archivi remoti o libri reperibili solo in una biblioteca finlandese, può essere invece utile o divertente per chiunque andarsi a spulciare il pdf con il carteggio tra due personaggi, dal quale si evince il fondamento di alcune frasi o episodi del romanzo, oppure un articolo scaricabile che approfondisce la biografia di una comparsa, rimasta ai margini della scena.
Succede qualcosa di simile a quel che accadde nel Seicento con la storiografia: gli storici di un tempo, come Tito Livio o Tucidide, non usavano note a pie’ di pagina e non supportavano con fonti e indicazioni bibliografiche le loro affermazioni o le notizie raccolte sul campo. Erano convinti che solo il tempo e l’ammirazione dei posteri avrebbero decretato il valore del loro lavoro. Forzare la mano con mezzucci da azzeccagarbugli era considerato inelegante. E ancora lo era agli inizi del XVII secolo, quando Étienne Pasquier inserì in una sua ricerca i riferimenti archivistici e si meritò il rimprovero del suo pubblico. Che noia, tutte quelle glosse! E che cattivo gusto, mettersi lì a chiosare sé stessi!
Poi, via via che i lettori di ricerche storiche diventarono anch’essi storici e ricercatori, si diffuse la pratica delle note a pie’ di pagina, perché chi leggeva era in grado di controllare, ricercare a sua volta e mettere alla prova le affermazioni dell’autore.
Oggi, molte fonti d’ispirazioni usate da uno scrittore per i suoi romanzi si possono rintracciare on line, il pubblico può vagliarle, giocarci, metterle a confronto con la vicenda narrata. Di conseguenza, i titoli di coda hanno una loro utilità e diventano sempre più corposi.
Con Proletkult, terminato il romanzo, ci siamo messi d’impegno per elencare indizi e dettagli, anche quelli scovati (o messi on line) dopo che avevamo ormai scritto l’ultimo capitolo. Ne sono venuti fuori 66mila caratteri, che nel formato di Einaudi Stile Libero corrispondono a circa 50 pagine.
Ve le offriamo qui, in formato pdf, evitando così di aumentare lo spessore del libro, l’uso di carta e forse anche il prezzo di copertina.
Consideratelo il nostro regalo di Natale. Un gioco di costruzioni da smontare e rimontare quante volte si vuole.
***
Quando abbiamo iniziato le ricerche per questo romanzo, negli ultimi mesi del 2016, non esisteva ancora una biografia dettagliata del nostro protagonista, Aleksandr Aleksandrovič Malinovskij, meglio noto come Bogdanov (ma anche Maksimov, Rjadovoj, Rejnert, Verner, PK, Rachmetov…)
Qualche settimana fa ci è giunta notizia che la prima in assoluto è stata pubblicata all’inizio di novembre, nell’ambito di un vasto progetto editoriale dedicato alle opere dell’Amleto Rosso:
J. White, Red Hamlet: The Life and Ideas of Alexander Bogdanov, Brill, 2018.
Averla sotto le mani ci avrebbe risparmiato un estenuante lavoro di raccolta, selezione, confronto e cucitura di mille frammenti, presi da introduzioni e brevi note, testi sparsi e citazioni inattese.
Eppure, a prima vista, il nostro compito sembrava semplice, perché lo stesso Bogdanov scrisse la sua Avtobiografija per l’Enciclopedia Granat (vol. 41, 1926).
Noi l’abbiamo letta in francese, ma una traduzione in italiano si trova in:
G. Haupt e J.J. Marie (a cura di), Autobiografie dei bolscevichi, vol. I, La Nuova Sinistra, Roma 1970. E il Kollektiv Ulyanov ne ha fatta una di recente, in appendice a A. Bogdanov, Stella rossa, Alcatraz, 2018.
Il testo però è davvero breve e ha lo stesso problema che abbiamo riscontrato in molti altri, perché si concentra sulle opere, sull’elaborazione intellettuale, mentre contiene pochissimi dettagli di vita privata.
Il primo volume che siamo riusciti a consultare che offrisse qualche elemento in più per la costruzione del personaggio è stato:
N. Krementsov, A Martian Stranded on Earth: Alexander Bogdanov, Blood Transfusions, and Proletarian Science, University of Chicago Press, 2011.
In seguito, siamo riusciti a mettere le mani sulla monumentale bibliografia completa del nostro, dopo averla assaggiata a spizzichi su Google Books:
J.Biggart, G. Gloveli, A. Yassour, Bogdanov and his work : a guide to the published and unpublished works of Alexander A. Bogdanov (Malinovsky), 1873-1928, Taylor & Francis, 2017.
 Di quel volume, ci è stata utilissima la Biographical Chronicle compilata da P. Plyutto (p.459), suddivisa per annate, con tutti gli spostamenti e gli episodi della vita di Bogdanov ricavabili dai suoi scritti.
Di quel volume, ci è stata utilissima la Biographical Chronicle compilata da P. Plyutto (p.459), suddivisa per annate, con tutti gli spostamenti e gli episodi della vita di Bogdanov ricavabili dai suoi scritti.
Tuttavia, anche un documento così dettagliato era per forza di cose concentrato sulla produzione intellettuale di B. e tralasciava invece gli aspetti più intimi.
Uno su tutti: la nascita di un figlio illegittimo, dall’unione con Anfusa Ivanovna Smirnova. Un “dettaglio” che siamo riusciti a scovare solo grazie a una ricerca in cirillico, che ci ha indirizzati sulle pagine russe di Rodovid, la “wikipedia” degli alberi genealogici.
Aleksandr Aleksandrovič Malinovskij - detto Kotik, “gattino”, perché il padre aveva come nomignolo Kot, gatto - è stato un importante biologo, genetista e studioso di cibernetica. Questa circostanza ci ha permesso di trovare altri materiali su di lui, sebbene l’omonimia con il padre non fosse proprio d’aiuto nelle ricerche. Anche in questo caso, si trattava comunque di cenni biografici, in apertura di articoli o saggi, spesso contenenti informazioni contraddittorie. La vera svolta è arrivata con una raccolta di scritti su tectologia, teoria dei sistemi e biologia teorica, scaricabile in formato pdf:
А. А. Malinovskij, Tektologija. Teorija Sistem. Teoretičeskaja biologija, Editorial URSS, 2000.
Il volume contiene un lungo articolo di V. S. Klebaner, A. Bogdanov i A.A. Malinovskij, dedicato al rapporto tra padre e figlio. Trasformata la scansione in un file word - con un software OCR apposta per il cirillico, - abbiamo usato un traduttore on-line per farci un’idea del contenuto del testo e infine girarlo alla task force di amici che ci ha aiutati con il russo. Un tassello assolutamente indispensabile, con stralci di corrispondenza, appunti dal diario di Bogdanov, poesie del figlio e altre perle.
Come detto, ricostruire il pensiero del nostro protagonista è stato molto più semplice, anche se in italiano non è stato pubblicato granché.
Soltanto dopo l’uscita di Proletkult, e grazie all’incontro con Noemi Ghetti, siamo andati a riguardarci la bibbia bibliografica di John Biggart et alii, constatando così che la prima traduzione nella nostra lingua di un testo di Bogdanov fu il saggio La poesia proletaria, pubblicato in due puntate su L’Ordine Nuovo, diretto da Antonio Gramsci, nei numeri del 9 e 27 ottobre 1921.
L’anno successivo lo stesso Gramsci, insieme a Giulia Schucht, avrebbe completato una misteriosa traduzione a quattro mani di Stella Rossa, come risulta dal suo epistolario. Ma questa è una storia che racconteremo meglio in un’altra occasione.
Per la cronaca, gli altri testi di Bogdanov pubblicati nella lingua di Dante sono:
La scienza e la classe operaia, Bompiani, Milano 1974.
La scienza, l'arte e la classe operaia, D. Lecourt e H. Deluy (a cura di), Mazzotta, Milano 1978.
Fede e scienza: la polemica su «Materialismo ed empiriocriticismo» di Lenin, (con scritti di L. Aksel'rod, V. Bazarov, P. Juškevic, M. Gor’kij), V. Strada (a cura di), Einaudi, Torino 1982.
Saggi di scienza dell’organizzazione, Theoria, Roma-Napoli 1988.
La stella rossa. L’ingegnere Menni, G. Mastroianni (a cura di), Sinefine, Catanzaro 1988.
La stella rossa. Romanzo-utopia, Sellerio, Palermo 1989.
Quattro dialoghi su scienza e filosofia, Odradek, Roma 1994.
Stella Rossa, Agenzia Alcatraz, Milano, 2018.
(oltre alla già citata Autobiografia).
Un’ottima raccolta bogdanoviana, multilingue e con decine di titoli scaricabili, si trova sulle pagine di Monoskop.
In lingua originale, invece, la risorsa alla quale abbiamo attinto è una biblioteca on-line di classici russi e sovietici, che dedica un ampio scaffale al nostro tectologo.
Naturalmente, per plasmare il personaggio, ci siamo anche serviti di studi e saggi critici sulla sua figura. I testi in italiano, pure in questo caso, non sono molti.
Un ottimo punto di partenza, per inquadrare la questione, ce l’ha offerto l’articolo di Jutta Scherrer, “Bogdanov e Lenin: il bolscevismo al bivio”, in Storia del Marxismo, vol. 2, Torino, Einaudi, 1979, pp. 493-546.
Un’altra utilissima introduzione generale si trova nel libro di Daniela Steila, Scienza e rivoluzione. La ricezione dell’empiriocriticismo nella cultura russa (1877 - 1910), Le Lettere, Firenze, 1996 (sullo stesso argomento, indispensabile anche A. Kelly, Empiriocriticism: a bolshevik philosophy?, in “Cahiers du monde russe et soviétique”, vol. 22, n°1, gen. - mar.1981. pp. 89-118).
Abbiamo incontrato Daniela Steila a Torino, a margine di un’iniziativa in memoria di Luca Rastello. Parlando con lei del nostro ultimo romanzo, abbiamo scoperto di aver di fronte una delle massime esperte interplanetarie di Bogdanov, autrice di alcuni saggi che già avevamo avuto il piacere di leggere, e di molti altri che due giorni dopo sono atterrati nella nostra casella di posta, insieme a un’offerta di aiuto incondizionato:
 «...Anche per cose che ho letto, ma non ho mai direttamente utilizzato. Anni fa, per esempio, ho visto nell’archivio di partito i taccuini di Bogdanov che non sono mai stati pubblicati. Ho preso degli appunti ed è un materiale interessantissimo. Lui sembra annotare delle considerazioni “per un romanzo”, come se pensasse a un seguito di Stella rossa e Ingegner Menni. Ma forse voleva soltanto dissimulare delle osservazioni molto dure nei confronti del regime e di Stalin.»
«...Anche per cose che ho letto, ma non ho mai direttamente utilizzato. Anni fa, per esempio, ho visto nell’archivio di partito i taccuini di Bogdanov che non sono mai stati pubblicati. Ho preso degli appunti ed è un materiale interessantissimo. Lui sembra annotare delle considerazioni “per un romanzo”, come se pensasse a un seguito di Stella rossa e Ingegner Menni. Ma forse voleva soltanto dissimulare delle osservazioni molto dure nei confronti del regime e di Stalin.»
Proprio in quei giorni usciva - curato da Daniela - il volume che raccoglie la corrispondenza tra Gorkij e Bogdanov, conservata alla Fondazione Basso di Roma. Ma di questo, parleremo più avanti.
Per ora segnaliamo gli altri studi generali sul nostro che abbiamo letto e utilizzato, dando la precedenza a quelli che sono reperibili on-line.
Sull’empiriomonismo, la tectologia e i tre lustri di battaglie con Lenin, un lavoro molto completo e di grande interesse è:
Z. Sochor, Revolution and Culture. The Bogdanov - Lenin Controversy, Cornell University Press, 1988.
Per un confronto tra diverse interpretazioni e punti di vista, suggeriamo i saggi di John Eric Marot, John Biggart, Zenovia Sochor, Andrzej Walicki e Aileen Kelly, contenuti in Russian Review, n. 3, vol. 49, luglio 1990 - edizione speciale dedicata ad Aleksandr A. Bogdanov.
Sul concetto di “cultura proletaria”, abbiamo trovato considerazioni importanti in:
James D. White, Alexander Bogdanov’s Conception of Proletarian Culture, in “Revolutionary Russia”, 26:1, 52-70.
J. Scherrer, The Cultural Hegemony of the Proletariat: The Origins of Bogdanov’s Vision of Proletarian Culture, in “Studies in History”, 5, 1989.
Moltissimi spunti, a partire da un raffronto tra la tectologia di Bogdanov e la teoria del montaggio di S. Ėjzenštejn - che collaborò per qualche anno con il teatro del Proletkul’t - ci sono arrivati dalla raccolta di autori vari intitolata:
Culture as Organization in Early Soviet Thought: Bogdanov, Eisenstein and the Proletkult. Helsinki, Espoo: Aalto University, 2016.
Il volume può essere “montato” in maniera diversa in base a un tema prescelto, e poi scaricato dal sito del progetto.
Tra le sue pagine, oltre a Daniela Steila, abbiamo ritrovato Fabian Tompsett, vecchia conoscenza di metà anni Novanta, ai tempi del Luther Blissett Project e della London Psychogeographical Association.
Un altro incontro inatteso è stato quello con McKenzie Wark, autore del famoso A Hacker Manifesto, nonché di un’appassionata recensione del nostro Q. Ci ha entusiasmato trovare il suo nome sulla copertina di un saggio dedicato all’attualità del pensiero (eco)sistemico di Bogdanov:
McKenzie Wark, Molecular Red. Theory for the Anthropocene, Verso, London, 2016.
Vedremo più avanti quali sono stati i testi specifici e le fonti storiche che abbiamo utilizzato per i vari aspetti del pensiero e della vita del nostro. Ora è giunto il momento di concentrarci su Denni, la co-protagonista di Proletkult, per la quale la principale fonte d’ispirazione sono stati i romanzi dello stesso Bogdanov.
Stella rossa è disponibile on-line in russo, in inglese e francese (nella prima traduzione, risalente al 1913). Ingegner Menni si trova in inglese, in volume unico con il precedente.
Ma è il poemetto Un marziano bloccato sulla Terra, pubblicato in appendice alla seconda edizione del 1924 (la sesta in assoluto) di Stella rossa, che ci ha spinto a fare di Denni un’extraterrestre che non può tornare a casa. Al momento, lo si trova in inglese, insieme agli altri due episodi della saga. Presto sarà pubblicato anche in italiano, a cura del Kollektiv Ulyanov, in appendice alla traduzione di Ingegner Menni per Agenzia Alcatraz. Oltre a quel testo, bisogna senz’altro citare Walter Tavis, The Man who fell to Earth (1963), dal quale fu tratto il film omonimo di Nicolas Roeg (1976) con protagonista David Bowie (in Italia, è stato tradotto e pubblicato nella serie Urania - n. 359, 1963 e n. 694, 1976 - poi da Minimum Fax, 2006 e BEAT, 2012). Anche il romanzo di R. A. Heinlein, Stranger in a strange land [Straniero in terra straniera] (1961) è stato benzina per accendere l’immaginazione.
Un altro mattone angolare per la costruzione di Denni è quella che Jacopo Nacci ha chiamato “cosmogonia dell’orfano alieno”, tipica degli anime di super-robot che divoravamo da ragazzini. Di quella massa di archetipi e mitologemi abbiamo conservato solo alcuni ingredienti: i due pianeti - uno dei quali minacciato da un cataclisma che potrebbe diventare catastrofico anche per l’altro, l’orfano mezzosangue che cerca uno dei suoi genitori, il padre putativo…
L’idea viene analizzata e sviscerata in:
Jacopo Nacci, Guida ai super robot. L’animazione robotica giapponese dal 1972 al 1980, Odoya, 2016.
Su Yattaran, il suo blog personale, l’autore aveva già pubblicato un testo preliminare alla Guida, suddiviso in 19 post + un bonus: L’altro me – l’avversario nell’animazione robotica classica.
 Per il personaggio di Natal’ja Bogdanovna Korsak (1865 - 1945), oltre ai libri già citati parlando del marito, non abbiamo trovato molte fonti autonome. Purtroppo avevamo già finito di scrivere Proletkult quando John Biggart ha reso disponibile on-line la traduzione di un memoriale, scritto da Natal’ja due mesi dopo la morte di Bogdanov. Il testo è quel che rimane di un manoscritto più voluminoso, costudito in casa di Kotik e parzialmente distrutto da un incendio, nel 1990. Le carte che si sono salvate coprono solo il periodo 1894-1901, ma l’introduzione, scritta dallo stesso Biggart e da J.D. White, fornisce molti preziosi dettagli sulla vita di Natal’ja. Leggendola, abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo, perché quel che se ne ricava corrisponde all’immagine che abbiamo dato nel romanzo della moglie del nostro protagonista.
Per il personaggio di Natal’ja Bogdanovna Korsak (1865 - 1945), oltre ai libri già citati parlando del marito, non abbiamo trovato molte fonti autonome. Purtroppo avevamo già finito di scrivere Proletkult quando John Biggart ha reso disponibile on-line la traduzione di un memoriale, scritto da Natal’ja due mesi dopo la morte di Bogdanov. Il testo è quel che rimane di un manoscritto più voluminoso, costudito in casa di Kotik e parzialmente distrutto da un incendio, nel 1990. Le carte che si sono salvate coprono solo il periodo 1894-1901, ma l’introduzione, scritta dallo stesso Biggart e da J.D. White, fornisce molti preziosi dettagli sulla vita di Natal’ja. Leggendola, abbiamo tirato un bel sospiro di sollievo, perché quel che se ne ricava corrisponde all’immagine che abbiamo dato nel romanzo della moglie del nostro protagonista.
A memoir of Natalia Bogdanovna Korsak (Malinovskaia), traduz. e introduz. di J. Biggart e J.D. White, 2018.
Altre indicazioni utili le abbiamo ricavate da un articolo sulla corrispondenza intercorsa tra Bogdanov e Lunačarskij nel periodo 1909 - 1913, dal momento che le lettere passavano spesso per le mani di Natal’ja e Anna - sorella di Saša e moglie di Lunačarskij.
I.A. Lapina, Ėmigracija i provincija, in «Terra Humana», n. 3, 2010.
Per immaginare e descrivere l’aspetto di Natal’ja, abbiamo avuto a disposizione soltanto due fotografie.

Una è quella della famosa partita a scacchi sul terrazzo di Villa Blaesus a Capri, dove lei compare al centro, lo sguardo rivolto in basso.
L’altra si trova sulla lapide della tomba dove le sue ceneri riposano insieme a quelle del marito, al cimitero moscovita di Novodevičij.
Tra i principali personaggi del romanzo, Vladimir Ilič Lenin non ci ha di certo creato problemi con il reperimento di materiali biografici. In particolare abbiamo attinto dalle Opere Complete, pubblicate in 43 volumi da Editori Riuniti, a partire dal 1955.
L’altro testo che abbiamo consultato assiduamente sono le memorie di Nadežda Kruspskaja, pubblicate in Unione sovietica nel 1933:
N. Krupskaja, Reminiscences of Lenin, International Publishers, 1970.
Infine qualche parola sull’ambientazione, limitandoci a quella geografica principale, cioè Mosca, e tralasciando quella storica, perché ci vorrebbero dei titoli di coda a parte sulla Rivoluzione d’Ottobre e l’Unione sovietica dei primi dieci anni.
Mappe, fotografie, filmati, romanzi e diari di viaggiatori sono gli ingredienti che abbiamo utilizzato per collocare l’azione e i personaggi nella Mosca dell’epoca.
Sul sito retromap.ru abbiamo trovato alcune bellissime mappe della città datate 1927. Un’altra pianta che ci è servita per descrivere gli spostamenti di Bogdanov è quella dei trasporti pubblici moscoviti nell’anno 1929.
 Per le fotografie, abbiamo saccheggiato il sito pastvu.com - Retro view of Mankind’s Habitat, dove si trovano migliaia di immagini georeferenziate di Mosca, dal 1826 al 2000.
Per le fotografie, abbiamo saccheggiato il sito pastvu.com - Retro view of Mankind’s Habitat, dove si trovano migliaia di immagini georeferenziate di Mosca, dal 1826 al 2000.
Tra i filmati, merita una menzione speciale il documentario Moskva, girato da M. Kaufman e I . Kopalin nel 1927. Altri sogni a occhi aperti li abbiamo fatti grazie a Tret’ja Meščanskaja, ambientato a Mosca sempre nel 1927, diretto da A. Room e scritto insieme a V. Šklovskij.
Abbiamo ricavato molti dettagli e informazioni dai diari russi e moscoviti di Walter Benjamin (Moscow Diary), Alexander Berkman (The bolshevik myth. Diary 1920-22), H.G. Wells (Russia in the shadows) e Pierre Pascal (Journal de Russie, 1928 - 29).
***
 Giunti a questo punto, dopo aver passato in rassegna gli aspetti più generali della nostra ricerca, possiamo analizzare capitolo per capitolo quali sono stati gli spunti più specifici, le fonti d’ispirazione precise di alcuni passaggi e le pezze d’appoggio documentali dalle quali abbiamo ricavato la materia prima delle singole scene.
Giunti a questo punto, dopo aver passato in rassegna gli aspetti più generali della nostra ricerca, possiamo analizzare capitolo per capitolo quali sono stati gli spunti più specifici, le fonti d’ispirazione precise di alcuni passaggi e le pezze d’appoggio documentali dalle quali abbiamo ricavato la materia prima delle singole scene.
Prologo
Sulla dinamica della rapina di Tbilisi/Tiflis, abbiamo letto:
Simon S. Montefiore, Young Stalin, Orion, 2007 (tr. it: Il giovane Stalin, Longanesi, 2010) - Prologue. The Bank Robbery.
Sulla figura del kinto, cantastorie e venditore ambulante:
P. Manning, Z. Shatirishvilki, "The exoticism and eroticism of the city: The »kinto« and his city", in T. Darieva et al. (a cura di), Urban spaces after socialism, Campus Verlag, 2012.
Per gli spostamenti dei personaggi, ci siamo basati su due mappe d’epoca, una pubblicata nella guida Moskvič (1913) e l’altra pubblicata nella guida Baedeker (1914).
Capitolo 1
Sui documenti d’identità dopo la rivoluzione, abbiamo consultato:
G. Superfinu, K predystorii sovestskogo pasporta (1917-1932) [Alla preistoria del passaporto sovietico], in “Intelros”, n. 2, 2009.
Abbiamo descritto il libretto di lavoro sovietico grazie alla scansione di un documento del 1921.
Capitolo 2
Sul Proletkul’t, il testo più completo e approfondito che abbiamo consultato è:
L. Mally, Culture of the Future: The Proletkult Movement in Revolutionary Russia,University of California Press,1990.
Su pastvu.com abbiamo studiato diverse fotografie di Villa Morozov, sede del Proletkult di Mosca.
 La frase in cui viene definita “un palazzo stupido e vano” è tratta dal romanzo di L. Tolstoj, Voskresen’e, 1899 (tr. it, Resurrezione, Mondadori, 2006).
La frase in cui viene definita “un palazzo stupido e vano” è tratta dal romanzo di L. Tolstoj, Voskresen’e, 1899 (tr. it, Resurrezione, Mondadori, 2006).
La Sinfonia di sirene, diretta da Arsenij Avraamov al porto di Baku nel 1922, per il quinto anniversario della Rivoluzione d’Ottobre, è stata ricostruita dal Laboratorio de Creaciones Intermedia, della facoltà di Belle Arti di Valencia, e si può ascoltare qui.
Su Lunačarskij e le sue dimissioni nel 1917:
S. Fitzpatrick, The Commissariat of Enlightenment: Soviet Organization of Education and the Arts under Lunacharsky, October 1917–1921, University of Chicago, 2002.
I versi che invitano a “bruciare i Raffaello” sono presi dalla poesia di V. Kirillov, “My” [Noi] citata in L. Mally, Culture of the Future, op. cit.. La traduzione (dall’inglese) è nostra.
La musica dell’ottetto di fagotti è ispirata alla composizione di M. Gordon, Rushes, Cantaloupe Music, 2014.
Qui un’esecuzione dal vivo, allo Stamps Auditorium della University of Michigan - School of Music, Theatre & Dance.
I principi della tectologia, sono esposti nell’opera omonima in 3 volumi (1913 - 1917), ristampata in russo in 2 tomi nel 1989. Noi ci siamo limitati a leggere la traduzione inglese degli Očerki organizacionnoj nauki (Saggi di scienza dell’organizzazione), una raccolta di articoli pubblicati su Proletarskaja Kultura, 7 - 20, 1919 - 1921 allo scopo di divulgare i principi della scienza dell’organizzazione:
A. Bogdanov, Essays in Tektology, 2ª ed., Intersystems, 1984.
Abbiamo scelto di rendere il neologismo russo tektologija con “tectologia”, anche se sarebbe più corretto “tettologia”, visto che la radice utilizzata da Bogdanov è la stessa di “tettonica” e “architetto” (dal greco τέκτων, costruttore, creatore). Un suono esotico e alieno ci è sembrato più adatto alla nostra vicenda.
Alcuni dettagli della distruzione dei pianoforti rimandano, parola per parola, a una scena analoga del Maestro e Margherita di Michail Bulgakov, che noi abbiamo riletto e citato nell’edizione Einaudi del 1967.
È possibile vedere Lev Termen suonare il suo eterofono - già ribattezzato Thereminvox - in un prezioso filmato, girato a Mosca nel 1954.
Capitolo 3
Le banconote da 500 rubli che Denni ha con sé sono quelle stampate nel 1898 - in corso nel 1907, al tempo della rapina di Tbilisi.
Capitolo 4
Le strambe architetture di casa Igumnov, sede dell’Istituto trasfusionale diretto da Bogdanov, si possono contemplare in fotografie di varie epoche, sempre grazie a pastvu.com
Per raccontare l’epidemia di “esaurimento sovietico”, ci siamo basati sul saggio:
F. Bernstein, “Panic, Potency, and the Crisis of Nervousness in the 1920s”, in C. Kiaer, E. Naiman (a cura di), Everyday Life in Early Soviet Russia. Taking the Revolution inside, Indiana University Press, 2015.
Le teorie di Bogdanov sul collettivismo fisiologico sono contenute soprattutto nel suo scritto Bor’ba za žiznesposobnost’ [La lotta per la vitalità] (1927). Il primo capitolo si trova on-line in russo, mentre l’intero libro è stato tradotto in inglese:
A. Bogdanov, The struggle for viability, Xlibris, 2002.
Il riferimento principale nella stesura di questo capitolo è stato N. Krementsov, A martian …, op. cit. Anche il personaggio di Charlampij Vlados è citato in quelle pagine, per quanto il suo profilo caratteriale, nel romanzo, sia puramente d’invenzione.
Grazie alla rilettura in anteprima di Daniela Steila, abbiamo evitato di ripetere un errore molto comune: l’attribuzione a Bogdanov della prima traduzione in russo del Capitale di Marx. In realtà, quella curata da Bogdanov insieme agli amici Skvorkov-Stepanov e Bazarov, non fu affatto la prima traduzione dell’opera in quella lingua. Il primato è da attribuire a Bakunin, che iniziò l’impresa, poi continuata da G. Lopatin e N. Daniel’son. Il testo vide la luce nel 1872. In seguito ne venne una a cura di P. B. Struve e infine quella di Bogdanov & Co, che diventò da allora la più diffusa.
Capitolo 5
Il testo in corsivo che compare in apertura è un riadattamento del dibattito sull’eventuale invasione della Terra raccontato nel cap.7 della terza parte di Stella rossa.
Per l’ambientazione a Leningrado, oltre ad alcuni dei diari già menzionati per Mosca, ci siamo serviti del solito sito pastvu.com (dove si possono ammirare diverse fotografie dell’Istituto Smol’nyj) e di mappe d’epoca, come quella del Municipio di Leningrado (1927).
La frase che compare sul volantino raccolto da Denni, “Il gruppo di Stalin guida il paese con il paraocchi…”, è tratta da L. Trockij, Platform of the joint opposition, Index Books, 1973.
L’articolo della Pravda sull’Istituto Trasfusionale a cui fa riferimento la caposcala è B. Baranovskij, Institut perelivanija krovi [Un istituto per la trasfusione di sangue], in “Pravda”, 27 luglio 1928.
Capitolo 6
Le frasi che B. legge da un foglio sulla scrivania, mentre gli torna in mente la domanda “Perché abbiamo fallito”, sono tratte dalle ultime righe di The struggle for viability’, op. cit. La traduzione dall’inglese è nostra.
Le frasi di Trockij in corsivo (Abbiamo la libertà di riunirci…) si trovano in L. Trockij, 1905 goda [L’anno 1905], Mosca, 1922 (una traduzione inglese è disponibile su marxist.org).
Bogdanov pubblicò il primo volume di Ėmpiriomonizm nel 1904, il secondo nel 1905 e il terzo nel 1906. On line lo si trova soltanto in russo. Tra il 1910 e il 1911, B. sistemò gli appunti delle sue lezioni sull’empiriomonismo a Capri e Bologna e li raccolse in un volume intitolato Filosofija živogo opta: populjarnye očerki [La filosofia dell’esperienza viva. Cenni popolari]. Il testo è stato tradotto in inglese da David J. Rowley:
The philosophy of living experience. Popular outlines, Brill, 2016.
Sebbene questo libro sia già inteso dall’autore come una divulgazione dell’empiriomonismo, tuttavia per assimilarlo è molto utile la spiegazione passo passo, paragrafo per paragrafo, che ne ha fatto:
K. Jansen, Beyond Marx and Mach. Alexandr Bogdanov’s Philosophy of Living Experience, Reidel, 1978.
Capitolo 7
Il testo in corsivo che compare in apertura è di nuovo un riadattamento del dibattito sull’eventuale invasione della Terra che compare in Stella rossa.
Capitolo 8
La considerazione sulle somiglianze fisiche acquisite da due coniugi dopo una vita insieme, sono tratte da Essays in tektology, op. cit, pp. 153-154:
«La congiunzione tra esseri umani è nota finora in due forme. La prima è quella sessuale, come per gli altri organismi […] La seconda consiste nell’interazione delle conoscenze e nella congiunzione delle esperienze, attraverso la parola, la mimica, l’arte […]. Questa congiunzione, tuttavia, non è soltanto “psichica”, come risulta evidente, per esempio, tra due sposi. Grazie alla dipendenza di tutti gli organi e tessuti dall’attività nervosa del cervello, dopo 15-20 anni di vita comune, gli sposi acquisiscono anche una somiglianza fisica esteriore, che in media può essere non inferiore, e talvolta addirittura superiore, alla normale somiglianza tra fratello e sorella.»
L’articolo menscevico con la prima “scomunica” di Bogdanov dal marxismo è:
L. Aksel’rod (Ortodoks), Novaja raznovidnost’ revizionizma [Un nuovo tipo di revisionismo], in “Iskra”, n. 77, 5 novembre 1904.
Lo stesso B. considerava questo articolo il primo anatema ufficiale scagliato contro di lui, tanto che nel 1914 pubblicò una raccolta di testi intitolata Desjatiletie otluchenija ot marksizma [Il decennale della scomunica dal marxismo], ora ristampato in:
Neizvestnyj Bogdanov [Bogdanov sconosciuto], vol. III, Moskva, AIRO-XX, 1995.
La prefazione ("Predislovie") al volume è di Daniela Steila.
Di villa Vasa, a Kuokkala (oggi Repino, Fed. Russa), non rimane nulla. Il proprietario la vendette nel 1916 e negli anni Trenta è stata demolita (altri sostengono che bruciò in un incendio nel 1940). Per il 70° anniversario della Rivoluzione c’era il progetto di costruire al suo posto una biblioteca, ma venne poi realizzata soltanto una stele commemorativa. Oggi il luogo dove sorgeva è un parco pubblico e nulla ricorda il suo passato.
Molti testi che abbiamo consultato fanno grande confusione nel dipanare l’intreccio tra la disputa filosofica che oppose Lenin e Bogdanov e il loro dissidio tattico sulla posizione da tenere nei confronti delle elezioni e della Duma. Spesso Bogdanov viene classificato come un otzovista, sostenitore del boicottaggio ad oltranza del Parlamento zarista, ma la faccenda è più complessa.
Ci è stato di grande aiuto, per comprenderla meglio, una articolo pubblicato nel già citato “numero speciale” della Russian Review, dedicato a Bogdanov:
J. E. Marot, Alexandr Bogdanov, Vpered, and the role of the intellectual in the workers’ movement, in “Russian Review", op. cit.
Per una biografia di Maksim Gorkij, incentrata più sulla sua attività politica che sulla critica letteraria delle opere, su archive.org abbiamo trovato:
T. Yedlin, Maxim Gorky. A political biography, Praeger, 1999.
Capitolo 9
Per i dettagli della vita di Kamo, ci siamo rifatti a S. S. Montefiore, Young Stalin, op. cit, in particolare i capp. 20 e 29.
Gli aneddoti sulla contraffazione delle banconote da 500 rubli, organizzata da Krasin e Ignat’ev, e sul rifiuto da parte di Plechanov di aiutare suo nipote Semaško, ci sono stati raccontati in una mail da Daniela Steila. Ci sono piaciuti talmente tanto che li abbiamo inseriti, senza preoccuparci di trovare altre pezze d’appoggio.
Capitolo 10
Nulla da segnalare.
Capitolo 11
In Stella Rossa, Leonid e Netti hanno una relazione che mette il terrestre in grande difficoltà. Dapprima, perché si sente attratto dalla marziana ma pensa che sia un maschio. In seguito, perché scopre che Netti gli ha nascosto di essere stata la moglie di Sterni - un marziano che vorrebbe sterminare il genere umano, per usare la Terra come nuovo bacino di risorse naturali.
Nel romanzo, non si accenna a figli della coppia mista interplanetaria.
Capitolo 12
Sugli esuli russi a Capri, abbiamo letto i capp. 2, 3 e 11 di:
A. Tamborra, Esuli russi in Italia dal 1905 al 1917, Rubbettino, 2002.
Sui rapporti tra Gorkij e Bogdanov abbiamo trovato di grande interesse l’articolo:
J. Scherrer, Gor’kij - Bogdanov : Aperçu sur une correspondance non publiée, in “Cahiers du monde russe et soviétique”, vol. 29, n°1, gennaio - marzo 1988.
La “corrispondenza non pubblicata” alla quale fa riferimento l’autrice si trova presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso di Roma, Fondo Aleksandr Aleksandrovič Bogdanov, ed è stata parzialmente pubblicata in volume mentre la stesura di Proletkult era in corso:
J. Scherrer, D. Steila (a cura di), Gor’kij-Bogdanov e la scuola di Capri. Una corrispondenza inedita (1908-1911), Carocci, 2017.
Avevamo invece già consegnato il romanzo all’editore, quando la fondazione Basso ha pubblicato on line l’inventario del fondo A. A. Bogdanov, con la traduzione in italiano di svariate lettere scambiate tra il nostro protagonista, Gor’kij e molti altri personaggi.
L’articolo di Gor’kij Razrušenie ličnosti [La distruzione della personalità] fu rifiutato dal Proletarij, per intervento di Lenin, durante una riunione di redazione del 24 febbraio 1908. Venne poi pubblicato nella raccolta Očerki filosofii kollektivizma [Saggi di filosofia collettivista], San Pietroburgo, 1909, insieme a scritti di Bogdanov, Bazarov, Lunačarskij ed altri.
 Bonč Bruevič, nelle sue Ženevskie vospominanija [Memorie ginevrine] ricorda che fu Plechanov a inventare l’espressione “empirioscemenze”, qui attribuita a Lenin.
Bonč Bruevič, nelle sue Ženevskie vospominanija [Memorie ginevrine] ricorda che fu Plechanov a inventare l’espressione “empirioscemenze”, qui attribuita a Lenin.
Bogdanov viene spesso inserito nelle fila della cosiddetta bogolstroitel’stvo (“costruzione di Dio”), che aveva in Gor’kij e Lunačarskij i suoi principali esponenti. Ma mentre quest’ultimo arrivò a ipotizzare una “trinità socialista”, Bogdanov non abbracciò mai quelle idee, per i motivi illustrati nel capitolo e basati sul suo libro Nel decennale della scomunica…, op. cit.
La nascita della “scuola di Capri” è ben illustrata da:
J. Scherrer, Les écoles du parti de Capri et de Bologne: La formation de l'intelligentsia du parti, in “Cahiers du monde russe et soviétique”, vol. 19, n. 3, Luglio-Settembre 1978.
V. Strada, L’altra rivoluzione. Gor'kij, Lunacarskij, Bogdanov. La «Scuola di Capri» e la «Costruzione di Dio», La Conchiglia, 1994.
Gor’kij scrive a Bogdanov: «Sto cercando di insegnare a Pepito il grido “empiriomonsimo”» in una lettera del maggio 1908 (la n.5, del Fascicolo 1 - “Corrispondenza 1908”, carteggio “Gorkij-Bogdanov e scuola di Capri”, Fondo A.A. Bogdanov, conservato alla Fondazione Basso). Abbiamo anticipato il dettaglio di un paio di mesi per non lasciarcelo scappare.
Anche altri aspetti del rapporto tra il nostro protagonista e il celebre scrittore sono qui anticipati di qualche mese. La frase sugli “operai che diventeranno tutti empiriomonisti” è nella lettera n.9, fascicolo 2 del carteggio “Gorkij-Bogdanov…”, op. cit, spedita nella seconda metà di marzo 1909. (ma già in una lettera dell’anno prima, la n. 4 del fascicolo 1, Gor'kij scrive che «nella persona di Bogdanov il proletariato russo, e non solo, riconoscerà ed apprezzerà il proprio filosofo») La lettera in cui Marija Andreeva chiede di non assegnare più al marito la stesura di articoli filosofici è la n. 15, del fascicolo 1, dello stesso carteggio, spedita dopo il 22 luglio 1908. Le prime lettere sull’organizzazione della scuola di Capri, sono del febbraio 1909 (n. 1, fascicolo 2, da Vilonov a Bogdanov). Questo chiaramente non significa che gli organizzatori non abbiano iniziato a parlarne fin dall’anno prima, come diamo a intendere nel capitolo e come sostiene anche:
R. C. Elwood, Lenin and the Social Democratic Schools for Underground Party Workers, 1909 - 11, in “Political Science Quarterly”, Vol. 81, n. 3, sett. 1966.
I giornali che attaccarono F. A. Krupp e montarono lo scandalo sulle sue abitudini sessuali furono Il Mattino (con l’articolo di Eduardo Scarfoglio, “Krupp re dei cannoni e re dei capitoni”), La Propaganda (con una serie di articoli, a partire da “Capri-Sodoma”, 15 ottobre 1902), quindi i quotidiani tedeschi Augsburger Postzeitung e il socialista Vorwärts. La vicenda è ricostruita anche in:
W. R. Manchester, I cannoni dei Krupp, Mondadori, 1968.
Capitolo 13
La canzone tradizionale russa Dubinuška, interpretata dalla voce di Fëdor Šaljapin si può ascoltare qui, in una versione incisa proprio nel 1908.
La visita di Leonid a una colonia infantile marziana è descritta nel cap. 3 della seconda parte di Stella Rossa.
Da un punto di vista strettamente cronologico, è impossibile che l’idea di base per la stesura di Stella Rossa sia nata nella primavera del 1908, perché il romanzo venne pubblicato quello stesso anno, e inoltre Lenin, in una lettera alla madre, scritta nell’estate, prende in giro l’autore del libro parlando di Marte e sostenendo che “la menzogna che ci eleva ci è più cara di un mucchio di volgari verità”.
Questa discrepanza è un’ulteriore dimostrazione che in Proletkult la genesi di quel romanzo è incerta e che il nostro Bogdanov non è in grado di distinguere il proprio contributo da quello di Leonid.
Capitolo 14
La visita di Lenin a Capri è raccontata con molti dettagli in:
B. Caruso, Lenin a Capri. Intellettuali, marxismo, religione, Dedalo, 1978.
I. Bociarov, Lenin a Capri, in “Realtà sovietica”, aprile 1969.
Le 18 mosse della partita tra i due avversari non sono quelle originali, ma vengono dalla sfida tra Bent Larsen e il connazionale Bent Kolvig, giocata a Copenhagen nel 1960.
Abbiamo scelto di riprodurre questa partita perché conciliava tre esigenze:
- Apertura “eretica” del Bianco, da attribuire a Bogdanov (il cosiddetto “fianchetto di re” non è tra le 4 aperture più comuni)
- Numero limitato di mosse, per contenere il capitolo in una lunghezza ragionevole, pur descrivendo quasi ogni scambio sulla scacchiera.
- Vittoria del Bianco, cioè di Bogdanov, come si evince da un ricordo di Lenin, scritto da Gor’kij alla morte del grande rivoluzionario (non è del tutto chiaro se Gor’kij parli di una partita giocata nel 1908 - verosimilmente quella della famosa foto - oppure se si riferisca a un’altra sfida, in occasione della seconda visita di Lenin sull’isola di Capri. L’episodio è ricordato anche nel libro di Gor’kij su Lenin, da poco ritradotto in italiano, a cura di M. Caratozzolo:
M. Gor’kij, Lenin, un uomo, Sellerio, 2018 (in appendice, tra i passi tratti dall’edizione originale del 1931 e non presenti in quelle del 1924 e 1927. Paragrafi 19 e 20).
Anche se non contiene citazioni dirette, questo capitolo deve molto alla narrazione delle partite di scacchi che compaiono in:
V. Nabokov, La difesa di Lužin, Adelphi, 2001.
Esistono almeno sette fotografie che ritraggono le partite di scacchi giocate a Capri tra Lenin e Bogdanov. La serie completa si trova nel libro di V. Strada, L’altra rivoluzione, op.cit. In tre di questi scatti compare anche il pappagallo di Gor’kij:
Qui, qui e qui.
Nel romanzo, raccontiamo dell’arrivo a Villa Blaesus di un fotografo chiamato apposta per immortalare la sfida Lenin - Bogdanov. In realtà, l’autore degli scatti fu il figlio di Marija Andreeva, I. Želiabužskij (cfr: J. Biggart, J. D. White (a cura di), A memoir of Natalia Bogdanovna…, op. cit.)
 La metafora della conoscenza come fotografia o come montaggio cinematografico non è farina del nostro sacco e riprende solo in parte uno scritto dei due contendenti. In Materialismo ed empiriocriticismo. Note su una filosofia reazionaria (1909), Lenin scrive che “la realtà oggettiva si trasmette all’uomo attraverso le sue sensazioni, ed è copiata, fotografata, riflessa dalle nostre sensazioni, sebbene esista indipendentemente da esse”. Naturalmente, qualunque fotografo di oggi potrebbe obiettare che tra una fotografia e un riflesso nello specchio c’è una grande differenza, e che nessuna immagine stampata su pellicola può essere considerata neutrale. Tuttavia, questa era l’idea di Lenin. Quanto a Bogdanov, sappiamo che conosceva e apprezzava il cinema e che lo riteneva un mezzo straordinariamente efficace – quasi “mistico” – di rappresentazione del mondo. In Stella Rossa immagina che su Marte abbiano inventato un cinema immersivo, in 3D, che rende ancora più sorprendente l’effetto di realtà. Inoltre, Ėjzenštejn, all’inizio della sua carriera, aveva collaborato con il teatro del Proletkult e possiamo immaginare che Bogdanov fosse a conoscenza delle sue riflessioni sul montaggio. Va notato, però, che tutte queste cose (Stella Rossa, il Proletkult) avvengono in seguito, rispetto al presente nel quale collochiamo il flusso di coscienza di Bogdanov, cioè la primavera del 1908. A quel tempo, il montaggio non aveva ancora l’importanza che si guadagnò nei vent’anni successivi, ma possiamo immaginare che Bogdanov avesse visto a Parigi i film di Meliès, dove la pellicola viene manipolata e montata per creare nuove, meravigliose realtà. La metafora, comunque, ci arriva da un articolo contenuto nel volume collettivo Culture as organization in early soviet thought, op. cit.:
La metafora della conoscenza come fotografia o come montaggio cinematografico non è farina del nostro sacco e riprende solo in parte uno scritto dei due contendenti. In Materialismo ed empiriocriticismo. Note su una filosofia reazionaria (1909), Lenin scrive che “la realtà oggettiva si trasmette all’uomo attraverso le sue sensazioni, ed è copiata, fotografata, riflessa dalle nostre sensazioni, sebbene esista indipendentemente da esse”. Naturalmente, qualunque fotografo di oggi potrebbe obiettare che tra una fotografia e un riflesso nello specchio c’è una grande differenza, e che nessuna immagine stampata su pellicola può essere considerata neutrale. Tuttavia, questa era l’idea di Lenin. Quanto a Bogdanov, sappiamo che conosceva e apprezzava il cinema e che lo riteneva un mezzo straordinariamente efficace – quasi “mistico” – di rappresentazione del mondo. In Stella Rossa immagina che su Marte abbiano inventato un cinema immersivo, in 3D, che rende ancora più sorprendente l’effetto di realtà. Inoltre, Ėjzenštejn, all’inizio della sua carriera, aveva collaborato con il teatro del Proletkult e possiamo immaginare che Bogdanov fosse a conoscenza delle sue riflessioni sul montaggio. Va notato, però, che tutte queste cose (Stella Rossa, il Proletkult) avvengono in seguito, rispetto al presente nel quale collochiamo il flusso di coscienza di Bogdanov, cioè la primavera del 1908. A quel tempo, il montaggio non aveva ancora l’importanza che si guadagnò nei vent’anni successivi, ma possiamo immaginare che Bogdanov avesse visto a Parigi i film di Meliès, dove la pellicola viene manipolata e montata per creare nuove, meravigliose realtà. La metafora, comunque, ci arriva da un articolo contenuto nel volume collettivo Culture as organization in early soviet thought, op. cit.:
D. Steila, “Knowledge as film vs knowledge as photo. Alternative models in early soviet thought.”
Georgij Plechanov strappò “i galloni da marxista” dall’uniforme di Bogdanov con una serie di due lettere, pubblicate nel 1908 sul quotidiano Golos Social-Demokrata [La voce socialdemocratica], alla quale se ne aggiunse una terza, nel 1910. Le tre lettere sono raccolte in:
G. Plechanov, Materialismus militans: Reply to mister Bogdanov, Progress, 1973.
Come ci ha fatto notare Daniela Steila, Lenin andò alla British Library di Londra nel maggio 1908, ovvero in seguito alla partita di scacchi contro Bogdanov, che risale ad aprile. Abbiamo deciso di non correggere quel dettaglio, perché il capitolo è basato sui ricordi di Bogdanov, e dunque un piccolo errore cronologico è del tutto naturale.
Gli esempi sulla verità della rivoluzione copernicana e sulla data precisa di un evento storico acclarato, sono entrambi proposti in A. Bogdanov, The philosophy of living experience, op.cit.
Leonid discute di poesia con Enno, un marziano, nel capitolo 4 della seconda parte di Stella Rossa, dedicato alla visita di un museo d’arte.
Le metafore contrapposte dello scultore e del musicista, sono un tributo al pensiero di Tim Ingold, che spesso le ha usate per illustrare la sua idea di conoscenza e di materia, traendo spunto dalla propria esperienza di violoncellista dilettante.
T. Ingold, The perception of the environment. Essays on livelihood, dwelling and skill, Routledge, 2000.
T. Ingold, Corrispondences, University of Aberdeen, 2017.
Capitolo 15
Per il personaggio di Maksim Litvinov abbiamo consultato la biografia scritta da:
Z. Sheinis, Maxim Litvinov, Progress, 1990.
Per Aleksandra Kollontaj, oltre ai suoi scritti, e alla sua autobiografia (1926), abbiamo utilizzato:
C. Porter, Alexandra Kollontai. A biography, Virago, 1980.
Capitolo 16
Sempre sul solito pastvu.com si possono vedere diverse fotografie del cantiere per la costruzione della Casa del Governo (Dom pravitel’stva).
 Il paradosso del collettivista solitario, unico testimone per un’epoca futura, viene affrontato in A. Bogdanov, Il decennale… op. cit.: “«Il collettivista non è un sostenitore delle decisioni prese a maggioranza di voti, ma un sostenitore della risoluzione scientifica dei problemi.» Per lui «non è esclusa la possibilità che sorga una situazione nella quale egli è solo contro tutti» e nondimeno è nel giusto, perché affidandosi alla scienza, egli « vede ciò che gli altri mancano di vedere o conoscere»”(D. Steila, Prefazione, op. cit. Traduzione nostra dalla versione inglese).
Il paradosso del collettivista solitario, unico testimone per un’epoca futura, viene affrontato in A. Bogdanov, Il decennale… op. cit.: “«Il collettivista non è un sostenitore delle decisioni prese a maggioranza di voti, ma un sostenitore della risoluzione scientifica dei problemi.» Per lui «non è esclusa la possibilità che sorga una situazione nella quale egli è solo contro tutti» e nondimeno è nel giusto, perché affidandosi alla scienza, egli « vede ciò che gli altri mancano di vedere o conoscere»”(D. Steila, Prefazione, op. cit. Traduzione nostra dalla versione inglese).
Anche la fabbrica Ottobre Rosso e la diga Bab’egorod si possono ammirare su pastvu.com, così come la “melmosa strada dedicata a Kropotkin”, lo stabilimento balneare, la piattaforma dei tuffi (visibile anche nel film Moskva, già citato) e il ponte di Crimea, dove Bogdanov e Dmitriev si salutano.
Capitolo 17
Il dialogo tra Denni e Bogdanov intorno alla questione della réclame dei prodotti, si rifà in particolare a due articoli:
Cox, «NEP Without Nepmen!» Soviet Advertising and the Transition to Socialism, in Everyday life in early soviet Russia, op. cit.
O. Kravets, Ö. Sandıkçı, Marketing for Socialism: Soviet Cosmetics in the 1930s, in “Business History Review”, 87, autunno 2013.
Capitolo 18
Per ricostruire la figura del commissario del popolo alla Salute pubblica, Nikolaj Semaško, abbiamo fatto riferimento agli articoli:
T. Zahariev, I. Zaprjanov, Nicolaj Aleksandrovič Semaško, in “Folia Medica”, vol. 9, n. 6, 1967.
A. J. Haines, Health work in soviet Russia, cap. 4: “Dr. N. A. Semaško. The Commissar of Health”, Vanguard, 1928.
Il primo e unico figlio di A. Bogdanov e Natal’ja Korsak nacque il 22 giugno 1896. Pesava circa un chilo e la madre doveva alimentarlo con il contagocce. Morì il 20 agosto dello stesso anno. Qualche tempo dopo, nel 1903, Natal’ja dovette affrontare un’operazione delicata che le tolse la possibilità di avere altri figli. (vedi J. Biggart, J. D. White (a cura di), A memoir of Natalia Bogdanovna…, op. cit.)
Le argomentazioni di Lenin contro Bogdanov, intorno alla scuola di Capri e all’empiriomonismo, si ricavano dai suoi scritti del 1908-1909, ovvero:
V. I. Lenin, Opere complete, Editori Riuniti, 1963 : Vol XIV [Materialismo ed empiricoriticismo] e Vol XV [marzo 1908 - agosto 1909].
Il problema di come gestire la cassa del Centro bolscevico fu senz’altro una della ragioni che acuirono lo scontro filosofico e politico tra le due fazioni in lotta. Alcuni storici, con un’interpretazione “materialista-leninista”, sostengono che la faccenda economica fu prioritaria rispetto alle altre. Nel romanzo, abbiamo riprodotto il punto di vista di Bogdanov, ma non mancano i testi dove lo si accusa di aver messo le mani su una parte dei soldi e di averli usati per i suoi scopi, senza autorizzazione. Altri ritengono che Lenin abbia “fatto fuori” Bogdanov e Krasin nel momento in cui, grazie ad altre manovre, riuscì a raggiungere un’indipendenza economica dai due.
 Sul sito Paris Révolutionnaire, è possibile vedere come appariva la facciata della Maison Commune del Terzo Arrondissement di Parigi, in rue de Bretagne 49, dove si tennero le riunioni della redazione allargata del Proletarij. La pagina contiene anche i riferimenti a molti altri luoghi bolscevichi della città.
Sul sito Paris Révolutionnaire, è possibile vedere come appariva la facciata della Maison Commune del Terzo Arrondissement di Parigi, in rue de Bretagne 49, dove si tennero le riunioni della redazione allargata del Proletarij. La pagina contiene anche i riferimenti a molti altri luoghi bolscevichi della città.
I dettagli del confronto parigino sono raccontati in J. E. Marot, Alexandr Bogdanov, Vpered, and the role of the intellectual…, op.cit.
I documenti pubblicati dal Proletarij sulla conferenza di Parigi si trovano in:
V. I. Lenin, Opere Complete, op. cit., Vol. XV, pp. 401 - 432.
Da notare che Bogdanov viene sempre indicato con lo pseudonimo che allora usava all’interno del POSDR, ovvero Maksimov.
L’idea che Lenin intendesse allontanare Bogdanov per ricucire con Plechanov, è espressa in A. Bogdanov, Il decennale della scomunica…, op. cit.
Il nome del gruppo e della rivista fondati da Bogdanov, Lunačarskij e altri - Vperëd [Avanti] - è identico a quello del primo giornale illegale bolscevico pubblicato da Lenin, e dallo stesso Bogdanov, a Ginevra, tra dicembre 1904 e maggio 1905.
Capitolo 19
Le lettere di Lenin agli organizzatori e agli alunni della scuola di Capri si trovano in:
V. I. Lenin, Opere Complete, op. cit., Vol. XV, pp. 447 - 456.
L’alunno della scuola di Capri che scrisse un articolo sulla sua esperienza è:
V. Kosarev, Partijnaja škola na ostrove Kapri [La scuola di partito sull’isola di Capri], in “Sibirskie Ogni”, n. 2, maggio-giugno 1922, pp. 63 - 75.
Le lettere che testimoniano la rottura dei rapporti tra Bogdanov e Gorkij sono:
- La n.12 del Fascicolo 3 (“Corrispondenza 1910-1911”) del carteggio “Gorkij-Bogdanov e scuola di Capri” presso la Fondazione Basso. Spedita da Bologna il 10/10/1910. Bogdanov chiede conto allo scrittore della diceria sulla sua fuoriuscita dal gruppo Vperëd.
- La n.15 dello stesso fascicolo e carteggio, spedita da Capri alla fine del 1910. Gorkij rinfaccia Bogdanov di trattarlo come “un soldato semplice del vostro plotone” e conclude la lettera scrivendo “s’intende che questo è […] il nostro ultimo colloquio”.
(le frasi di questa lettera riportate nel romanzo sono prese dall’articolo di J. Scherrer, Gorkij-Bogdanov, op.cit. e tradotte dal francese).
Abbiamo rintracciato l’indirizzo della scuola di Bologna incrociando un’informazione contenuta nell’articolo di J. Scherrer, Les écoles…, op. cit (la scuola era presso l’Università popolare G. Garibaldi) con l’articolo di L. Arbizzani, Dalla lega per l’istruzione del popolo alla Università popolare di Bologna, in “Emilia”, n.25, nuova serie, anno III, marzo 1954 (la nota 12 riporta l’intestazione di una circolare dell’Università G. Garibaldi, datata 1901, dove si specifica che la sede si trova in via Cavaliera, 22 - Casa della Società Operaia di Mutuo Soccorso). Via Cavaliera è l’attuale via Oberdan.
Bogdanov, nel suo soggiorno bolognese, risiedeva con Lunačarskij poco lontano, in via Marsala 16, come si evince dalle lettere del Fondo A. A. Bogdanov, Fondazione Basso. R.C. Elwood, Lenin and the social democratic schools, op. cit, afferma che le lezioni si tenevano in questo appartamento di 4 stanze. In nessuno dei luoghi c’è una targa o un ricordo di quel che accadde.
Per delineare alcune caratteristiche del personaggio di V. Menžinskij abbiamo utilizzato:
D. Rayfield, The exquisite inquisitor: Viacheslav Menzhinsky as poet and hangman, in “New Zealand Slavonic Journal”, 2003, pp. 91 - 109.
Il palazzo dei magazzini Mostorg, tra i capolavori della Mosca costruttivista, si può ammirare su pastvu.com. Oggi è occupato da un negozio Benetton.
 Sul rapporto tra tectologia, Proletkult e costruttivismo, si veda:
Sul rapporto tra tectologia, Proletkult e costruttivismo, si veda:
S. Poustilnik, “Alexandr Bogdanov’s Tektology: A science of construction” in Culture as Organization, op. cit.
Sui rapporti tra la scuola di Bologna e quella “leninista” di Longjumeau, oltre al solito, fondamentale articolo di J. Scherrer, Les écoles…, ci siamo basati su:
R. C. Elwood, Lenin and the Social Democratic Schools…, op. cit.
Sulle tensioni all’interno del partito comunista e l’attività dell’Opposizione Unita, con particolare riferimento alla città di Mosca, abbiamo trovato spunti e informazioni in:
C. A. Merridale, The communist party in Moscow 1925 - 1932, University of Birmingham, Ph.D. thesis, 1987.
Capitolo 20
Alla torre radio di Šukov, oggi piuttosto male in arnese, è dedicato un lungo passaggio del già citato documentario Moskva (1927), ed è possibile vederla in diverse fotografie di pastvu.com
Non è facile farsi un’idea precisa di come Bogdanov intendesse il rapporto tra uomo e natura. Negli Essays in tektology sostiene chiaramente che il primo deve dominare la seconda, renderla umana. Quindi hanno ragione quanti sostengono che Bogdanov - e con lui tutti i marxisti della sua epoca - hanno denunciato il dominio dell’uomo sull’uomo ma non quello dell’uomo sulla natura. Tuttavia, la sua idea di “stabilità del sistema”, basata sulla ricerca di un equilibrio dinamico con l’ambiente e di un reciproco aggiustamento tra uno e l’altro, fanno intravedere ad alcuni studiosi i germi di un pensiero ambientalista. Su questo, in particolare:
A. Gare, Soviet environmentalism: the path not taken, in “Capitalism, Nature, Socialism”, vol. IV, n. 4, 1996.
Mc Kenzie Wark, Molecular red…, op.cit.
 Capitolo 21
Capitolo 21
In una mail di osservazioni e commenti, dopo la lettura in anteprima del romanzo, Daniela Steila ci ha raccontato i retroscena finanziari della rottura di Bogdanov con il gruppo Vperëd. Il nostro doveva prendere soldi dalla cassa per girarli alle famiglie dei georgiani in carcere per la rapina di Tbilisi, ma non poteva dichiarare che quello era lo scopo, perché l’accordo lo aveva fatto lui da solo, con Kamo, e non tutti l’avrebbero condiviso.
Immagini d’epoca del parco di Montsouris si possono osservare in una serie di cartoline pubblicate on-line.
Le circostanze della nuova scomunica di B., questa volta escluso dalle pagine della Pravda, ma sempre per mano di Lenin (con Zinov’ev e Kamenev), sono descritte da A. Bogdanov, Il decennale…, op. cit. e da D. Steila nella sua prefazione al volume. La rubrica per la quale Bogdanov scrisse da marzo a maggio 1913 si intitolava “Dal dizionario delle parole straniere” e illustrava in maniera divulgativa i principali concetti del marxismo e delle scienze sociali.
I versi che iniziano a pagina 197 e intervallano il capitolo sono tratti da:
A. Bogdanov, Nine [A Nina - diminutivo di Anfusa], in “Vestnik Meždunarodnogo Instituta A. Bogdanova”, n.4, 2000.
Capitolo 22
Questa è la stazione Leningradskij di Mosca negli anni Venti.
L’articolo di Aleksandra Kollontaj, L’opposizione e la base del partito, pubblicato sulla Pravda nell’ottobre 1927, è citato, senza fonte, in:
C. Carpinelli, Donne e famiglia nella Russia sovietica. Caduta di un mito bolscevico., Franco Angeli, 1998.
Si tratta di:
A. Kollontaj, Opposicija i partijnaja massa, in “Pravda”, 30 ottobre 1927.
Capitolo 23
Qui si può ammirare una bella selezione di fotografie della Prima esposizione mondiale di apparecchi e veicoli interplanetari.
 La mostra si tenne a Mosca da febbraio (in realtà, per ritardi, aprì il 24 aprile) a giugno del 1927. Nel romanzo, immaginiamo che l’abbiano prolungata di qualche mese, per permettere a Denni di visitarla con comodo.
La mostra si tenne a Mosca da febbraio (in realtà, per ritardi, aprì il 24 aprile) a giugno del 1927. Nel romanzo, immaginiamo che l’abbiano prolungata di qualche mese, per permettere a Denni di visitarla con comodo.
Preziosi dettagli sull’esposizione si trovano in una sterminata opera in più volumi, pubblicata in Unione Sovietica nel 1929, e poi tradotta su commissione della NASA:
N. A. Rynin, Interplanetary flights and communication, Vol. 2, n. 4: “Rockets”, pp. 201-207, Israel program for scientific translations, 1971.
Altre informazioni sulla mostra le abbiamo ricavate da libri e articoli in russo, in particolare:
A. Pervušin, Kosmonavty Stalina. Mežplanetyj prorvy sovetskoj imperii [I cosmonauti di Stalin. La svolta interplanetaria dell’impero sovietico], cap. 2.2, Ėksmo, 2005.
V. Zotov, Na prove zvezdnogo veka [Sulla soglia dell’era stellare], in “Ural’skij sledopyt”, n. 11, 1977, pp. 52-54.
La poesia “All’inventore” di Sergeevič è citata sia nel libro di Rynin che in quello di Pervušin.
Sui primordi della cosmonautica - sovietica e internazionale - abbiamo consultato:
F. H. Winter, Prelude to the space age. The rocket societies 1924 - 1940, Smithsonian Institution, 1983.
Un altro volume molto interessante è il racconto, scritto a quarant’anni di distanza, da uno dei protagonisti delle prime associazioni sovietiche per lo studio dei viaggi interplanetari, bolscevico della prima ora e poi giornalista:
G. Kramarov, Na zare kosmonavtikij [All’alba della cosmonautica], Znanie, Moskva, 1965.
Negli archivi digitali on-line della biblioteca nazionale d’Estonia abbiamo rintracciato una copia della Grammatica della lingua AO, grazie alla quale l’Associazione degli inventori voleva risolvere tutti i problemi comunicativi e creativi del genere umano:
Grammatika panmetodologičeskogo jazyka AO [Grammatica della lingua panmetodologica AO], pubblicato in proprio, 5° anno dall’invenzione della lingua dell’Umanità AO (7° anno dalla Rivoluzione d’Ottobre).
L’autore del libretto non è specificato, ma sappiamo che si tratta di V. L. Gordin, filosofo “pan-archico” e membro dell’Associazione degli Inventori, dalla quale partì l’idea della mostra interplanetaria.
Sulla lingua AO e le sue caratteristiche, lo studio di riferimento è:
S. Kuznecov, Linguistica cosmica: la naissance du paradigme cosmique, in “Histoire Épistémologie Langage”, vol. 17/2, 1995.
(Una versione più aggiornata dell’articolo, in russo, è S. Kuznecov, Linguistica cosmica: roždenie «kosmičeskoj paradigmy», in “Lingvistika”, n. 2, 2014).
Grazie a Maria Sangermano, che da giapster volontaria si è sobbarcata un difficilissimo lavoro di traduzione, possiamo regalarvi il testo in italiano della grammatica AO, elaborata da Gordin nel 1919 e pubblicata nel ’24.
Capitolo 24
Dalle carte private e dall’epistolario, risulta che Natal’ja Korsak ha tradotto il romanzo Maria Donadieu di Charles-Louis Philippe tra il 1911 e il 1912. Non si hanno notizie della pubblicazione in russo di questo lavoro. (cfr. J. Biggart, J. D. White (a cura di), A memoir of Natalia Bogdanovna…, op. cit.)
Nel romanzo, immaginiamo che quindici anni dopo, Natal’ja traduca un altro romanzo dello stesso autore.
L’articolo di N. Elanskij che stronca le ricerche dell’istituto trasfusionale e le teorie mediche di Bogdanov, è una recensione di Bor’ba za žiznesposobnost’, op. cit, apparsa sul Žurnal dlia usoveršenstvovanija vrachei [Rivista per l’educazione continua dei dottori], 7-8, 1927 citata in N. Krementsov, A martian…, op. cit.
 Capitolo 25
Capitolo 25
Bogdanov prestò servizio come sottufficiale medico sul fronte russo Nord Occidentale, tra il luglio 1914 e l’estate 1915, con il 221° reggimento di fanteria.
Capitolo 26
Le gesta di Bogdanov sul campo di battaglia sono ispirate - in alcuni casi con citazioni dirette - al diario di guerra di un medico italiano:
G. Frontali, La prima estate di guerra, Il Mulino, 1998.
Alcuni brani del libro sono stati pubblicati on-line, in occasione del centenario della Grande Guerra:
1, 2, 3 e 4
Capitolo 27
Anfusa Ivanovna Smirnova (nata nell’agosto 1873) morì il 25 dicembre 1915.
Nel romanzo, Natalia porta a Bogdanov la triste notizia “poco prima di Natale”, cosa ovviamente impossibile. L’errore cronologico è dovuto al fatto che durante la stesura del romanzo non siamo riusciti a rintracciare notizie precise sul decesso di Anfusa. Sapevamo soltanto che era morta nell’autunno del’15. La data esatta è riportata in J. Biggart, J. D. White, A memoir of Natalia Bogdanovna, op.cit. . Da notare che i due autori scrivono sempre Anfusia invece di Anfusa, mentre tutte le altre fonti che abbiamo consultato riportano la seconda dizione, o in alternativa Anfisia.
 Il manifesto di Zimmerwald si può leggere on-line in diverse lingue, comprese inglese e italiano.
Il manifesto di Zimmerwald si può leggere on-line in diverse lingue, comprese inglese e italiano.
La “mozione della sinistra”, proposta da Lenin ed altri, è consultabile qui (in inglese).
La mozione venne respinta, nonostante il voto favorevole di 12 delegati, tra i quali anche Trockij.
Nel romanzo, scriviamo che Trockij firmò - con Lenin e altri - un addendum al manifesto, dove i sottoscrittori si dichiaravano insoddisfatti perché il testo non conteneva indicazioni su come battersi contro la guerra. In realtà, questo primo addendum fu firmato dai soli Lenin, Zinov’ev, Radek, Nerman, Hoglund e Winter, mentre il secondo addendum, contro i crediti di guerra, fu firmato anche da Trockij e Roland Holst.
La circostanza è chiarita in:
L. Trockij, The War and the International, appendice: “Two declarations on the Zimmerwald manifesto”, Wesley Press, 1971.
Abbiamo ricostruito le posizioni e l’attività di Bogdanov ai tempi della rivoluzione d’ottobre, mettendo insieme riferimenti e analisi sparse in vari testi. In particolare:
Z. Sochor, Revolution and culture, op. cit., part II: “After October: which way to socialism?”
A. Bogdanov, Voennyj kommunizm i gosudarstvennyj kapitalizm [Comunismo di guerra e capitalismo di stato], in Voprosy socializma, Mosca, 1918 (raccolta di articoli pubblicati nel 1917).
J. Biggart, Alexandr Bogdanov and the Theory of a «New Class», in “Russian Review”, op. cit.
Mentre scrivevamo, non era ancora disponibile un testo che mettesse in fila i dettagli che ci servivano. È uscito soltanto qualche mese più tardi:
D. Tepljakov, Revoljucija 1917 g. v traktovke A. A. Bogdanova [La rivoluzione del 1917 nell’interpretazione di A. Bogdanov], in “Vestnik Omskogo universiteta. Serija «istoričeskie nauki», n. 1 (17), 2018.
Il brano riportato delle “Tesi d’Aprile” di Lenin è una nostra traduzione dalla versione inglese, che si trova qui.
La risposta di Bogdanov alla lettera di Lunačarskij del novembre 1917, dove il vecchio amico gli offre un posto al ministero, si trova nella biblioteca on-line dei suoi scritti in russo:
“Pis’mo Lunačarskomu 19 nojabrja 1917 g.”, in A. Bogdanov, Voprosy socializma (sborink), Politizdat, 1990.
Capitolo 28
La procedura trasfusionale è descritta seguendo il manuale che lo stesso Bogdanov aveva reperito a Londra, durante il viaggio al seguito di Krasin:
G. Keynes, Blood transfusion, Londra, 1922, pp. 118 - 134.
 Lei idee di Bogdanov sull’immortalità sono state spesso travisate e non è stato semplice restituirle in maniera fedele. Nel tentativo, ci sono stati d’aiuto alcuni testi:
Lei idee di Bogdanov sull’immortalità sono state spesso travisate e non è stato semplice restituirle in maniera fedele. Nel tentativo, ci sono stati d’aiuto alcuni testi:
D. Steila, “Death and anti-death in russian Marxism at the beginning of the 20th century”, in Ch. Tendy (a cura di), Death and anti-death, volume 1: one hundred years after N.F. Fedorov (1829 - 1903), Palo Alto, 2003.
R. Tartarin, Transfusion sanguine et immortalité chez Alexandr Bogdanov, in “Droit et société”, n°28, 1994.
I. Stambler, Life extension – a conservative enterprise? Some fin- de-siècle and early twentieth-century precursors of transhumanism, in “Journal of Evolution and Technology”,Vol. 21, n. 1, mar. 2010.
Sul tema dell’immortalità e della fine della vita, Bogdanov scrisse un racconto molto significativo, che riecheggia nel dialogo con Bazarov e Kir’jakov. Fu pubblicato per la prima volta in russo, su una rivista di San Pietroburgo, nel 1912:
A. Bogdanov, Immortality day, in “e-flux journal”, n. 65, mag. - ago. 2015.
A proposito del “collettivismo fisiologico”, oltre alle opere già citate, l’articolo più ricco e completo che siamo riusciti a trovare è:
M. S. Sergeeva, «Physiological collectivism»: the origins of the Institute of Blood Transfusion’s ideas and their practical realization, in “History of Medicine”, Vol. 2, n 4. P. 420–430.
Bogdanov, di ritorno dal viaggio a Londra con Leonid Krasin, scrisse il suo primo testo scientifico sull’argomento (che già aveva affrontato, con le armi della narrativa, in Stella Rossa):
A. Bogdanov, O fisiologičeskom kollectivizme, in “Vestnik Meždunarodnogo Instituta A. Bogdanova”, n. 2 (14), 2003.
Le proposte di pianificazione economica di Vladimir Aleksandrovič Rudnev (1874 -1939), detto Bazarov, sono analizzate nel capitolo a lui dedicato in:
Jasny, Soviet economists of the Twenties: names to be remembered, CUP Archive, 1972.
Altre notizie si trovano in un interessante articolo dedicato al rapporto, in campo economico, tra la dialettica marxista e la “teoria dell’equilibrio” formulata da Bogdanov:
A. Belych, A. A. Bogdanov’s theort of equilibrium and the economic discussion of the 1920s, in “Soviet Studies”, vol. 42, n. 3, lug. 1990.
Sul rapporto tra i due vecchi amici e i loro scambi di opinione, abbiamo letto:
D. Steila, “From Experience to Organization: Bogdanov’s Unpublished Letters to Bazarov”, in V. Oittinen (a cura di), Aleksandr Bogdanov Revisited, Kikimora, 2009.
Bukharin, in un articolo dell’ottobre 1926, accusò Bogdanov e Bazarov di aver elaborato per primi la teoria della degenerazione burocratica e dell’emergere, dopo la rivoluzione, di una “nuova classe”. Il testo è citato in:
J. Biggart, Alexandr Bogdanov and the Theory of a «New Class», op. cit.
Uno dei “famigerati articoli” di Bazarov contro il governo bolscevico è:
V. Bazarov, What is needed for socialism?, ediz. or. in “Novaja Žizn’”, 190, 1-14 dic. 1917.
Capitolo 29
Devi scrivere un capitolo ambientato in una fabbrica sovietica del 1927 e hai bisogno di capire che tipo di saldatori si usavano allora? Niente paura, di sicuro nel mondo c’è qualcuno che li colleziona e almeno uno che li fotografa e descrive per il suo sito in Rete.
Le opinioni di Bogdanov sul taylorismo e la catena di montaggio mescolavano l’evidente apprezzamento per un’organizzazione più scientifica del lavoro, con un’embrionale consapevolezza dei suoi rischi in termini di sfruttamento:
A. Bogdanov, Meždu čelovykom i mašinoju. (O sistemy Tajlora) [Tra uomo e macchina. Il sistema di Taylor], San Pietroburgo, Priboj, 1913.
Anche Lenin scrisse a proposito di questi argomenti:
“Il sistema di Taylor - senza che i suoi promotori lo sapessero o volessero - prepara il tempo in cui il proletariato prenderà nelle sue mani la produzione e incaricherà i propri comitati operai allo scopo di distribuire e razionalizzare tutto il lavoro sociale”.
V. I. Lenin, “Il taylorismo asserve l’uomo alla macchina”, in Opere Complete, op. cit. , Vol. 20, pp. 141 - 143.
 Capitolo 30
Capitolo 30
Lo zoo di Mosca compare nel documentario Moskva (1927) e si può esplorare come appariva nell’anno che ci interessa grazie alle fotografie caricate su pastvu.com
La frase di Lunačarskij sui grandi geni del passato che fanno già parte della cultura proletaria, è contenuta in:
A. Lunačarskij, O proletarskoj kul’ture [Sulla cultura proletaria], in Opere Complete, Vol 7, Mosca, 1963.
La frase di Bogdanov sulla funzione dell’arte si trova in:
A. Bogdanov, “Proletariat i iskusstvo” [Proletariato e arte], in Voprosy Socializma, op. cit.
Sull’Internazionale della Cultura (Kultintern), abbiamo trovato di grande utilità:
J. Biggart, Alexander Bogdanov and the short history of the Kultintern, in “Vestnik Meždunarodnogo Instituta A. Bogdanova”, n. 3 (7), 2001 (versione rivista a nov. 2018).
La seconda edizione di Materialismo ed empiriocriticismo, pubblicata nel 1920 con una nuova introduzione di Lenin, contiene anche un’interessante appendice:
V. Nevskij, Dialectical materialism and the philosophy of dead reaction.
Capitolo 31
La parata militare per il decennale della rivoluzione, sopravvive in una breve ripresa di 2’44”.
Esiste anche una breve cronaca degli scontri di quel 7 novembre, scritta da Trockij cinque anni più tardi:
L. Trockij, The “uprising” of Nov. 7, in “The Militant”, Vol. 5, n. 6, 6 feb. 1932.
Come al solito, su pastvu.com, si possono vedere il Grand Hotel de Paris - sede della 27ª Casa dei Soviet e il palazzo della Lubjanka, come appariva prima di essere “unificato”.
Capitoli 32
Bogdanov scrisse un resoconto delle cinque settimane (8 sett. - 13 ott. 1923) passate nella prigione della GPU, sulla base di appunti presi durante il periodo di detenzione. Il diario è stato pubblicato, insieme alle lettere indirizzate a Dzeržinskij e ai verbali d’interrogatorio in Neizvestnyj Bogdanov, Vol 1, op. cit.
Una ricostruzione delle circostanze e dei motivi dell’arresto si trova in:
J. Biggart, Alexandr Bogdanov and the Theory of a «New Class», op. cit.
All’epoca dell’incontro che abbiamo immaginato tra Bogdanov e Leonid Voloch, nel novembre 1927, la GPU si chiamava ufficialmente OGPU (Direzione politica generale dello Stato), ma abbiamo preferito mantenere il vecchio nome, per non confondere il lettore e perché era rimasto comunque in uso nel parlato.
 Capitoli 33
Capitoli 33
Per gli esperimenti di V. Pravdič-Neminskij sull’elettroencefalografia, si veda:
A. Zani, Le origini storiche dell’elettroencefalografia, in “Storia e critica della psicologia”, Vol. 2, n. 1, giu. 1981.
La descrizione di Mosca dall’alto, come “immenso lago elettrico” e “groviglio di desideri e disperazione”, è ripresa da:
M. Bulgakov, Il maestro e Margherita, op. cit.
I. Ėrenburg, Nel vicolo Protocny, Dall’Oglio, 1963.
Capitolo 34
Sappiamo che Bogdanov tenne un accurato diario sul decorso della malattia che gli fu fatale, ma quello riprodotto in questo capitolo è di nostra invenzione. Una cronaca dettagliata dei suoi ultimi giorni si trova in:
S. Donskov, V. Jagodinskij, Poslednie dni A.A.Bogdanova. Chronika tragečeskich sobytij [Gli ultimi giorni di A .Bogdanov. Cronaca di eventi tragici], in “Vestnik služby krovi Rossii”, mar. 2006.
Questo è il testo in russo della poesia di Bogdanov dedicata alla moglie, scritta il 9 marzo 1915, mentre era al fonte:
A. Bogdanov, Nataše [A Nataša], in “Vestnik Meždunarodnogo Instituta A. Bogdanova”, n.4, 2000.
Che fine hanno fatto?
Natal’ja B. Korsak, dopo la morte del marito, visse con Kotik nell’appartamento della Dom Igumnova dove aveva sede l’Istituto trasfusionale. Continuò a lavorare in quelle stanze finché il palazzo non venne destinato all’ambasciata francese, nel 1937. Si trasferì allora nel distretto di Krasnaja Presnja, sempre insieme al figlio di Bogdanov, a sua moglie e - dopo un anno - alla nipotina Natal’ja. Morì per un infarto, all’inizio di marzo del 1945, davanti all’ingresso dell’istituto che aveva contribuito a fondare.
Anatolij Lunačarskij rimase Commissario del popolo all’istruzione fino al 1929. Nel 1933 venne nominato ambasciatore sovietico in Spagna. Morì a Mentone, il 26 dicembre dello stesso anno, per un malore, durante il viaggio verso Madrid.
Vladimir Rudnev, detto Bazarov venne arrestato nell’estate del 1930 e accusato di sabotaggio da un collega del Gosplan, imputato nel cosiddetto “processo ai menscevichi” del 1931. Il 25 aprile di quell’anno venne condannato a 5 anni di prigione. Fu rilasciato all’inizio del 1932 e visse in esilio fino al 1935, quando rientrò a Mosca. Morì di polmonite il 16 settembre 1939.
Aleksandra Kollontaj, dopo l’incarico in Norvegia, fu ambasciatrice in Svezia, dal 1930 al 1945. Dovette abbandonare la carica a causa di una grave malattia, che la ridusse sulla sedia a rotelle. Nel marzo 1945 fece ritorno a Mosca e ricevette un’onorificenza per la sua attività patriottica durante la seconda guerra mondiale. L’8 marzo del 1952, all’età di ottant’anni, fu ricoverata in ospedale con fortissimi dolori al petto. Morì il giorno successivo e venne sepolta nel cimitero di Novodevičij. Sui giornali sovietici, non apparve nessun ricordo ufficiale.
Maksim Litvinov (nato col nome di Meir Henoch Wallach-Finkelstein) fu ministro degli Affari esteri dal 1930 al 1939 e poi sollevato dall’incarico per via delle accuse, rivoltegli da Molotov, di non essere fedele alla linea del partito. Nel 1940 risultano piani, approvati da Stalin, per la sua eliminazione fisica. Dal 1941 al 1943 ricoprì l’incarico di ambasciatore negli Stati Uniti. Morì d’infarto il 31 dicembre 1951 e venne sepolto nel cimitero di Novodevičij.
Moris Lejtejsen fu arrestato il 12 maggio 1938, con l’accusa di spionaggio. Un anno dopo, il 16 aprile 1939 venne fucilato a Butovo-Kommunarka.
Nikifor Vilonov, il meccano-filosofo, dopo aver seguito le lezioni di Lenin a Parigi, morì di tubercolosi nel maggio 1910, a 27 anni, quando la direzione del partito aveva ormai deciso di assegnargli un posto nel comitato centrale.
Vjačeslav Menžinskij rimase a capo della polizia segreta per 8 anni, finendo per dirigerla da un divano, dove lo costringevano vari malanni. Morì il 10 maggio 1934, all’età di 59 anni. Il suo successore, A. Jagoda, processato nel 1938, dichiarò di aver determinato la sua morte, ordinando che non venisse curato correttamente.
Nadežda Krupskaja, dopo la definitiva ascesa di Stalin, ebbe incarichi di minor importanza. Rimase comunque attiva nel Commissariato per l’Educazione, membra del Comitato centrale del partito e del Soviet supremo dell’URSS. Morì per un’embolia addominale il 27 febbraio 1939, a settant’anni appena compiuti.
Aleksandr A. Malinovskij (detto Kotik), dopo la laurea, diventò ricercatore in scienze biologiche. Partecipò come ufficiale medico alla Seconda Guerra Mondiale e poi lavorò in istituti di ricerca di medicina, scienze naturali e tecnologia. Pensionato dal 1986, è morto dopo una grave malattia il 16 aprile 1996, all’età di 87 anni.
Georgij Plechanov ritornò in Russia, dopo 37 anni di esilio, in seguito alla Rivoluzione di Febbraio del 1917. All’inizio del 1918, a causa di problemi di salute dovuti alla tubercolosi, si trasferì in un sanatorio finlandese, nella cittadina di Jalkala. Il 30 maggio morì di un’embolia cardiaca, all’età di 62 anni.
Dopo la Rivoluzione, Maksim Gor’kij lasciò di nuovo la Russia, nel 1921, ufficialmente per motivi di salute. Visse a Helsinki, Berlino, Praga e infine si sistemò in una villa di Sorrento. Tornò in Unione Sovietica una prima volta nel maggio 1928, con un tour trionfale attraverso molte città. Nel 1929, visitò il “campo per scopi speciali” delle isole Solovki (considerato da Solženicyn il prototipo dei gulag). Gorkij scrisse un saggio sulla sua visita, appoggiando il sistema di rieducazione dei prigionieri. Si stabilì definitivamente in URSS dal 1933 e fu candidato 5 volte al Premio Nobel. Morì il 18 giugno 1936, per le conseguenze di un’influenza.
Il 10 aprile 1928, Aleksandr Bogdanov ebbe l’onore di un funerale di stato, durante il quale Bucharin pronunciò un appassionato discorso. Anche Semaško e Lunačarskij lo ricordarono con un necrologio sull’Izvestija e la Pravda. Il 19 giugno 1929, gli fu intitolato l’Istituto trasfusionale che aveva diretto per soli due anni.


Dopo il successo della serie tv in onda su Rai 1, arrivata alla seconda stagione, torna uno degli appuntamenti più attesi dai lettori, quello con i Bastardi di Maurizio de Giovanni.
Gli investigatori di Pizzofalcone sono diventati una squadra di prim'ordine. Hanno armonizzato le loro capacità pur portandosi dentro demoni e problemi personali. In Vuoto, però, devono fare i conti con un nuovo arrivo: Pisanelli, detto il Presidente, salvato da Marco Aragona, è in ospedale, e dal Piemonte arriva Elsa Martini, la più giovane Vicecommissaria del paese. Anche lei ha un lato oscuro ed è stata allontanata dal suo ambiente. È bella, capace, e rischia di turbare il fragile equilibrio di Pizzofalcone: «Cercavo un personaggio diametralmente opposto a Pisanelli, non per sostituirlo ma per rendere un altro aspetto dei Bastardi: in realtà lei è la più Bastarda di tutti, ha un passato drammatico e a Napoli riempe il suo vuoto tanto da decidere di rimanerci con la figlia» (Maurizio de Giovanni intervistato da Generoso Picone, «Il Mattino»)
Iniziare un romanzo nero, di quelli che vanno a cercare le ombre nel buio delle anime, col rumore di una carezza può sembrare forse strano. Ma se si tratta dei Bastardi di Pizzofalcone, che con le ombre proprie e altrui combattono sempre, forse tanto strano non è. Maurizio de Giovanni
Il caso è delicato: Chiara Fimiani, insegnante di lettere e moglie di un ricco industriale che si sta preparando ad entrare in politica, è sparita. Si sentiva minacciata e lo aveva confessato a una collega. L'indagine costringerà i Bastardi a muoversi con prudenza in un ambiente di uomini potenti: «La scomparsa di Chiara disegna un vuoto e l'unica cosa da fare è scavare per capire e arrivare a una verità» (Maurizio de Giovanni, «Il Mattino»).
Dopo l'incontro a tema «Bastardi» al festival Bookcity di Milano, Maurizio de Giovanni presenterà Vuoto al Teatro Diana di Napoli il 29 novembre: «Sarà una cosa diversa da ogni altra presentazione. Un vero spettacolo. Vi aspetto tutti».

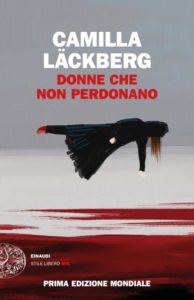
Tre donne: Ingrid, Birgitta e Victoria. Umiliate, offese, disprezzate dai loro compagni ma costrette a vivere al di fuori delle mura domestiche una vita «normale», come se niente fosse. Sullo sfondo una Svezia che sembra guardare distrattamente l’onda del movimento #MeToo, anche se avrebbe molto su cui interrogarsi, come sostiene la stessa Camilla Läckberg nell’intervista rilascia a D - la Repubblica: «La gente crede che la Svezia sia una società egualitaria. Certo stiamo meglio che da altre parti, ma ancora oggi ci sono il pay gap, molto sessismo e violenza. Una vera vergogna! Nessuna classe sociale è esonerata. La sopraffazione è questione di potere».
Donne che non perdonano parte da qui, da queste tre donne che si sono stancate di subire e hanno il desiderio di vendicarsi. Ingrid è la moglie di un famoso direttore di giornale: ha sacrificato la propria carriera per quella del marito che, oltretutto, la tradisce. Victoria è una donna russa a cui hanno ucciso l’ex compagno gangster davanti ai suoi occhi e che ora si ritrova prigioniera di un ubriacone obeso che la tratta «come una bambola gonfiabile capace anche di cucinare e tenere pulita la casa». Infine c’è Birgitta, la dolce maestra apprezzata da tutta la comunità che deve combattere contro una malattia trascurata a causa delle violenze costanti del marito. Le tre storie «si intrecciano in un crescendo di suspense e violenza fino a culminare in un finale sorprendente e liberatorio» (Mara Accettura,«D - la Repubblica»).
L’autrice, una vera star internazionale i cui precedenti romanzi hanno ispirato anche una serie tv, non nasconde che il suo ultimo lavoro non è solo un thriller ma anche un libro impegnato sulla solidarietà femminile, che deve far riflettere: «Con l’età ho realizzato che ho una voce pubblica e che la gente mi ascolta. Ora voglio usarla per parlare di temi che mi stanno a cuore» (Camilla Läckberg, intervistata da Mara Accettura, D – «la Repubblica»).
Donne che non perdonano è «femminista e femminile, con le protagoniste filtrate dalla divertita e commossa partecipazione della giallista. Prima lascia emergere le sofferenze, poi si staglia l’attimo preciso dell’”Adesso basta!”, infine arriva un sadico divertimento che aumenta di pagina in pagina» (Piero Colaprico, «la Repubblica»).