Autore: Editor Einaudi

Il 2 aprile è uscito Almarina, il nuovo romanzo di Valeria Parrella. È la storia dell’incontro nel carcere minorile di Nisida fra Elisabetta, insegnante di matematica cinquantenne che ha perso da poco il marito, e Almarina, una ragazza romena di sedici anni con alle spalle una storia di violenza familiare.
Fra le due donne nasce un legame che non può essere spezzato, soprattutto quando si affaccia per entrambe la speranza di poter ricominciare una nuova vita. L’autrice racconta la libertà di due solitudini con una voce calda, intima, politica, capace di schiudere la testa e il cuore.
Il romanzo ha ricevuto subito un’eccezionale accoglienza da parte della critica e di molte firme autorevoli del mondo letterario italiano:
«Valeria Parrella scrive, e con la scrittura arriva in cima alle montagne, guarda il mondo dall’alto: dall’alto il mondo è così piccolo che puoi tenerlo in una mano. Lei lo tiene e lo racconta da un punto minuscolo, la guardiola del carcere di Nisida, la piccola isola all’estremità della collina di Posillipo: quando la sbarra si richiude alla spalle di una donna che insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Valeria Parrella da quella guardiola, apre all’immensità […] Il romanzo di Valeria Parrella compie questo percorso miracoloso: prende il lettori in un punto e lo trasporta in un altro punto, gli offre il mondo dall’alto, e in centoventi pagine tese e illuminate gli cambia lo sguardo».
Annalena Benini, «Il Foglio»
«Almarina di Valeria Parrella è uno dei libri più belli usciti negli ultimi anni: un racconto intenso, struggente, scritto con una lingua stupenda. Quando l’italiano diventa musica, musica che affonda le unghie nella realtà, si segna la storia della letteratura».
Caterina Bonvicini, link
«E ciò che l’io narrante chiama “la staratura di Nisida”. Ed è dentro questa staratura che il romanzo di Parrella offre un ulteriore livello di lettura, quello di una delicatissima storia d’amore, che ha perfino un che di fiabesco, appunto, per quanto di un fiabesco non privo di ombre, dove la protagonista si prepara a rimettere in discussione tutta la sua “vita di usura”, quando un giorno a lezione arriva una ragazza nuova […] Il romanzo però non offre risposte facili, nemmeno nel finale, perché la vita stessa non risposte facili, così come la Napoli che qui fa da sfondo, anche se quasi in lontananza, sembra sempre alludere a qualcos’altro: a una città prima della città, alla ricerca di una innocenza perduta per sempre».
Fabrizio Coscia, «Il Mattino»
«Valeria Parrella ha scritto un libro che racconta questo: l’amore perfetto. Quello che non vuole niente in cambio, che non ha un motivo per darsi. L’amore che non c’è. Nel difetto e nel dolore […] La sola recensione possibile a questo libro dovrebbe durare un secondo, essere di una parola: leggetelo».
Concita De Gregorio, «la Repubblica»
«Ci sono un'infinità di passi talmente densi e folgoranti che diventa istintivo fermarsi, rileggere, lasciar agire (come un balsamo per capelli o fate voi). La scrittura di Parrella è come se non avesse tempo di menarla per le lunghe davanti alla precarietà della vita di chiunque, ma è il contrario di ciò che associamo all'aggettivo "essenziale". È una scrittura che cattura lo scorrere incessante di cose, odori, sapori e altri incontri sensoriali da cui nascono pensieri e sentimenti che hanno la stessa plasticità della materia. […] Nessuna scrittrice come Parrella è capace di cogliere nella sua città la linfa ancora viva di una colonia greca di nome Neapolis».
Helena Janeczek, link
«Ogni volta che esce un libro di Valeria Parrella lo aspetto come si aspetta una lettera importante che mi riguarda».
Nicola Lagioia, link
«La sua qualità di scrittura, la rotondità e la precisione nei dettagli è qui costante, non cala mai, non ha mai un attimo di respiro, di bisogno di ricaricarsi […] Parrella ha raggiunto l’apice della sua maturità. Ciò può apparire scontato, ma non lo è affatto, perché sono tanti gli scrittori che negli anni non riescono più a migliorarsi».
Francesco Piccolo, «la Lettura – Corriere della Sera»
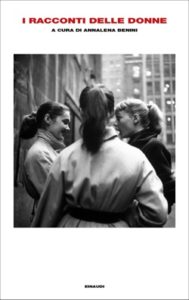
Venti storie. Venti autrici. Da Virginia Woolf a Chimamanda Ngozi Adichie, da Clarice Lispector a Patrizia Cavalli… intelligenza, sincerità e ironia descrivono un mondo vivissimo e sempre in movimento. Ne I racconti delle donne, curato da Annalena Benini, «parlano voci diverse e potenti, spiazzanti e libere, soprattutto libere, di quella libertà che viene dalla gioia e premia il coraggio portando la luce dopo il disastro; tutte le protagoniste hanno vissuto un dislivello di potere, hanno percepito l’attimo in cui l’immagine che avevano di sé si incrinava, si spezzava modificandole per sempre, e hanno saputo raccontarne le conseguenze con onestà, dolore e a volte ironia» (Nadia Terranova, «Il Foglio»).
L’amicizia, l’invidia, l’amore, lo smarrimento, il sesso, la paura, l’ambizione, i figli, gli uomini, le risate, il coraggio: «Alcuni racconti sono di inarrivabile magnificenza, come Quello che si ricorda di Alice Munro o Oggetto d’amore di Edna O’Brien, altri intelligentissimi e di tecnica sopraffina, come La presentazione di Virginia Woolf, una specie di spin of di Mrs Dalloway, o Amiche di Grace Paley» (Elena Stancanelli, «D – la Repubblica»).
«Questi racconti li vedi esplodere. Li vedi prendere forma sotto i tuoi occhi, parola dopo parola, infuocarti la testa mentre stai leggendo, insinuarsi nei tuoi ricordi e nella tua esperienza e in quello che sai di te e del mondo, infilarsi di diritto nella vita che fai, che hai, oltre quello che hai letto, dopo quello che hai letto, e continuare a tuonare in lapilli dentro di te. Questi racconti sono tra i più belli che ho letto» (Antonella Lattanzi, «La Stampa»).
La raccolta composta dalla curatrice ha un respiro contemporaneo, raccontare le donne d’altronde significa raccontare una forza che all’improvviso squarcia tutto, oppure si nasconde, o cammina piano e prepara la strada a chi verrà dopo: «si divertono, scrivono, fanno figli, amano e odiano, ma sono vittime di un segreto, qualcosa che vorrebbero ignorare ma incombe: la necessità di sentirsi legittimate. Preziosa questa antologia, anche per le accurate postille di Benini a ogni racconto» (Elena Stancanelli, «D – la Repubblica»).
«Il lettore uomo, alla fine di questo libro, non riesce a capire meglio, a capire non in senso razionale ma come intelligenza emotiva, forma di conoscenza empatica, quale sia la specificità femminile della letteratura scritta da donne. Ma forse può capire che il filo rosso, ciò che avvicina scrittrici sideralmente lontane come Dorothy Parker e Yourcenar, è il come, non tanto il che cosa. Un come che si esprime in un modo di raccontare con una felice spudoratezza che forse, gli scrittori uomini, più attenti, più prudenti, più sicuri di sé, più stanchi, senza il bisogno di sentirsi “legittimati”, non riescono più a mettere tra le pagine» (Pierluigi Battista, «Corriere della Sera»).

Armand Gamache, il commissario capo della Sureté del Quebec nato dalla penna di Louise Penny e definito dal Times «uno dei detective più memorabili in circolazione», si presenta subito ai lettori: è seduto sul banco dei testimoni e sembra a disagio davanti alle domande del procuratore stranamente ostile e sarcastico. Al centro del processo un omicidio, alla sbarra il presunto assassino. Lo sfondo, dietro alle domande del procuratore e i ricordi del poliziotto, è Three Pines, villaggio immaginario nella foresta canadese, un posto che sembra un porto sicuro, ma che è invece la maglia di una rete di narcotraffico che il commissario vorrebbe sgominare. «Il protagonista assoluto non è l’assassino, e non è neppure Armand Gamache, che pure riveste il ruolo di capo della polizia canadese: il vero protagonista è l’atmosfera che ti cattura sin dalla prima pagina e non ti lascia andare sino al climax finale» (Massimo Vincenzi, «La Stampa»).
Il racconto coinvolge il lettore, lentamente, con abilità; si è subito attratti da una figura inquietante, rievocata da Gamache: «Appena il poliziotto mite e bravissimo dice ho capito che stava succedendo qualcosa di strano quando ho visto la figura con la tonaca nera nel parco del villaggio, ecco che ormai ci sei, dentro la ragnatela, stordito e affascinato, come succede ai lettori di un bel giallo che funziona» (Carlo Lucarelli, «la Lettura – Corriere della Sera»).
Louise Penny ha, nell’arte dell’indagare nella mente degli uomini, la capacità di creare nodi per poi scioglierli con un’abilità da maestra. Massimo Vincenzi, «La Stampa»
Ed è proprio da questo personaggio, che sembra un sinistro mietitore di vite, che inizia la vicenda che Louise Penny racconta con stile, da vera giallista: «È il primo libro che ho letto di Louise Penny […] E non conoscevo l’ispettore capo Armand Gamache con la sua squadra di poliziotti, tra cui Louiselle Lacoste, che dirige la Omicidi e che parla con i morti, promettendogli di prendere l’assassino. Non so come si sentano le mosche invischiate al centro del bozzolo in attesa del ragno. Male, penso. Io invece mi ci sento bene e aspetto così il prossimo libro di Louise Penny e Armand Gamache, e so che ce ne saranno tanti. Perché questo libro è come una ragnatela. Bello» (Carlo Lucarelli, «la Lettura – Corriere della Sera»).
Il romanzo è costruito su due piani temporali diversi: «A novembre la pace del paesino è turbata da una presenza inquietante – una figura incappucciata e con un manto nero che si piazza in mezzo a uno spazio pubblico – e da un delitto che sembra legato a quell’entità misteriosa. A luglio, invece, si svolge un processo che vede Gamache sul banco dei testimoni, incalzato da un magistrato che gli appare ostile» (Giuliano Aluffi, «il venerdì – la Repubblica»).
Poi c’è il finale, «serrato, ricco di colpi di scena e di scontri che non ti aspetti nella quiete, tra i grossi alberi e gli animali che pascolano serene vicino agli uomini […] Tutto è da scoprire, perché Louise Penny ha, nell’arte dell’indagare nella mente degli uomini, la capacità di creare nodi per poi scioglierli con un’abilità da maestra. Ed ecco il trucco è tutto qui: non è un noir, non la Signora in giallo. Tutto sarà bene, fidatevi lettori» (Massimo Vincenzi, «La Stampa»).

Karl Marx è tornato attuale, in questi tempi difficili. Attuale come lo sono sempre i classici del pensiero. Con questa Biografia intellettuale e politica Musto ci riconsegna, senza la pretesa di essere esaustivo vista la ricchezza e la complessità del suo pensiero, un grande intellettuale che non appartiene solo al suo tempo e che, in questo saggio, «è diverso, sembra quasi un contemporaneo.
Musto presenta un Marx notevolmente diverso rispetto all’abituale, un Marx si potrebbe dire che appartiene ai nostri giorni e perfino un po’ al futuro» (Corrado Augias, «il venerdì - la Repubblica»).
L'autore è interessato a studiare gli anni maturi del filosofo, quelli che vanno dal 1857 al 1883, quando i suoi interessi e la sua attenzione alle vicende internazionali si allargano e nascono nuove curiosità verso le scoperte scientifiche: «Musto parte dalla critica dell’economia politica affiancandovi subito la ricostruzione dell’attività politica di Marx nel quindicennio considerato, esplora poi le ricerche antropologiche dell’ultimo triennio e conclude ripercorrendo la teoria politica che attraversa tutta la sua vita. L’afflato ‘militante’ della biografia di Musto si risolve nella rivitalizzazione del laboratorio analitico marxiano, fondamentale per giungere a una narrazione storica sensata del mondo contemporaneo, distinta e distante dalle diatribe correnti sulla ‘globalizzazione’ e sul ‘disordine mondiale’» (Giuseppe Vacca, «Il Sole 24 Ore»).
Nella ricerca di Musto è interessante il rilievo dato al ‘plusvalore’, cioè all’appropriazione da parte del padronato del tempo rubato gratuitamente agli operai, trascurando i loro bisogni di acculturazione e in genere di libertà nei rapporti sociali. Rossana Rossanda, «il manifesto»
È attento alla sua biografia perché è convinto che gli eventi della sua esistenza non siano slegati dall'elaborazione del suo pensiero; dedica grande e scrupolosa attenzione alla militanza politica, alla sua corrispondenza e ai manoscritti degli ultimi anni della sua vita. Il risultato di questa ricerca «è un’opera in ogni senso magistrale per l’acribia della documentazione filologica, il rigore della trattazione, la cristallina chiarezza espositiva, l’originalità dell’approccio interpretativo. Già autore di altri fondamentali contributi alla comprensione del pensiero marxiano, Musto ci consegna ora un testo che sconvolge il sonnolento scenario dell’esangue letteratura marxologica, per consegnarci la viva attualità del pensiero di un grande autore classico» (Umberto Curi, «Corriere della Sera»).
Uno studioso rigoroso come Musto sa bene che i molteplici interessi di Marx lasciano sempre aperti nuovi spazi interpretativi ma il suo lavoro arricchisce e soddisfa molte curiosità intellettuali; Secondo Rossana Rossanda nella ricerca dell’autore «è interessante il rilievo dato al ‘plusvalore’, cioè all’appropriazione da parte del padronato del tempo rubato gratuitamente agli operai, trascurando i loro bisogni di acculturazione e in genere di libertà nei rapporti sociali» («il manifesto»).

Nel dicembre del 2017 il New Yorker ha pubblicato, sia nella versione cartacea che sul proprio sito, un racconto intitolato Cat Person, di Kristen Roupenian, al suo esordio letterario. In pochi giorni il pezzo ha iniziato ad essere al centro di un forte dibattito e ha dato vita a moltissime conversazioni, fino a diventare il caso letterario dell’anno, il racconto più condiviso della storia.
L’omonima raccolta, dodici storie provocatorie su sesso, amicizia, piacere e rimpianto, è figlia di quel racconto. Margot ha 20 anni, lavora nel bar di un cinema dove incontra Robert, più grande di lei; si scambiano i numeri, si scrivono dei messaggi, escono a bere qualcosa ma poco dopo «lei cominciò a sentirsi tremendamente a disagio». L’incontro non è naturale, Margot non è sicura ma, nonostante tutto, ci fa sesso.
Raccontando di un sesso mediocre fatto sull’orlo del consenso ma non del desiderio, Kristen Roupenian ha esposto la questione meglio di mille articoli di cronaca sul tema: si può scegliere di esprimere un consenso circostanziale al sesso anche quando non esiste desiderio sessuale. Michela Murgia, «Robinson - la Repubblica»
«Cat Person non è una storia di stupro o molestie sessuali, ma, piuttosto, sul sottile confine tra gli esseri umani. Nell’estremo realismo con cui racconta un episodio banale, riesce a indagare le trappole, le manipolazioni e le delusioni del dating moderno. “Questa è fondamentalmente una storia che parla del consenso”, dice, “un concetto che ha molte nuance”» (Laura Pezzino, «Vanity Fair»).
La discussione intorno a questa storia si è subito accesa. Aiutata dal clima politico dopo l’elezione di Trump e dall’ascesa del movimento #metoo, ha scatenato forti reazioni: «Quando il racconto è apparso in rete, le prime a condividerlo sono state delle ragazze; dicevano che descriveva un’esperienza che avevano vissuto anche loro: l’idea che esista un punto oltre il quale è “troppo tardi” per sottrarsi a un rapporto sessuale. Si parlava anche, più in generale, del fenomeno del sesso fatto controvoglia quando si è spinte non dall’uso della forza ma da un cocktail micidiale di emozioni e aspettative sociali – imbarazzo, orgoglio, insicurezza a paura» (Kristen Roupenian, «Robinson - la Repubblica»). Poi però sono arrivati anche minacce, insulti e i toni si sono inaspriti. «Come ci si sente quando un proprio racconto diventa virale? Rispondere si sta rivelando imprevedibilmente difficile» (Kristen Roupenian, «Robinson - la Repubblica»).
Ma la forza di Cat Person è che «parlando di una specifica relazione tra due soggetti e raccontando di un sesso mediocre fatto sull’orlo del consenso ma non del desiderio, Kristen Roupenian ha esposto la questione meglio di mille articoli di cronaca sul tema: si può scegliere di esprimere un consenso circostanziale al sesso anche quando non esiste desiderio sessuale» (Michela Murgia, «Robinson - la Repubblica»).
Negli altri racconti della raccolta il preferito della Roupenian è Mordere: «Mentre la scrivevo avevo i brividi, è stato viscerale. Parla della frustrazione di non avere quello che si vorrebbe e, poi, di riuscire a ottenerlo […] Penso che sia tipico di noi donne interrogarci se quello che desideriamo sia giusto o sbagliato. Oddio, anche certi uomini lo fanno» (Kristen Roupenian intervistata da Laura Pezzino, «Vanity Fair»).
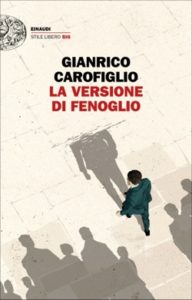
Il maresciallo dei carabinieri Pietro Fenoglio sta andando verso il congedo. Lontano dalla caserma per un'operazione all'anca e costretto alla fisioterapia, che vive come segno ineluttabile di senilità, non vede l'ora di riprendere il lavoro; anche se sa con sgomento che la pensione si avvicina.
Seguito da Bruna, una fisioterapista attraente ma indecifrabile, condivide il percorso rieducativo con Giulio, un giovane studente di Giurisprudenza che si sta affacciando alla vita con poche certezze, tranne quella di non voler fare l'avvocato come suo padre.
C’è insomma un’umanità dolente e imperfetta, che sbaglia, delinque, a volte uccide. Carofiglio la sdraia sul lettino con la tecnica inesorabile dell’analista, ma lo fa con tutta la pietas di cui ci sarebbe tanto bisogno in questo tempo cattivo. Massimo Giannini, «la Repubblica»
I due parlano, Fenoglio racconta le sue storie da investigatore, tre casi risolti dai quali emerge il suo metodo investigativo: «Gianrico Carofiglio è tornato sul luogo del delitto (letterario) che lo appassiona di più. Investigare sul crimine, per indagare la vita. Sviscerare il meccanismo col quale un bravo sbirro riesce a spremere da un fattaccio di cronaca qualche stilla di verità, per azzardare un metodo che ci consenta di conoscerci e riconoscerci per quello che siamo: il legno storto dell’umanità, per usare l’immagine di Isaiah Berlin» (Massimo Giannini, «la Repubblica»)
Investigare è un arte complessa, l'ego deve rimanere in disparte, bisogna saper costruire una storia, sapersi guardare intorno, saper riconoscere la menzogna, perché tutti mentono: «C’è la menzogna per la sopravvivenza individuale e collettiva: la verità sempre e comunque è un’idea astratta, un obbligo che può confliggere con l’imperativo morale» (Gianrico Carofiglio intervistato da Maria Grazia Ligato, «Io Donna Corriere della Sera»)
Il vecchio carabiniere che ha visto «centosettantuno morti ammazzati» e il giovane che non sa dare un senso alla sua vita condividono, attraverso le storie, un percorso che aiuterà a decifrare l'esistenza e che li cambierà entrambi. «C’è insomma un’umanità dolente e imperfetta, che sbaglia, delinque, a volte uccide. Carofiglio la sdraia sul lettino con la tecnica inesorabile dell’analista, ma lo fa con tutta la pietas di cui ci sarebbe tanto bisogno in questo tempo cattivo» (Massimo Giannini, «la Repubblica»).
Quali sono i segreti di Fedeltà, il nuovo romanzo di Marco Missiroli? Qual è stata la genesi del romanzo? Quanto c’è di autobiografico nelle storie di Carlo e Margherita?
Il 12 febbraio, a bordo di un vecchio tram nella sera milanese, l’autore ha ripercorso i luoghi principali del suo ultimo lavoro, rispondendo alle domande di alcuni amici della casa editrice e svelando dettagli intimi che lo hanno aiutato nella stesura del romanzo. La serata si è conclusa al bar Refeel, il locale dove Missiroli ha scritto Fedeltà: «Per tre anni, tutti i giorni, sei ore e mezza tranne il weekend. Avevo paura di scriverlo da solo. Ho ascoltato moltissimo The National e Conversations with myself di Bill Evans».
La serata ha avuto subito un tono confidenziale: «Sappiate che sul tram rispondo anche a domande alle quali non risponderei fuori. Appena il tram si ferma indosso la mia membrana». Sfondo di questo incontro ovviamente Milano, città che in Fedeltà è protagonista, quasi un personaggio del libro: «Si nasconde e si svela quando vuole lei. È un’amante capricciosa».
Anna Nadotti: Caro Matteo, ho cominciato a rileggere il tuo Holden - mi sa che facevo quarta ginnasio quando l'ho letto per la prima volta, e non mi segnò se non per qualcosa che non compresi e che forse, chissà, mi ha indotta ad accettare l’incarico di rivedere la nuova traduzione. Ora Holden riprende vita nella tua traduzione, che mi piace moltissimo. Holden, giovane nelle parole e nei tratti. Nel modo impacciato di cacciarsi in situazioni difficili. Con la sua fragile sicumera adolescente e gli spaventi esistenziali difficili a dirsi. E l’intelligente arguzia di Phoebe, più moderna che mai. Ne hai fatto, senza forzatura alcuna dell’originale, una ragazzina del nostro tempo. Sullo scarno paesaggio verbale allestito da Salinger nel 1946, hai lavorato con precisione meticolosa, con un orecchio attentissimo, con intuizioni linguistiche che del resto mi aspettavo dal traduttore di Yellow Birds.
Matteo Colombo: Oh, grazie mille Anna! Io sono qui che limo, scolpisco, soffio, starnutisco per la polvere. Direi che per giovedì il nostro piccolo amico sloggerà FINALMENTE da casa mia. E portandosi le valigie, stavolta.
AN: E io vado in bici a prendere le stampate in casa editrice. Poi con lo stesso mezzo le riporto costellate di appunti e proposte di vari colori, a penna e a matita. Un'artigianalità che, ai miei occhi, dà corpo alle cose e alle parole. E pedalando penso, rimugino, ascolto.
MC: Quanto ho apprezzato ciò che scrivi sull'artigianalità. Ti ringrazio di cuore. È bello parlare con te del nostro mestiere. Leggevo da qualche parte che forse, a breve, le mutazioni cognitive che l'essere umano sta attraversando nell'era digitale si manifesteranno in modo importante. Ma nel frattempo siamo ancora fatti in un altro modo, e rendiamo al meglio solo se possiamo lasciare che la mente unisca i puntini, effettui le sue associazioni, riempia gli spazi vuoti. Perciò evviva la bicicletta, evviva Berlino che, con i suoi grandi spazi e tutte le sue persone, riesce a calmarti lo spirito anche sotto un cielo bianco, e spazzata da un vento non più freddo.
MC: Non ho ancora trovato pace sulla questione «cazzo» (risate in sala). Ne ho aggiunti alcuni qua e là, per esempio per tradurre i rari my ass, che risultavano altrimenti troppo deboli, e ogni tanto facendoli pronunciare a qualcuno di particolarmente furioso. Ma ho lavorato molto a uniformare termini caratterizzanti come stuff, phony, can, moron, e una vocina in me continua a pensare che avrebbe senso tentare una sostituzione metodica in tutto il libro. Ho l'impressione che il nostro rigore sulle implicazioni psicologiche della ristrettezza lessicale e della tendenza alla ripetizione di Holden Caulfield sia una delle chiavi di volta di questa traduzione. Magari preparo davvero una seconda versione «virata cazzo».
AN: Sul cazzo non ho dubbi (standing ovation), lo usava già Leopardi. Ma sarei favorevole anche all'anacronismo «cazzeggiare».
Ah, sono riuscita a trovare Il club dei trentanove di Hitchcock, il film preferito di Phoebe. È del '35. Doppiato e distribuito subito dopo, viene ridoppiato nel '59. A quest’ultima edizione faccio riferimento. La prima era rigorosamente aderente ai dettami fascisti. Ho dato un’occhiata anche allo script originale:
«Do you like a haddock?»
«Le va un eglefino?»
L'eglefino (pesce di cui ignoravo l'esistenza) mi piace, trovo che è perfetto per il tuo Holden, anche se Salinger non lo saprà mai, e i suoi eredi ce ne chiederanno ragione.
MC: Quindi che eglefino sia, giusto?
AN: Eglefino sia!
MC: «Lo sa a memoria, quell'accidenti di film, perché ce l'avrò portata qualcosa come dieci volte. Quando per esempio il vecchio Donat arriva alla fattoria, mentre sta scappando dalla polizia e via dicendo, ecco, Phoebe nel bel mezzo del film dice ad alta voce - proprio nel momento in cui lo dice lo scozzese sullo schermo - "Le va un eglefino?" Sa tutte le battute a memoria».
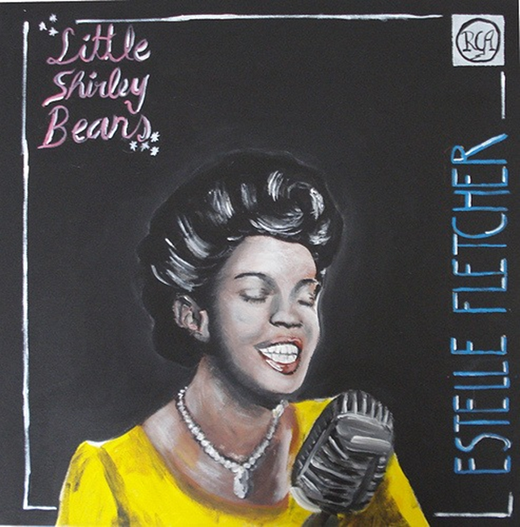
AN: Me la vedo Phoebe che precede gli attori nel dire le battute, in quella sala buia di un cinema newyorkese. Credo che le sarebbe piaciuto un sacco dire «eglefino» anziché haddock.
Io in questo preciso istante mi stavo interrogando su crazy face.
La soluzione arrabbiatissima - separata da faccia - non mi convince.
MC: Eh, ma infatti crazy, in questo libro, è uno dei termini più problematici, trovo.
AN: Be', diciamo che sono parecchi i termini problematici, perlopiù risolti. Qui mi pare proprio che la faccia sia quella particolarissima di Phoebe, con le sue orecchie piccole, i capelli rossi, carina e pensosa, più adulta della sua età. È arrabbiata, ma anche preoccupata. E quando finalmente toglie il cuscino e si lascia guardare, ecco la sua faccia bizzarra, particolare, in un certo senso unica agli occhi del fratello. Motti traduce «stralunata», ma trovo che fa un po' Pippi Calzelunghe.

MC: «Quando ho fatto il giro del letto e mi sono rimesso a sedere, ha girato la sua faccia buffa dall'altra parte. Mi stava tagliando fuori completamente». Che dici?
AN: Good! A proposito di Phoebe, eliminerei i diminutivi per i vestiti(ni). Io in generale evito, perché subito mi rimanda a immagini di maschietti e femminucce, due termini sui quali sempre si abbatte furiosa la mia matita. Per fortuna la madre di Holden e Phoebe compra alla figlia vestiti pratici, senza ricami, nastri e altri frizzi. Così Phoebe può pattinare tranquilla e pure «imparare a fare scoregge...» Perciò direi vestiti orrendi - e non vestire malissimo - quando Holden allude agli abiti degli altri bambini ricchi.
MC: Completamente d'accordo sui diminutivi. E anzi grazie, perché è una riflessione che non avevo mai davvero fatto, e di cui - insieme con il modo in cui mi hai insegnato a domare la mia eccessiva tendenza a ribaltare le frasi per renderle più naturali/colloquiali/italofone - farò prezioso uso in futuro.
AN: Be', caro signore, questo mi fa molto contenta. Ma mi racconti come se la passa con gli ultimi capitoli.
MC: Quest'ultima parte mi sta mettendo in difficoltà. Credo che mi si sia scatenata qualche insicurezza, forse per aver letto le correzioni in corso d'opera, e le mie soluzioni spesso non mi convincono. Come se non bastasse, verso la fine la traduzione di Motti migliora molto. A tratti è perfetta, e trovare un equilibrio, distanziarsi in modo non pretestuoso - riuscendo comunque a migliorarla - si sta rivelando difficile. Dopo quasi un anno di beata incoscienza, comincio ad avvertire la pressione.
AN:Capisco benissimo l'ansia: lo dico dopo Mrs Dalloway - e con il Faro all'orizzonte - dunque a ragion veduta... a esperienza fatta e in fieri. Non ti curar di lor ma guarda e passa, diceva un signore di mia conoscenza. E non è un cattivo insegnamento. Perché di solito mi consente di concentrarmi sull'essenziale, sulla cosa in sé, che nel tuo caso è Holden, la sua lingua connotatissima. E solo in seconda istanza la traduzione di Motti. Capisco la tua ansia performativa (ho letto Mrs D non so quante volte, prima di decidere che dovevo lasciarla andare), ma vorrei rassicurarti sulla buona tenuta della tua performance fin qui. Le mie correzioni, i miei suggerimenti in corso d'opera intendevano essere, anzi sono stati, anzi sono un contributo alla tua traduzione.
MC: Ti ringrazio per il calore della tua mail. Era il momento giusto per leggere quelle parole, perché stavo perdendo un po' il filo. E hai ragione in quello che dici: ultimamente ho spostato troppo l'attenzione sulla traduzione di Motti, impantanandomi in una terra di mezzo un po' nevrotica che rischierebbe di fare lo sgambetto alla mia cosiddetta «voce». Ancora una volta trovo cruciale potermi confrontare con te che sei alle prese con un lavoro di ritraduzione immane (il faro, correggimi se sbaglio, è ben più tosto della signora), e condividi quindi le sfumature di questo tipo di esperienza.
AN: Abbiamo quasi finito. Grazie Matteo, hai restituito a Holden la sua tenerezza, la sua ancora incerta sessualità, le sue paure, e con ciò anche quella madness-pietas di reduce che vedevo in Septimus Warren Smith... E nel modo in cui Holden guarda, descrive, capisce sua sorella Phoebe mi è sembrato di cogliere l’affetto, o forse l’amore di chi ha conosciuto se stesso, e per se stesso dispera. Truth («La verità mi fa male, lo sai…») E lo sapeva anche Salinger, che torna negli Stati Uniti gravato dalla memoria dei campi di battaglia e dei campi di concentramento europei, e relativa sindrome per cui venne ricoverato in una casa di cura.
MC: Truth, in effetti è un sostantivo pesante. È l'antitesi di quell'onnipresente phony, l'altro polo del manicheismo adolescenziale di Holden, e andrebbe preservato, soprattutto in apertura. Nel resto del libro sarei tentato di privilegiare una versione più veloce e sonora, «se proprio devo dire» o simili, perché a mio avviso, nel Catcher, la riflessione sul significato e sulla valenza dei singoli termini va costantemente stemperata con quella sulla tendenza di Holden alla ripetizione delle formule. Spesso ha l'effetto di svuotarle del significato, rendendole più simili a sintomi di dinamiche mentali, del suo bisogno di rassicurarsi e tenere sotto controllo la realtà con le parole, perché non si disgreghi del tutto.

AN: Sono assolutamente d'accordo. E sulle due questioni in sospeso dell'incipit cosa mi dici?
MC: Ripristinerò senz'altro la ripetizione di want, mantenendo però la mia prima versione di hear about it: «se davvero volete sentirne parlare». «Starmi a sentire» mi piace molto, ma trovo che sottolinei troppo l'accezione uditiva, a mio parere in contrasto con il fatto che si tratta di un testo scritto. «Sentirne parlare» al mio orecchio risulta più vago, e quindi più fedele.
AN: «Vagamente fedele», molto suggestivo.
MC: Ciao. Per quanto fantascientifico possa sembrarvi, ho finito. Ora mi straccio i vestiti e corro nudo a urlare per strada. Mi trovate sulle pagine esteri.
AN: Mi raccomando non farti arrestare, perché martedì ti aspettiamo in casa editrice.
MC: Arrivo!
Cara Anna,
siccome immagino che tu MUOIA dalla voglia di sapere cos'è successo a Holden dopo che il tuo lavoro si è concluso, eccoti un frizzante bollettino dalla trincea.
Le ultime tre settimane prima dell’andata in stampa sono state frenetiche. Ho trascorso ore e ore su Skype con l’editor Einaudi, rapiti da una foga di perfezione inebriante ma faticosissima. Sentivamo di giocarci la faccia, e quando siamo rimasti da soli a tirare la volata, ci ha preso la tensione. È stato tutto un lavoro di ripristino delle coerenze interne, di musicalità, di «de-colombizzazione» (ovvero la caccia ai miei tic linguistici, anche infinitesimali), ma soprattutto di progressiva modulazione del registro, anche questa infinitesimale. Un momento bellissimo, comunque, benché estenuante.
MC: Ora te lo posso dire: piaceva a tutti, questa traduzione, tranne a me. Mi mancava qualcosa di indefinibile, non sentivo di essere arrivato in fondo. Durante tutta la lavorazione, il mio pensiero costante è stato: «Fai, per una volta in vita tua, qualcosa al meglio delle tue possibilità». Finalmente sento di averlo fatto. Poi ho paura, sia chiaro. Ho cominciato ad avere incubi abbastanza pittoreschi sull'uscita del libro: ora che è finito, non riesco più a tenere a bada la tensione. Ma quest'esperienza incredibile non me la toglierà nessuno.
Anna Nadotti e Matteo Colombo

Il proscenio di questa storia divertente, ironica, paradossale, è un «sobborgo mediopolitano» circoscritto dalla privativa di sali, tabacchi e valori bollati dei fratelli Venanzio e Isaia Landemberger, soprannominati Fosforo, e dalla mescita Enterprise. La fonte che testimonia la vicenda umana di Buttarelli è Gualtieri, l'amico nullafacente.
Chi era Buttarelli? Un caso difficile sin da bambino, nella scuola convitto Dioscoride Polacco, quella dai molti divieti, dove la severa direttrice Maribèl non era in grado di far fronte ai suoi strani comportamenti. Buttarelli non mangiava, era ossessionato dalle differenze e dalle divisioni ma, soprattutto, studiava i libri a pagine alterne perché era in grado di leggere solo quelle di destra, quelle pari.
«Come già avveniva nei precedenti romanzi di Colagrande, il punto di vista coincide con una sorta di piano sequenza rasoterra dove tutto è narrato come se appartenesse al mondo minerale, e dove l’obiettivo talora si innalza ad altezze panoramiche da cui è possibile misurare l’universo e il destino. Senza discostarsi mai troppo da quella voce popolare semicolta che ha in Celati e Cavazzoni due indiscussi maestri, Colagrande declina la realtà in una direzione comica e stralunata che rende La vita dispari un libro su cui fissare la nostra attenzione» (Chiara Fenoglio, «la Lettura – Corriere della Sera»).
Un romanzo imperdibile, che si candida ad essere uno dei migliori della stagione. Fabrizio Ottaviani, «il Giornale»
L’autore ci trascina in un’inusuale e divertente parabola esistenziale offrendo varie chiavi interpretative e vari livelli di lettura, con un finale che è «un susseguirsi di colpi di scena che non vanno rivelati. Rimane la capacità di Colagrande di mettere insieme un romanzo che non è un romanzo ma che soprattutto non è italiano […] La sua scrittura vola verso altri lidi che lasciano uno strano sapore nella bocca del lettore. Era tanto, tolto il noir, che uno scrittore non riusciva ad uscire così bene dagli stereotipi italiani. Risate e magia» (Massimo Vincenzi, «Tuttolibri - La Stampa»).
Il mondo, visto dagli occhi di Paolo Colagrande, è un posto in cui l’uomo è stato messo per sbaglio; «il lettore è accompagnato per mano ad assistere alla deriva del racconto stesso, in un gioco di specchi volto a denunciare la difficoltà di descrivere in modo univoco ciò che si stima chiaro ed esplicito, ed è invece per lo più falso e fuorviante» (Chiara Fenoglio, «la Lettura – Corriere della Sera»).

Il 12 dicembre è stato annunciato il libro dell’anno 2018 per la Lettura – Corriere della Sera. La giuria della Classifica di Qualità, presieduta da Marzio Breda (segretario Severino Colombo), ha assegnato il premio a Berta Isla di Javier Marías, uscito a maggio nei Supercoralli: «Un libro che si addentra nelle pieghe di un amore imperfetto e nel mistero che ogni cuore nasconde, anche a chi crede di conoscerlo a fondo».
L'11 febbraio l'autore è ospite al Teatro Grassi di Milano per la cerimonia di premiazione, intitolata Javier Marías, la forza della parola e organizzata da la Lettura.
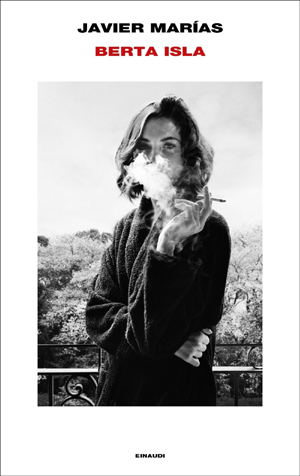
Lo scrittore spagnolo partecipa alla cerimonia di premiazione che si aprirà con i saluti del presidente della Fondazione Corriere, Piergaetano Marchetti, del direttore del «Corriere della Sera» Luciano Fontana e del direttore editoriale di Einaudi Ernesto Franco, coordinati da Antonio Troiano, responsabile delle pagine culturali del quotidiano. Di seguito la conversazione tra lo stesso Marías e il linguista Giuseppe Antonelli.













