-
Antropologia e religione Antropologia e religione
-
Arte e musica Arte e musica
-
Classici Classici
-
Critica letteraria e linguistica Critica letteraria e linguistica
-
Filosofia Filosofia
-
Graphic novel Graphic novel
-
Narrativa italiana Narrativa italiana
-
Narrativa straniera Narrativa straniera
-
Poesia e teatro Poesia e teatro
-
Problemi contemporanei Problemi contemporanei
-
Psicologia Psicologia
-
Scienze Scienze
-
Scienze sociali Scienze sociali
-
Storia Storia
-
Tempo libero Tempo libero
25 aprile 2024, Civitella in Val di Chiana Il discorso di Michela Ponzani
Celebrazione del Quirinale per il 79° anniversario della Liberazione
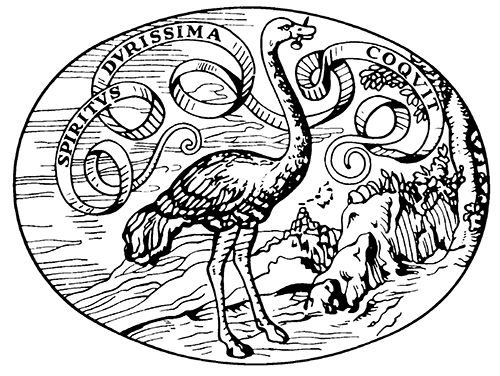
Pubblichiamo il discorso della professoressa Michela Ponzani tenuto a Civitella in val di Chiana in occasione del 25 aprile 2024 per le celebrazioni della festa della Liberazione organizzate dal Quirinale in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Presidenza della Repubblica
Celebrazione del 79° anniversario della Festa della Liberazione
80° anniversario dell’eccidio di Civitella in Val di Chiana
25 aprile 2024
La guerra giusta contro la politica del terrore
Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, famigliari delle vittime
«L’ho lasciato lì, in mezzo alle piante dell’orto». Alba Bonichi ha ricordato così l’ultimo istante in cui ha visto suo padre. I suoi occhi di bambina non hanno mai dimenticato «quel babbo che per le scale si reggeva il sangue».
È il 29 giugno 1944 quando militari tedeschi della divisione corazzata paracadutisti “Hermann Göring” massacrano oltre 200 civili nei paesi di Civitella in Val di Chiana, e nei piccoli comuni di Cornia e San Pancrazio.
Non sono uomini delle SS ma reparti scelti dell’esercito regolare; soldati della Wehrmacht giovanissimi (fra i 16 e i 25 anni), un corpo d’élite, provengono dalla gioventù hitleriana, e sono addestrati alle più spietate operazioni di polizia antipartigiana, alla guerra di sterminio. I loro commilitoni si sono già macchiati d’infamia massacrando la popolazione sul fronte orientale, nell’Europa dell’est, fin dal 1942; in Italia tornano a razziare e impiccare in una lunga scia di sangue che travolge l’intera penisola. Tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, si combatte in Italia una «guerra totale»: le popolazioni civili, investite di colpo da un conflitto che usa la violenza in maniera massiccia e indiscriminata, diventano improvvisamente il bersaglio strategico di una delle più spietate forme di guerra terroristica che la storia ricordi. Una guerra fatta di rastrellamenti con incendi a case e villaggi, corpi impiccati sulla pubblica piazza a monito della popolazione, torture sui corpi dei prigionieri politici, stragi, eccidi di massa, deportazioni, stupri contro le donne.
La guerra ai civili è la logica della “terra bruciata”, della guerra “casa per casa”; una tattica di terrorismo preventivo e intimidatorio, utilizzata dalle forze occupanti tedesche per “bonificare” il territorio dalle bande di ribelli e punire i civili che osano dare sostegno alle formazioni partigiane.
Una precisa strategia militare già prevista dalle spietate direttive del generale Wilhelm Keitel, comandante in capo delle forze armate tedesche e ribadita dagli ordini draconiani del feldmaresciallo Albert Kesselring: non riuscendo a stanare ogni singolo partigiano che si nasconde in montagna, che combatte in collina o nelle città occupate, le truppe tedesche (con l’ausilio dei reparti armati di RSI) dovranno mettere a ferro e fuoco quei villaggi e quelle comunità che danno aiuto ai partigiani; si dovranno massacrare civili innocenti che possono dare ai partigiani rifugio, cibo e cure.
In quella fresca mattina d’estate del 29 giugno 1944 a Civitella, la gente si è radunata in chiesa per celebrare le festività dei santi Pietro e Paolo. Qualche giorno prima i partigiani della banda “Renzino”, che opera in zona, hanno teso un agguato e ucciso, in pieno giorno, alcuni soldati tedeschi presso il dopolavoro ferroviario della città. Nessuno però si aspetta rappresaglie, come lo stesso comando tedesco si affretta a dire, rassicurando la popolazione. E invece, quel 29 giugno, alle prime ore del mattino, circa 400 uomini della divisione tedesca accerchiano la collina da due lati; un reparto uccide tutti gli uomini nelle vicine frazioni che tentano la fuga, e incendia tutto. L’altro, entra nel borgo, raccoglie la popolazione sulla piazza del paese: donne e bambini vengono allontanati, mentre gli uomini radunati in gruppi di cinque, sono portati sul retro della scuola e uccisi da un colpo di pistola alla nuca. Tra le vittime c’è anche don Alcide Lazzeri, il parroco di Civitella, che invano tenta di difendere la sua gente. E mano a mano che la strage procede, i cadaveri vengono gettati nelle case in fiamme.
A Solaia, altra frazione, una donna, Modesta Rossi, viene massacrata col figlio in braccio, di neppure un anno. A Cornia (dove il 21 giugno i partigiani hanno aperto il fuoco e ferito un sottufficiale tedesco), viene messa a punto una vendetta ancora più terribile: il massacro colpisce donne e bambini e alcune sono costrette a subire violenza davanti ai mariti e ai figli. Tutte le case vengono date alle fiamme e fino a sera, per tutta la campagna, si sentono urla e spari.
A comandare l’operazione è un ufficiale tedesco di 28 anni, che le testimonianze descrivono dal carattere ironico e sicuro di sé: morirà sul fronte orientale, nel marzo 1945, senza scontare neppure un giorno di prigione per i suoi crimini.
Nel tempo, intorno all’eccidio di Civitella si è radicata una memoria divisa: una memoria che ha trovato appiglio nel dolore di donne e orfani, abbandonati dalle istituzioni del dopoguerra, lasciati in una profonda solitudine di fronte al trauma della morte e al dolore dell’elaborazione del lutto. Una solitudine che nel tempo è diventata rabbia, si è trasformata in un risentimento profondo verso le bande partigiane locali, accusate di aver scatenato la ritorsione tedesca. Ma quella rabbia (umanamente comprensibile) è stata abilmente strumentalizzata da narrazioni di comodo, da polemiche infinite, da distorsioni della verità intenzionate a prendere di mira le ragioni dell’antifascismo e di tutta la Resistenza. Da un uso pubblico della storia che ha potuto radicarsi soprattutto a causa dell’assenza di una giustizia, incapace nel dopoguerra, di inchiodare i carnefici alle loro responsabilità.
Oggi, grazie al lavoro degli storici, sappiamo che la strage di Civitella non è stata una rappresaglia compiuta per vendicarsi di azioni partigiane, ma una spietata operazione di polizia antipartigiana, usata per controllare un territorio in prossimità delle linee di difesa e ritirata.
Un massacro ordinario, un crimine di guerra, una ritorsione vigliacca. I tedeschi sanno benissimo che su quel territorio l’iniziativa partigiana è praticamente inesistente (anche se ogni tanto si manifesta), che i partigiani in zona sono pochi e mal organizzati. Ma sanno anche che la Resistenza potrebbe crescere e rafforzarsi proprio grazie al sostegno della popolazione civile. La consistenza delle truppe impiegate nell’eccidio dimostra come l’operazione fosse stata decisa da tempo dai vertici militari, per ripulire dalle bande di ribelli una zona considerata strategica. E a massacrare la gente di quel paesino, che ha solo la sfortuna di trovarsi a ridosso di una linea di fortificazione tedesca, ci sono anche tanti italiani: spie, delatori, confidenti dei comandi tedeschi di zona. Sono squadre di brigate nere e militi della GNR, a straziare i corpi di donne, vecchi e bambini nella zona di Cornia, insieme ai soldati nazisti: fascisti animati dal culto del sangue e della violenza, da un crudele spirito di vendetta che cresce man mano che la guerra si sente perduta.
È contro questa politica del terrore che i ribelli, i combattenti irregolari, i partigiani che si danno alla macchia cercano di resistere; e lo fanno come possono. La scelta di combattere non sarà né allora, né in seguito, una decisione presa a cuor leggero. Convincersi all'uso armato della violenza è un dramma di coscienza attraversato da dubbi, da crisi, da tormenti interiori: perché in fondo «ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione», come avrebbe ricordato Cesare Pavese nella sua Casa in collina.
Sta tutta qui l’etica della responsabilità di quei combattenti volontari, «dagli abiti laceri e dalle scarpe rotte», «straccioni affamati» come li chiamano i tedeschi, che scelgono la lotta al fascismo perché mossi dalla ferma convinzione che sia giunto il momento d’opporsi in maniera definitiva, risoluta e forte, anche con la violenza, a chi la violenza la usa mille volte di più.
A resistere dopo l’8 settembre del ’43 sono soprattutto ufficiali e soldati del regio esercito sbandato, che si danno alla macchia, ma anche giovani nati e cresciuti sotto il fascismo: studenti ispirati da uno spontaneismo libertario, patriottico, influenzato da Mazzini e da Croce, operai, antifascisti della prima ora, sorvegliati speciali, che hanno patito il carcere e il confino, e molte donne: sono i “piccoli maestri” decisi a mettersi fuori legge per farla finita con un regime ormai crollato, che ha portato la rovina della patria. Scegliere di resistere, è un atto di disobbedienza radicale contro il poter fascista (come scriverà Itali Calvino), che matura nell’intimo della propria coscienza, in solitudine, e si trasforma in assunzione di responsabilità con l’irrompere della guerra in casa.
Azioni di sabotaggio, attacchi a convogli in transito e a linee nemiche, agguati continui a tedeschi e fascisti nelle città occupate: chi combatte nella Resistenza deve misurarsi ogni giorno con eccidi, rastrellamenti e violenze, senza cedere mai alla paura e al ricatto delle rappresaglie. È una scelta coraggiosa ma non scontata, una scelta dolorosa e carica di responsabilità.
Una scelta verso la quale il paese dovrebbe riconoscenza.
E invece ad ogni anniversario del 25 aprile il paese è però scosso da un Processo alla Resistenza che punta il dito sulle ragioni dell’antifascismo, confondendo torti e ragioni, meriti e bassezze, valori e disvalori, che cerca di equiparare le azioni partigiane ad atti di terrorismo. Si assiste, di contro, a una generale riabilitazione del fascismo, quasi a giustificare le colpe dei tanti crimini commessi da militi della RSI, “buoni padri di famiglia”, costretti solo ad obbedire a ordini superiori”.
«Assassini», «vigliacchi», «terroristi», «colpevoli sfuggiti all’arresto»: così i revisionisti hanno da sempre definito i partigiani, accusati d’irresponsabilità per non essersi costituiti ai nazisti in modo da evitare rappresaglie. Ma si tratta di una questione tirata fuori in maniera consapevolmente faziosa da chi, allora e in seguito, fu incapace di considerare il profondissimo dilemma umano e intellettuale che i partigiani di tutta Europa si erano posti, con estrema serietà e coscienza. Al fatto, cioè, che proprio l’antifascismo, in tutte le sue componenti politico-culturali, si era da sempre ispirato all’idea di un’Europa in cui le nazioni potessero convivere pacificamente; ma con l’irrompere della guerra l’idea della pace non poteva indurre alla soluzione d’arrendersi, di cedere al ricatto delle rappresaglie.
L’assenza di processi contro criminali di guerra nazifascisti ha nel tempo alimentato l’odio verso i partigiani, permettendo ai carnefici di rimanere impuniti. Migliaia di documenti e fascicoli processuali illecitamente archiviati con nomi di vittime e carnefici, con testimonianze e luoghi di migliaia di eccidi in tutta la penisola. Documenti occultati per oltre 50 anni in nome delle ragioni della guerra fredda rinvenuti solo nel 1994 presso la sede della Procura militare di Palazzo Cesi a Roma. Un tragico Atlante delle stragi nazifasciste, con oltre 5000 episodi di violenza contro i civili commessi dall’esercito tedesco e dai suoi alleati fascisti, per il quale ben pochi hanno pagato.
Gli storici hanno recuperato fonti, scavato fra gli atti processuali, ascoltato memorie e testimonianze, fino a entrare negli abissi della mente di chi decise quei massacri. E oggi grazie alle sentenze pronunciate dalla magistratura militare italiana per i nazisti non è più possibile nascondersi dietro al dito degli ordini ricevuti: non solo i comandanti ma anche i soldati semplici hanno delle responsabilità. Perché per sterminare centinaia di persone inoffensive non è sufficiente dire ho obbedito a un ordine; bisogna credere a quell’ordine, bisogna essere disposti a considerarlo legittimo.
La Resistenza ha affermato il diritto di un popolo a non farsi massacrare, a non farsi annientare senza muovere un dito: il diritto di lottare (con e senz’armi) per riprendersi la libertà e restituire dignità al paese in cui il fascismo aveva avuto origine nel 1922.
Il 25 aprile è il simbolo di una libertà riconquistata a caro prezzo. Una giornata chiamata a celebrare il ricordo, per le generazioni future, di quei mesi di guerriglia, trascorsi clandestinamente sulle montagne, tra «agguati, rastrellamenti, e imboscate», dove ognuno, a modo suo, aveva imparato a combattere «per l’indipendenza della patria e per la dignità di uomini liberi».
In tutte le sue forme e ovunque si combattesse, nelle città presidiate dai Gap o a Nord della linea Gotica, tra gli Appennini e il Po, e ancora con la mobilitazione sociale nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche e nelle campagne, la Resistenza rappresentò il senso più profondo della lotta contro questa politica criminale. Donne e uomini, partigiani e civili, internati e deportati: persone che, con modalità e tempi diversi (e per diverse ragioni) avevano contribuito a riscattare l’onore della Patria, gettata nel fango dal fascismo e dai suoi miti guerrieri. Alcuni trovarono la morte, altri divennero sopravvissuti, ma per tutti l’amore per la libertà aprì un nuovo sguardo al futuro. Ha scritto così Rosario Bentivegna, ricordando quei giorni:
«Capimmo allora, poco più́ che ventenni, che la pace tra uomini liberi era la cosa più́ bella del mondo e quella lezione non l’abbiamo mai dimenticata, noi che abbiamo dovuto batterci nella più́ feroce delle guerre e abbiamo visto cadere, al nostro fianco, tanti amici, compagni, tante persone che ci erano care. La guerra è la cosa più́ sporca, più́ ignobile che all’uomo possa capitare di vivere, anche se i fascisti la acclamavano e la invocavano come “unica igiene del mondo”».
Civitella, questo luogo della memoria ci parla oggi del senso di quella scelta antifascista; la scelta maturata da un’intera generazione costretta a battersi, come scrisse Piero Calamandrei «per necessità, non per odio», nell’idea di un possibile riscatto dell’Italia «dalla vergogna e dall’orrore del mondo».
Buona Liberazione Presidente.

