Mese: aprile 2025
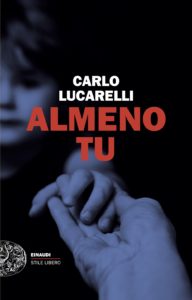
Quella di Vittorio è una vita come tante, che procede evitando squilli e cadute. Un giorno gli accade la più terribile delle tragedie: l’unica figlia, adolescente, muore mentre è con un gruppo di amici. Un incidente, così sembra, poi qualcuno insinua un dubbio. A quel punto l’esistenza di Vittorio, già devastata, si sgretola del tutto. Finché non è proprio la figlia morta, in sogno, a dirgli cosa deve fare: «Devi ammazzarli tutti».
Carlo Lucarelli torna con un thriller scorretto, crudele e doloroso perché, come sottolinea lo stesso autore, «qualche volta scrivere deve fare male, è necessario. Perché il noir è indagine sociale, come amo ripetere, se scava davvero. E perché oggi sono padre di due ragazzine di tredici anni: molto probabilmente qualche anno fa non avrei potuto scrivere questo libro. O forse lo avrei scritto, ma in modo completamente diverso» («7 – Corriere della Sera»).
«Dalla vendetta non si torna indietro, mai. Ho letto il romanzo di Carlo e mi è molto piaciuto quel padre tranquillo, almeno all’inizio, il che rende la vicenda ancora più tragica. Tutto si muove sul margine dell’errore, a volte si arriva a risultati giusti sbagliando clamorosamente. Ho una certa passione per quel tipo di trame, e medito di scriverne una anch’io».
Gianrico Carofiglio, «la Repubblica»
«Carlo Lucarelli, dopo quattro anni di silenzio dalla scrittura, è tornato e stavolta fa – davvero – paura… Stavolta te la porta a domicilio, dentro le mura domestiche, nella tragedia che colpisce un luogo come tanti (nello specifico Faenza), una famiglia come tante, un uomo come tanti: Vittorio. […] Dolore, dubbio, giustizia, verità, silenzi, reticenze: gli elementi per costruire un romanzo teso, dallo sviluppo imprevedibile e dall’esito aperto sono tutti sul piatto e Lucarelli si muove con maestria costruendo una trama avvincente e affidandosi a una scrittura asciutta, levigata, senza fronzoli, tagliente».
Severino Colombo, «La Lettura – Corriere della Sera»
«Carlo Lucarelli, uno dei più grandi scrittori di noir, questa volta ha messo da parte la Storia con la maiuscola – spesso cardine delle sue narrazioni – per addentrarsi in una vicenda che fa stringere lo stomaco sin dalle prime pagine. Almeno tu comincia infatti con uno di quegli annunci che ci tormentano negli incubi: la visita di un maresciallo a una coppia come tante, la notte, lo stupore, lo sgomento, la rivelazione (“c’è stato un incidente... vostra figlia è morta”) e poi l’abisso».
Roberta Scorranese, «7 – Corriere della Sera»
«Tra centri commerciali e caffè di paese, villette, caserme e bordi piscina, Lucarelli descrive con il consueto stile asciutto un’eterna provincia del mondo in bilico tra tranquillità e disperazione, prendendo tutti i punti di vista senza sceglierne alcuno. Nessuno è buono, nel suo universo, ma chiaramente le vittime sono i ragazzi, schiacciati dall’ingordigia, dall’egoismo, dalla vigliaccheria degli adulti. D’altronde se gli adolescenti ci fanno paura è perché sono il nostro sintomo: rivelano con le loro azioni la parte più oscura di noi, mostrano al mondo i nostri fallimenti, le nostre debolezze, la faccia che vogliamo nascondere».
Raffaella Silipo, «tuttolibri – La Stampa»

Mario Vargas Llosa, il grande autore peruviano, è morto a 89 anni a Lima, «in pace, circondato dalla sua famiglia». Nato il 28 marzo 1936, era naturalizzato spagnolo.
Vinse il Nobel per la letteratura nel 2010 «per la sua cartografia delle strutture del potere e per le acute immagini della resistenza, rivolta e sconfitta dell'individuo». Ha scritto capolavori come La città e i cani, La zia Julia e lo scribacchino, La Casa Verde, Elogio della matrigna.
Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e, rispettando le sue volontà, le sue spoglie saranno cremate.
«Ho imparato a leggere a cinque anni, nella classe di frate Giustiniano all’Accademia de la Salle di Cochabamba». Così, nel 2010, iniziava il suo discorso di accettazione del premio Nobel per la Letteratura all’Accademia di Svezia. Settanta anni dopo, riconosceva serenamente che il momento magico in cui - decifrando i segni e trasformandoli in parole - aveva abbattuto le frontiere dello spazio e del tempo, «era la cosa più importante che mi è mai accaduta».
Avvenne nel 1941: il piccolo Mario - nato in Perù - cresceva in Bolivia senza padre (gli avevano detto che era morto), con la famiglia della madre: grandi lettori, appassionati di poesia. Anni talmente felici che non proverà mai a raccontarli. La scrittura è una forma di protesta: nasce sempre dal trauma, dal conflitto, dalla rivolta.
Nel suo caso, contro il padre, che nel 1946 riapparve per riprenderlo, riportarlo in Perù e sottometterlo alla propria ferrea disciplina. Nel 1950 lo iscrisse all’Accademia Militare Leoncio Prado. La tirannia familiare duplicava quella nazionale, perché il Perù era allora sottomesso alla dittatura del generale Odría. La letteratura divenne per il ragazzo ribelle il passaporto per la libertà. Il precoce matrimonio con la zia acquisita Julia, dieci anni più grande di lui, il trasferimento in Spagna e poi a Parigi, dove scoprì l’America Latina (e lesse Borges, Paz, García Márquez, Fuentes, Rulfo, Cabrera Infante, Onetti, Cortázar, Donoso) e il viaggio in Amazzonia dove - rifiutando ogni tentazione di esotismo o idealizzazione di una presunta armonia con la natura - scoprì il Perù arcaico dei nativi, esclusi dalla modernità e in balia del dispotismo e dell’ingiustizia, fecero di lui uno scrittore.
Il suo primo amore in verità era stato il teatro (sedotto da Morte di un commesso viaggiatore di Miller al teatro Segura di Lima), e aveva esordito come giornalista e autore di racconti (I cuccioli. I capi, 1959). È stato anche critico letterario (pregevoli i suoi scritti su Flaubert e Borges e sul romanzo - fra cui La verità della menzogna e La letteratura è la mia vendetta, dialogo con Claudio Magris), saggista (articoli e interviste raccolti in Contro vento e marea, 1982-86, mentre Il richiamo della tribù, 2018, è una ricognizione fra i pensatori liberali, come Aron, Berlin e Popper, che hanno anteposto l’individuo alla tribù, cioè alla classe, al partito, alla nazione), e politico.
Da studente marxista e socialista, intellettuale engagé nella maturità, come molti della sua generazione influenzato da Sartre, salutò con favore la rivoluzione cubana, per poi rinnegarla quando essa, divenuta regime, iniziò a reprimere il dissenso. L’invasione russa della Cecoslovacchia nel 1968 sancì la disillusione, e l’inizio di un sofferto percorso di avvicinamento all’umanesimo laico di Camus e al liberalismo. Nel 1987, col Movimiento Libertad, ha guidato le proteste contro il progetto del presidente García di nazionalizzare il sistema bancario: divenuto leader del Frente Democratico, si è candidato nel 1990 alle elezioni presidenziali del Perù. Denigrato come reazionario e conservatore (mentre lui ha sempre sostenuto che nell’America Latina funestata dalle dittature, dal terrorismo, dal nazionalismo, dal misticismo, dal razzismo, essere liberali significa essere rivoluzionari), fu sconfitto al secondo turno da Fujimori, su cui si riversarono i voti della sinistra.
Nel 1992, con un colpo di stato, Fujimori abolì parlamento e democrazia, instaurando l’ennesima dittatura: ma Vargas Llosa si era già trasferito in Spagna, paese del quale è divenuto cittadino. Se ho rievocato questa esperienza (da Vargas Llosa raccontata nell’autobiografia Il pesce nell’acqua, 1993) è perché essa ha fatto di lui il protagonista di uno dei suoi romanzi, svelando l’essenza stessa della letteratura – che dai fatti e dal vissuto nasce, ma insegna a inventare la vita e a trasformarla. La riflessione sulla natura del potere, sulla debolezza e la nobiltà dell’essere umano è del resto il nucleo della sua opera, tanto da figurare nella motivazione del premio Nobel, attribuitogli appunto per «la cartografia delle strutture del potere, per la sua immagine della resistenza, della rivolta e della sconfitta dell’individuo».
Ma Vargas Llosa è stato soprattutto un romanziere, trascinato dalla «passione, il vizio, la meraviglia della scrittura». Dal primo romanzo, La città e i cani (1962), ispirato alla sua esperienza all’accademia militare di Lima, fino all’ultimo, Tempi duri (2019), non ha mai cessato di credere nel potere del romanzo. Ha riconosciuto come maestri Flaubert, Faulkner, Dickens, Balzac, Conrad, Mann, Orwell, ma sin dal fulminante esordio che lo impose in tutto il mondo (è stato tradotto in 60 lingue), ha cercato di rinnovarlo e reinventarlo, traghettandolo nel XXI secolo. Combinando lirismo e realismo, moltiplicando i punti di vista, stravolgendo i piani temporali, usando il monologo interiore e i dialoghi, la storia, la cronaca, la satira e l’erotismo, ha indagato le miserie del suo paese e dell’animo di tutti.
In Perù – il paese di «ogni sangue» secondo José Maria Arguedas – sono ambientati La casa verde (1966), Conversazione nella cattedrale (1969), Pantaleon e le visitatrici (1973), Zia Julia e lo scribacchino (1977), Avventure della ragazza cattiva (2006), L’eroe discreto (2013), Crocevia (2019) e Le dedico il mio silenzio (2023). Ma le sue storie esplorano l’America Latina tutta, dal Brasile ottocentesco de La guerra alla fine del mondo (1981), alla Santo Domingo di Trujillo in La festa del caprone (2000), al Guatemala di Tempi duri (2019), fino alla Polinesia de Il paradiso è altrove (2003), e al Congo-belga devastato dal colonialismo de Il sogno del celta (2010).
Vargas Llosa non ha mai perso la fiducia nella capacità sediziosa della narrativa di creare un mondo alternativo, senza frontiere di lingua, cultura e religione, nel quale trovare rifugio contro le avversità o la barbarie, dissipare il caos, eternare la bellezza di un istante. Un mondo senza letteratura (o con una letteratura ridotta a svago e passatempo) sarebbe un mondo senza desideri e ideali – ha detto - perché le menzogne della letteratura diventano verità attraverso di noi, e i lettori contagiati dal dubbio metteranno in discussione la realtà mediocre in cui gli tocca vivere. La finzione è un’assoluta necessità affinché la nostra civiltà continui a esistere, si rinnovi e preservi in noi il meglio di ciò che è umano. E per questa utopia visionaria, che si è tradotta in personaggi ambigui e indimenticabili, e in migliaia di pagine trascinanti, sinistre, divertenti, feroci, sempre gli saremo grati.
Pubblicato per gentile concessione di «la Repubblica». Riproduzione riservata.

Clementina, romanzo d’esordio di Giuliana Salvi, è la storia di una donna che, rimasta vedova e con tre figli, deve reinventarsi e caricarsi sulle spalle l’intera famiglia. Mentre la Storia impazza fuori dalla finestra e l’Europa combatte la Prima Guerra mondiale, lei decide di lasciare Roma – dove viveva col marito – e tornare a Lecce, nella casa di famiglia.
Proprio in quella casa, dove da bambina studiava, leggeva e scriveva racconti, sceglie di dedicarsi all’insegnamento. Accettare ragazzini e ragazzine nel proprio salotto e curare la loro istruzione: è nell’insegnamento che Clementina realizza sé stessa, e trova il modo per aiutare i propri figli. Vincendo le proprie resistenze e quelle del suo tempo non immagina che la sua casa possa trasformarsi in scuola: appiglio, salvezza, piccola rivoluzione.
Ispirato alla storia vera della bisnonna dell’autrice, Clementina è un romanzo che non si dimentica, grazie alla forza di un personaggio estremamente contemporaneo. È una storia, secondo Leonetta Bentivoglio che l’ha recensita su Robinson, «fondata sulla resilienza di una donna desiderosa di reinventare il mondo. Narra la sorte dell’autentica bisnonna dell’autrice. Ci sono tante maniere di fare una rivoluzione senza salire sulle barricate, e Clementina realizza la propria sventolando a modo suo, più di pancia che di testa, la bandiera femminista».
La figura che l’autrice ha restituito ai lettori non è quella di un’eroina. La stessa Salvi ammette che «Clementina era ruvida, complicata, come madre a tratti castrante. Ma anche stimolante, attenta. Era una femminista nei fatti, non nelle rivendicazioni, per le quali non aveva tempo. Nell’insegnamento ha messo tanta passione che chi le stava attorno ne è stato invaso» (il venerdì – la Repubblica).
Per Carmen Pellegrino «muovendo dalla personale esigenza di “rendere giustizia” alla figura della sua antenata, Salvi sembra andare in cerca di un grande linguaggio dimenticato, di una pietra, di una foglia, di una porta non trovata. E, continuerebbe Thomas Wolfe, di tutti i volti dimenticati. Un esordio decisamente convincente» (La Lettura – Corriere della Sera).
Clementina ha toccato e commosso molti lettori, che hanno scritto direttamente all’autrice per esprimere i propri pareri e le emozioni provate durante la lettura del romanzo. Ve ne lasciamo alcuni:
«Mentre leggo il suo libro sul treno sto piangendo davanti a tutti. Non pensavo che un libro potesse prendermi così tanto, la ringrazio per avermi fatto sentire parte di una famiglia meravigliosa e forte».
Alice
«Buonasera, scusi l’ora tarda. Sono una libraia, ieri ho divorato e amato il suo romanzo. Volevo ringraziarla per la storia stupenda di questa donna che ha voluto scrivere e tramandarci».
Lydia
«Ho finito di leggere il romanzo ieri pomeriggio. Ho pianto, ho gioito, mi sono appassionata alla storia ed affezionata a ogni singolo personaggio».
Patrizia
«Ho amato Clementina e la sua vita come fosse mia nonna. Grazie. Libro stupendo. Clementina spacca!».
Anna

Roberto De Simone è stata una figura di artista a tutto tondo: pianista di valore, compositore, scrittore, uomo di teatro. Grazie a un affascinante intreccio di filologia e creatività, ha saputo costruire un ponte fra la cultura barocca e la modernità e riformulare una viva tradizione napoletana distante da ogni banalizzazione folkloristica. Esito sommo di questo lavoro è stato ovviamente La gatta Cenerentola, uno spettacolo di enorme successo che De Simone mise in scena come autore e regista nel 1976 con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, da lui fondata. Ma in tutti i suoi spettacoli e i suoi libri c’è la stessa idea di fondo: quella di ritrovare l’unità sostanziale tra l’anima colta e l’anima popolare della tradizione napoletana. Se per gli studiosi romantici ottocenteschi la letteratura popolare era il momento creativo sorgivo, elaborato successivamente dai letterati, e se Benedetto Croce aveva viceversa teorizzato che la letteratura dialettale era sempre una letteratura riflessa, cioè derivata da quella colta, per De Simone l’origine era comune: nella storia letteraria e musicale di Napoli “miseria e nobiltà” erano sempre andate a braccetto. La vera cultura popolare (quella che, secondo lui, va dal tardo Cinquecento al primo Novecento) dava vita a forme raffinatissime così come la letteratura e la musica colte sapevano farsi capire da tutti. In questo sentiva una parentela con la sensibilità di Pasolini, e come Pasolini deprecava l’omologazione del pieno Novecento che aveva inquinato e corrotto questa tradizione e aveva banalizzato la musica, la letteratura, il teatro (Eduardo era sul suo banco degli imputati), la cultura popolare e, in particolare la canzone napoletana.
Con Einaudi ha pubblicato una quindicina di libri in poco più di quarant’anni. Fu Roberto Cerati a chiedergli La gatta Cenerentola subito dopo averla vista a teatro: il libro uscì nel 1977 e ha avuto venti edizioni, più un paio con il video dello spettacolo. Ma è negli anni della maturità che De Simone ha infittito la collaborazione portando a compimento alcuni «Millenni» che sono entrati nella storia della collana: le Fiabe campane (1994), Il cunto de li cunti del Basile con la sua riscrittura in napoletano moderno (2002), La canzone napolitana (2017), sempre con le illustrazioni di Gennaro Vallifuoco. E poi, oltre al fondamentale saggio sul Presepe popolare napoletano (1998), mi piace segnalare due testi teatrali originali degli anni recenti, a testimoniare che la sua vena creativa si era mantenuta viva anche in tarda età: Cinque voci per Gesualdo (2013), dedicato al grande compositore di madrigali che uccise la moglie nel 1590, un testo dove in De Simone convivono il drammaturgo e il musicologo, e L’oca d’oro (2019), una sorta di testamento in cui tutte le sue idee teatrali vengono passate in rassegna al cospetto di un capocomico morente, con un irresistibile cocktail di gag tratte da un repertorio che andava dalla commedia dell’arte a Totò. Ricordo che abbiamo presentato questo libro al Teatro Argentina di Roma con le letture di Isa Danieli, un’attrice della vecchia guardia, molto cara al Maestro, come tutti lo chiamavano. De Simone aveva già molti problemi fisici e, pur sostenuto, raggiunse il palco con fatica, ma poi l’atmosfera di affetto che lo circondava e la forza del suo testo che veniva letto lo rasserenarono completamente facendogli dimenticare tutti i guai.
De Simone era così: a volte un carattere non facilissimo ma, messo in un teatro con gli attori e le musiche giuste, era la persona più gioviale, ironica e generosa. E così lo ricorderanno tutti coloro che hanno lavorato con lui nel corso di tanti anni.
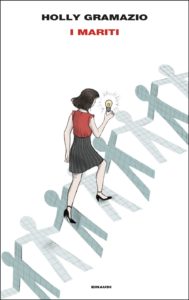
Se vi trovaste a dover costruire il vostro partner ideale a tavolino, quale scelte prendereste? Sarebbe un esercizio semplice? O completamente ozioso? E in fondo: esiste davvero un partner ideale?
Queste domande sembrano assillare anche Lauren, la protagonista del romanzo d’esordio di Holly Gramazio, quando si trova a stilare una lista di ciò che un marito dovrebbe avere. La ricerca della perfezione la condannerà a un loop infinito di mariti?
Una sera, tornata a casa dall’addio al nubilato di un’amica, Lauren trova uno sconosciuto che sta scendendo dalla sua soffitta, solo che quello sconosciuto sostiene di essere suo marito e, incredibilmente, lo è davvero. E quando quel marito risale in soffitta, ecco scendere un altro sconosciuto, e quello sconosciuto è il suo nuovo marito. E così scopre di avere una «soffitta magica», una soffitta che fa e disfa mariti, e coi mariti fa e disfa la sua vita, a ripetizione. È questo l’avvio di una commedia brillante che illumina la natura delle relazioni sentimentali nel nostro tempo.
Gramazio, come ha sottolineato Annachiara Sacchi nelle pagine del Corriere della Sera, ha scritto un romanzo «divertente, doloroso, arguto, straniante, profondo… che da commedia esilarante (solo a tratti romantica) assume toni dark; che è totalmente immaginaria, ma con le radici ferocemente ancorate alla realtà. Quella di una società “social” che però è antisociale, che corre veloce come in un’app di appuntamenti, dove scorrere come in un catalogo infiniti tipi di umanità, dove “un sacco di ragazzi matchano con tutte, fanno swipe, swipe”. Dove la compatibilità tra due persone la decide un algoritmo».
Un libro ironico e pungente, che parte da «una di quelle idee (sfolgoranti) che sanno raccontare questi tempi, le storie sperimentali che sembravano andate perse dopo la rivoluzione del realismo, l’autofiction, e il paradiso delle storie comuni a corto raggio. I mariti è un romanzo di quelli con la tassa d’ingresso e un patto di lealtà: il lettore sospende l’incredulità, lo scrittore in cambio lo accompagna a capire qualcosa di nuovo. L'ultimo esperimento così riuscito lo aveva fatto Ottessa Moshfegh con l’Anno di Riposo e Oblio» (Ester Viola sul Foglio).
Gramazio, oltre ad essere scrittrice è anche una game designer e ha accompagnato l’uscita del libro con un Generatore di mariti: «Un gioco che inizialmente ho creato per aiutarmi a scrivere il romanzo, un modo per immaginare uomini che potrebbero esistere e scendere dalla soffitta di Lauren. Combina casualmente diversi hobby, nomi e abitudini per creare milioni di mariti possibili. Abbiamo pensato di metterlo online, così chiunque può divertirsi a generarne uno proprio».
«L’esperienza di Gramazio come curatrice d’arte e game designer dona a I mariti più profondità e sfumature di quanto ci si potrebbe aspettare dalla sua premessa stravagante… La tua reazione al finale di questo straordinario romanzo potrebbe dipendere dalla tua esperienza della vita di coppia. O, semplicemente, della vita, punto».
«The Washington Post»
«Gramazio di mestiere fa la game designer. E si vede: il suo bel romanzo d’esordio I mariti somiglia a uno di quei videogiochi pieni di mondi paralleli in cui avventurarsi»
«Donna Moderna»
«…Un po' come facciamo tutte noi alle prese con l’eterna commedia della scelta dell’uomo perfetto. E da commedia è infatti il tono di I mariti di Holly Gramazio, un romanzo che sa rendere realistica persino la magia di una soffitta da cui sbucano tutte le possibilità di innamorarci della persona giusta.
Rossana Campisi, «Io Donna»




