Mese: maggio 2024
Venerdì 31 maggio è stata annunciata la cinquina finalista del Premio Campiello 2024. Fra i titoli selezionati c’è Locus desperatus di Michele Mari, uscito il 23 aprile nei Supercoralli.
«Un po' thriller metafisico, un po' horror filologico, un po' commedia grottesca, in Locus desperatus l'intreccio è sostituito da un colto rimuginio, le intuizioni sono quasi tutte etimologiche e le parole diventano un'arma, quella che trasforma l'impossibile in possibile e ha così la meglio sul mistero e sull'oblio. Perché la propensione al sapere dà un potere immenso, non solo su chi non sa, ma soprattutto su ciò che (ancora) non si sa».
Nicola H. Cosentino, «La Lettura – Corriere della Sera»
«Un romanzo unico, che immobilizza con la lingua vitale, ricchissima, inconfondibile dello scrittore. E regala una suggestione dopo l'altra: come l'inconscio che è una cosa sola col posto in cui abitiamo».
Sabina Minardi, «L’Espresso»
«Dopo i racconti delle Maestose rovine di Sferopoli, il nuovo sontuoso romanzo di Michele Mari, Locus desperatus trascina il lettore in un viaggio destabilizzante, che mette in gioco l'idea stessa di io, la persistenza mutevole delle memorie, il rapporto con gli oggetti materiali in cui la vita si incapsula e dura. Chi legge è risucchiato in un mondo in cui ogni dato vacilla e si sgretola».
Matteo Palumbo, «Alias - il manifesto»
Il vincitore sarà proclamato il 21 settembre dal Teatro La Fenice di Venezia. Ecco gli altri finalisti:
Il fuoco che ti porti dentro, Antonio Franchini
Alma, Federica Manzon
Dilaga ovunque, Vanni Santoni
La casa del Mago, Emanuele Trevi

Goliarda Sapienza ha dovuto attraversare in Italia quello che, in una lettera ad Attilio Bertolucci, definisce un vero e proprio «inferno editoriale» per riuscire a pubblicare il suo indiscusso capolavoro, L’arte della gioia, scritto tra il 1969 e il 1976. Solo nel 1994, due anni prima della sua morte, venne pubblicata da Stampa Alternativa la prima parte del romanzo, e solo nel 1998, due anni dopo la sua morte, grazie alla cura del marito Angelo Pellegrino, il romanzo completo, poi ripubblicato nel 2003, sempre in pochissimi esemplari. Ed è in uno di quei pochi esemplari dell’edizione italiana che sono incappate Waltraud Schwarze e Viviane Hamy, che tra il 2005 e il 2006 lo pubblicarono in Germania e in Francia, dove il libro ottenne un successo straordinario.
Tutto partì da lì: da quel testo stampato in 1000 copie, quasi introvabile, di cui si innamorarono due donne in due Paesi diversi. Io lo lessi e me ne innamorai a mia volta, e con me tutta la casa editrice Einaudi. Non parlavamo d’altro, in quei giorni. Decisi di andare a Roma da Angelo Pellegrino, marito di Goliarda Sapienza, che mi aprì la cassapanca di Goliarda. Conteneva il manoscritto dell’Arte della gioia e migliaia di pagine scritte di suo pugno, con la Bic nera, in una grafia febbrile, cardiaca: quelle pagine assomigliavano davvero a elettrocardiogrammi, partivano da una riga piena e a poco a poco arrivavano a mezza riga, un quarto di riga, per poi ritornare alla mezza riga e alla riga intera, disegnando figure geometriche, pezzi di clessidre. Le ho lette con una gioia che non so descrivere, ed è da lì, da quelle pagine inedite, che sono poi nati negli anni i libri successivi: il romanzo Io, Jean Gabin (2010), le due raccolte dei suoi taccuini, Il vizio di parlare a me stessa. Taccuini 1976-1989 (2011) e La mia parte di gioia. Taccuini 1989-1992 (2013), e il romanzo Appuntamento a Positano (2015).
Decidemmo di pubblicare L’arte delle gioia nei Supercoralli nel 2008, per sottolinearne finalmente la rilevanza letteraria e culturale, e fu un grande successo di critica e di pubblico.
La vicenda del lungo rifiuto italiano si può ricostruire a partire dai libri Cronistoria di alcuni rifiuti editoriali dell’Arte della Gioia (Edizioni Croce) e Lettere e biglietti (La nave di Teseo). È una vicenda interessante, che meriterebbe di essere scandagliata. Sta di fatto che uno dei più grandi e pulsanti romanzi del Novecento italiano venne definito in patria «un cumulo d’iniquità», «un romanzone», letto di volta in volta come un romanzo libertino, un romanzo socialista, un romanzo criminale, un romanzo femminista, un romanzo sessantottino, e capito solo da alcuni, tra cui Enzo Siciliano e Cesare Garboli. Proprio Cesare Garboli, in una bella intervista, aveva dichiarato profeticamente: «Il tempo lavorerà a favore dei libri di Goliarda Sapienza, e questo non è un augurio, è una certezza.» Ha avuto ragione.
L’Italia di quegli anni forse non era pronta per lei e per la sua Modesta, donna libera e anticonformista nella Sicilia della prima metà del secolo. La libertà sessuale, l’amore fisico, la politica, il femminismo, la capacità di rompere convenzioni e ruoli sociali, la sfida alla cultura patriarcale, fascista, mafiosa e oppressiva, l’amoralità: tutte le questioni centrali dell’Arte della gioia potevano essere dei muri difficili da scalare, per molti. È la teoria di Nathalie Castagné, traduttrice del libro in Francia, che ha dichiarato: «La Francia al contrario dell’Italia, ama molto la trasgressione. Per cui il successo enorme dell’Arte della gioia da noi si deve esattamente a tutto quello che lo ha fatto rifiutare da voi». Io sono convinta che la società letteraria degli anni Settanta in Italia non fosse pronta ad accogliere l’esuberanza di Goliarda Sapienza soprattutto per ragioni stilistiche, prima ancora che morali o ideologiche o politiche. La sua scrittura doppia, barocca e razionale, vorticosa ed esatta, poetica e orale, sempre appassionata, sempre dietro la vita, anche quando non intende ghermirla programmaticamente nella «autobiografia delle contraddizioni», era qualcosa che poteva spiazzare, e anche molto, alcuni intelletti. Ha ragione Angelo Pellegrino, suo marito e curatore della sua opera, quando scrive che, anche quando la sua scrittura non è autobiografica, «è trasfigurazione, trasposizione di tanta vita che le appartiene».
E in un certo senso si può anche dire che L’arte della gioia racconta il Novecento da un punto di vista eccentrico. Perché isolano. Perché femminile. Perché fuori da ogni possibilità di categorizzazione. Il suo stesso femminismo anticipava i tempi. Una frase come «State attenti perché di questo passo quando le donne si accorgeranno di come voi uomini di sinistra sorridete con sufficienza paternalistica ai loro discorsi, la loro vendetta sarà tremenda» sembra scritta più oggi che ieri.
Goliarda Sapienza è una scrittrice difficilmente collocabile nel panorama nazionale. Tutto è inusuale in lei, inusuale è stata la sua stessa formazione, il suo apprendistato eccentrico. Suo padre, Giuseppe Sapienza, l’avvocato dei poveri, decise di chiamarla Goliarda «perché era un nome senza santi» e le fece abbandonare la scuola dopo le elementari per paura che l’istituto scolastico la guastasse: fu istruita in casa dai suoi genitori straordinari e dai tanti fratelli, ognuno con una competenza diversa. Il suo sapere «diverso» veniva da lì, oltre che dalla vita e dal lavoro nel teatro e nel cinema, e lei lo riversò nel suo linguaggio. Mescolando storie e mondi e immagini e sguardi in un flusso ininterrottamente vitale.


A tre anni di distanza da Angeli, la loro ultima indagine, i Bastardi sono tornati.
Serve a poco l'ombrello se ti piove dentro… e a tutti i membri del commissariato di Pizzofalcone piove sopra e sotto la pelle, che decidano di andarsene in giro riparati o no. In questa atmosfera dovranno risolvere il caso dell’omicidio di Leonida Brancato, penalista imbattibile, il re del cavillo.
Quando Brancato era andato in pensione, in procura avevano fatto festa. Da anni non si sapeva più nulla di lui, ma ora qualcuno lo ha ucciso e ha infierito sul suo cadavere. Un omicidio all’apparenza privo di movente.
Sotto un diluvio che non concede tregua, circondati da nemici e nonostante dolorosi problemi personali, i formidabili poliziotti, usciti dalla penna di Maurizio de Giovanni, si districheranno fra segreti, ipocrisie, rancori. Arrivando a scoprire una verità quanto mai inaspettata.
Così l’autore presenta il ritorno dei Bastardi al Corriere della Sera: «Quel mondo è per me tra i più interessanti, perché è quello che mi consente di guardarmi attorno nel mio ambiente, qui e ora, e declinare uno spettro di ferite e lesioni attraverso una pluralità di personaggi che mi ha sempre incantato […] Man mano che andavo avanti nella scrittura ero sempre più felice di trovarmi lì […] Mi sono divertito, preoccupato, angosciato e addolorato. Ho avuto paura, mi sono arrabbiato, ho molto riso e ho perfino imprecato a mezza voce mentre scrivevo. Mi sono perfino, ci credereste?, molto sorpreso per il finale, in cui accade qualcosa che non avevo previsto».
Per Raffaella Silipo, nella sua recensione su tuttolibri – La Stampa, «i Bastardi di Pizzofalcone, secondogeniti turbolenti e amatissimi di Maurizio de Giovanni, sono un’orchestra jazz, di quelle mitiche del dopoguerra, alla Glenn Miller: virtuosi diversi tra loro, ciascuno guidato dai suoi demoni e abituato a improvvisare per conto suo, eppure alla fine, come per miracolo, il suono combinato regala momenti di felicità e persino un poco di giustizia […] de Giovanni coordina i suoi Bastardi come un direttore d'orchestra consumato, sa tirar fuori da ognuno il suono giusto, che è poi il suono complesso di una città “piena di confini interni, dalle Vele di Scampia al Circolo Nautico Posillipo: i miei poliziotti altro non sono che navigatori fra questi mondi”. La musica di Napoli, per dirla con Pino Daniele: tra la pazzia e il blues».
«Questo è il male, sapete? Ognuno fa il suo pezzo di lavoro, senza mai alzare lo sguardo... Ma la giustizia, ispettore, che fine fa? Si perde nei rivoli, negli interstizi, nei dettagli, nelle procedure…» Come fa notare Generoso Picone sul Mattino, «non ci sarà articolo del codice penale o sentenza di Tribunale a fornire un'adeguata risposta a interrogativi di tanta inquietudine. Tali da ribaltare lo schema di una pur complicata indagine per omicidio nella trama quasi dostoevskiana di un’immersione che scandaglia le profondità più oscure dell’animo umano, misurandosi con il nodo inestricabile che intreccia la verità, la giustizia, la vendetta, la pena».

Ho saputo della morte di Alice Munro e, appena tornata a casa, sono andata ai suoi libri allineati sullo scaffale. D’impulso ne ho presi due: Danza delle ombre felici e Uscirne vivi. Il primo e l’ultimo, l’alfa e l’omega di una scrittrice che ha messo la longevità al servizio di un percorso artistico di assoluta imperterrita grandezza.
Tradurre Alice Munro è quello che ho fatto quasi ininterrottamente per circa dodici anni; è stata la mia vita per circa dodici anni. Come per altri può essere fare ogni giorno il pane, visitare pazienti, costruire case, suonare il violoncello. Il mio mestiere per tanto tempo è stato questo: tradurre Alice Munro. A me sembra una cosa strabiliante.
Ecco l’incipit del primo racconto della prima raccolta, quella dedicata al padre, Robert Laidlaw:
«Dopo cena mio padre fa: - Scendiamo a vedere se c’è ancora il lago? - Lasciamo mia madre a cucire sotto la lampada in sala da pranzo; mi fa dei vestiti per l’inizio della scuola».
Ed ecco l’epilogo del suo ultimo racconto, dedicato, senza bisogno di dediche, a sua madre:
«Non tornai a casa per la sua malattia e nemmeno per il funerale... Di certe cose diciamo che non si possono perdonare, o che non ce le perdoneremo mai. E invece poi lo facciamo, lo facciamo di continuo».
Tra l’uno e l’altro si dispiega l’immensa costellazione di storie che, con felice caparbietà, Munro non ha mai trasformato in romanzi. «Maestra del racconto breve» recita la motivazione per l’assegnazione del Nobel del 2013. E maestra anche per non aver cambiato rotta e per aver consegnato un Premio Nobel al Canada e alla forma del racconto. Il suo unico presunto tentativo di romanzo, La vita delle ragazze e delle donne, anziché cedere all’ambizione del racconto di lunga gittata, ne frantuma la compattezza in capitoli per registrare il processo di formazione della voce narrante, Del, che, da bambina di nove anni, attraverso una serie di riti iniziatici e passaggi, approda alla necessità della scrittura e promette al lettore il dono di racconti credibili e radiosi.
Alice Munro ha continuato per sessant’anni a convocare le sue storie e a ripeterle, cioè a domandare a ciascuna di esse qualcosa che ancora le sfuggiva. «Scrivo dal punto in cui mi trovo nella vita», diceva. Il miracolo è che ogni volta il racconto trascina il lettore nel luogo in cui la lettura si fa necessaria e incantevole.
Le storie di Munro per me sono ricordi, come quelli che conserviamo delle persone che abbiamo conosciuto.
Donne, soprattutto, ragazze, bambine e donne di ogni età coi loro nomi: Heather, Maddie, Almeda, Sally, Lucille, Helen, Verna, Meriel, Fiona, Pauline, Mary Louise, Annie, Marian, Frances e tante altre ancora. Di loro, conosco i vestiti capaci di sedurre o imbarazzare, certi segreti e certe vergogne, spesso l’indirizzo, che saprei trovare, se solo esistessero i posti dove abitano.
E cose, osservate nella loro vita attiva in relazione con la nostra: case bianchissime, chiese, cuffie da bagno, tailleur, lettere micidiali.
Ma anche alberi, erbe, arbusti, piante in vaso e rovi perfino, protagonisti ignari dei racconti, insieme ai mille laghi in cui si nuota o si annega. Sono naturalmente aceri, ma anche abeti azzurri, cedri, pini neri, salici, olmi, pioppi rossi, betulle, castagni e meli, e radure sconfinate di tarassaco, lappe, piantaggini, ortiche, verghe d’oro, crescione, monarda didima e melissa. Come l’erbario poetico di Seamus Heaney che si conclude con un elenco di erbe spontanee da fiore e con la dichiarazione di un’appartenenza.
«Tra erica e calendula,
tra sfagno e ranuncolo,
tra tarassaco e ginestra,
nontiscordardimé e caprifoglio,
come tra azzurro chiaro e nuvola,
tra pagliaio e cielo al tramonto,
tra quercia e tetto d’ardesia,
passai la mia esistenza. Lì fui,
io nel luogo e il luogo in me».
Infine, le stagioni e le località, il tempo e lo spazio, tutte le immaginarie cittadine dell’Ontario come Walley, Jubilee, Hanratty, Dalgleish, che Munro ha inventato traducendole dalle reali Wingham, Guelph, Clinton, Kitchener. Perché Munro è nel luogo e il luogo in lei, oltre che nella geologia della sua lingua.
Ricordo la potenza della gioia con cui nel 2013 accolsi la notizia del Nobel: una telefonata dalla casa editrice. È stato così anche questa volta e ho sentito dentro un silenzio quieto, come di neve. Ci vorrebbe lei, per descriverlo.
Susanna Basso
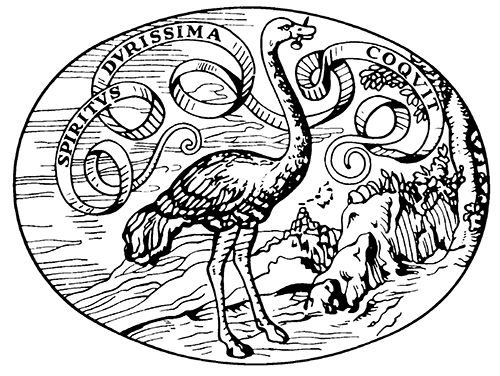
Pubblichiamo il discorso della professoressa Michela Ponzani tenuto a Civitella in val di Chiana in occasione del 25 aprile 2024 per le celebrazioni della festa della Liberazione organizzate dal Quirinale in presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Presidenza della Repubblica
Celebrazione del 79° anniversario della Festa della Liberazione
80° anniversario dell’eccidio di Civitella in Val di Chiana
25 aprile 2024
La guerra giusta contro la politica del terrore
Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, famigliari delle vittime
«L’ho lasciato lì, in mezzo alle piante dell’orto». Alba Bonichi ha ricordato così l’ultimo istante in cui ha visto suo padre. I suoi occhi di bambina non hanno mai dimenticato «quel babbo che per le scale si reggeva il sangue».
È il 29 giugno 1944 quando militari tedeschi della divisione corazzata paracadutisti “Hermann Göring” massacrano oltre 200 civili nei paesi di Civitella in Val di Chiana, e nei piccoli comuni di Cornia e San Pancrazio.
Non sono uomini delle SS ma reparti scelti dell’esercito regolare; soldati della Wehrmacht giovanissimi (fra i 16 e i 25 anni), un corpo d’élite, provengono dalla gioventù hitleriana, e sono addestrati alle più spietate operazioni di polizia antipartigiana, alla guerra di sterminio. I loro commilitoni si sono già macchiati d’infamia massacrando la popolazione sul fronte orientale, nell’Europa dell’est, fin dal 1942; in Italia tornano a razziare e impiccare in una lunga scia di sangue che travolge l’intera penisola. Tra l’8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, si combatte in Italia una «guerra totale»: le popolazioni civili, investite di colpo da un conflitto che usa la violenza in maniera massiccia e indiscriminata, diventano improvvisamente il bersaglio strategico di una delle più spietate forme di guerra terroristica che la storia ricordi. Una guerra fatta di rastrellamenti con incendi a case e villaggi, corpi impiccati sulla pubblica piazza a monito della popolazione, torture sui corpi dei prigionieri politici, stragi, eccidi di massa, deportazioni, stupri contro le donne.
La guerra ai civili è la logica della “terra bruciata”, della guerra “casa per casa”; una tattica di terrorismo preventivo e intimidatorio, utilizzata dalle forze occupanti tedesche per “bonificare” il territorio dalle bande di ribelli e punire i civili che osano dare sostegno alle formazioni partigiane.
Una precisa strategia militare già prevista dalle spietate direttive del generale Wilhelm Keitel, comandante in capo delle forze armate tedesche e ribadita dagli ordini draconiani del feldmaresciallo Albert Kesselring: non riuscendo a stanare ogni singolo partigiano che si nasconde in montagna, che combatte in collina o nelle città occupate, le truppe tedesche (con l’ausilio dei reparti armati di RSI) dovranno mettere a ferro e fuoco quei villaggi e quelle comunità che danno aiuto ai partigiani; si dovranno massacrare civili innocenti che possono dare ai partigiani rifugio, cibo e cure.
In quella fresca mattina d’estate del 29 giugno 1944 a Civitella, la gente si è radunata in chiesa per celebrare le festività dei santi Pietro e Paolo. Qualche giorno prima i partigiani della banda “Renzino”, che opera in zona, hanno teso un agguato e ucciso, in pieno giorno, alcuni soldati tedeschi presso il dopolavoro ferroviario della città. Nessuno però si aspetta rappresaglie, come lo stesso comando tedesco si affretta a dire, rassicurando la popolazione. E invece, quel 29 giugno, alle prime ore del mattino, circa 400 uomini della divisione tedesca accerchiano la collina da due lati; un reparto uccide tutti gli uomini nelle vicine frazioni che tentano la fuga, e incendia tutto. L’altro, entra nel borgo, raccoglie la popolazione sulla piazza del paese: donne e bambini vengono allontanati, mentre gli uomini radunati in gruppi di cinque, sono portati sul retro della scuola e uccisi da un colpo di pistola alla nuca. Tra le vittime c’è anche don Alcide Lazzeri, il parroco di Civitella, che invano tenta di difendere la sua gente. E mano a mano che la strage procede, i cadaveri vengono gettati nelle case in fiamme.
A Solaia, altra frazione, una donna, Modesta Rossi, viene massacrata col figlio in braccio, di neppure un anno. A Cornia (dove il 21 giugno i partigiani hanno aperto il fuoco e ferito un sottufficiale tedesco), viene messa a punto una vendetta ancora più terribile: il massacro colpisce donne e bambini e alcune sono costrette a subire violenza davanti ai mariti e ai figli. Tutte le case vengono date alle fiamme e fino a sera, per tutta la campagna, si sentono urla e spari.
A comandare l’operazione è un ufficiale tedesco di 28 anni, che le testimonianze descrivono dal carattere ironico e sicuro di sé: morirà sul fronte orientale, nel marzo 1945, senza scontare neppure un giorno di prigione per i suoi crimini.
Nel tempo, intorno all’eccidio di Civitella si è radicata una memoria divisa: una memoria che ha trovato appiglio nel dolore di donne e orfani, abbandonati dalle istituzioni del dopoguerra, lasciati in una profonda solitudine di fronte al trauma della morte e al dolore dell’elaborazione del lutto. Una solitudine che nel tempo è diventata rabbia, si è trasformata in un risentimento profondo verso le bande partigiane locali, accusate di aver scatenato la ritorsione tedesca. Ma quella rabbia (umanamente comprensibile) è stata abilmente strumentalizzata da narrazioni di comodo, da polemiche infinite, da distorsioni della verità intenzionate a prendere di mira le ragioni dell’antifascismo e di tutta la Resistenza. Da un uso pubblico della storia che ha potuto radicarsi soprattutto a causa dell’assenza di una giustizia, incapace nel dopoguerra, di inchiodare i carnefici alle loro responsabilità.
Oggi, grazie al lavoro degli storici, sappiamo che la strage di Civitella non è stata una rappresaglia compiuta per vendicarsi di azioni partigiane, ma una spietata operazione di polizia antipartigiana, usata per controllare un territorio in prossimità delle linee di difesa e ritirata.
Un massacro ordinario, un crimine di guerra, una ritorsione vigliacca. I tedeschi sanno benissimo che su quel territorio l’iniziativa partigiana è praticamente inesistente (anche se ogni tanto si manifesta), che i partigiani in zona sono pochi e mal organizzati. Ma sanno anche che la Resistenza potrebbe crescere e rafforzarsi proprio grazie al sostegno della popolazione civile. La consistenza delle truppe impiegate nell’eccidio dimostra come l’operazione fosse stata decisa da tempo dai vertici militari, per ripulire dalle bande di ribelli una zona considerata strategica. E a massacrare la gente di quel paesino, che ha solo la sfortuna di trovarsi a ridosso di una linea di fortificazione tedesca, ci sono anche tanti italiani: spie, delatori, confidenti dei comandi tedeschi di zona. Sono squadre di brigate nere e militi della GNR, a straziare i corpi di donne, vecchi e bambini nella zona di Cornia, insieme ai soldati nazisti: fascisti animati dal culto del sangue e della violenza, da un crudele spirito di vendetta che cresce man mano che la guerra si sente perduta.
È contro questa politica del terrore che i ribelli, i combattenti irregolari, i partigiani che si danno alla macchia cercano di resistere; e lo fanno come possono. La scelta di combattere non sarà né allora, né in seguito, una decisione presa a cuor leggero. Convincersi all'uso armato della violenza è un dramma di coscienza attraversato da dubbi, da crisi, da tormenti interiori: perché in fondo «ogni caduto somiglia a chi resta e gliene chiede ragione», come avrebbe ricordato Cesare Pavese nella sua Casa in collina.
Sta tutta qui l’etica della responsabilità di quei combattenti volontari, «dagli abiti laceri e dalle scarpe rotte», «straccioni affamati» come li chiamano i tedeschi, che scelgono la lotta al fascismo perché mossi dalla ferma convinzione che sia giunto il momento d’opporsi in maniera definitiva, risoluta e forte, anche con la violenza, a chi la violenza la usa mille volte di più.
A resistere dopo l’8 settembre del ’43 sono soprattutto ufficiali e soldati del regio esercito sbandato, che si danno alla macchia, ma anche giovani nati e cresciuti sotto il fascismo: studenti ispirati da uno spontaneismo libertario, patriottico, influenzato da Mazzini e da Croce, operai, antifascisti della prima ora, sorvegliati speciali, che hanno patito il carcere e il confino, e molte donne: sono i “piccoli maestri” decisi a mettersi fuori legge per farla finita con un regime ormai crollato, che ha portato la rovina della patria. Scegliere di resistere, è un atto di disobbedienza radicale contro il poter fascista (come scriverà Itali Calvino), che matura nell’intimo della propria coscienza, in solitudine, e si trasforma in assunzione di responsabilità con l’irrompere della guerra in casa.
Azioni di sabotaggio, attacchi a convogli in transito e a linee nemiche, agguati continui a tedeschi e fascisti nelle città occupate: chi combatte nella Resistenza deve misurarsi ogni giorno con eccidi, rastrellamenti e violenze, senza cedere mai alla paura e al ricatto delle rappresaglie. È una scelta coraggiosa ma non scontata, una scelta dolorosa e carica di responsabilità.
Una scelta verso la quale il paese dovrebbe riconoscenza.
E invece ad ogni anniversario del 25 aprile il paese è però scosso da un Processo alla Resistenza che punta il dito sulle ragioni dell’antifascismo, confondendo torti e ragioni, meriti e bassezze, valori e disvalori, che cerca di equiparare le azioni partigiane ad atti di terrorismo. Si assiste, di contro, a una generale riabilitazione del fascismo, quasi a giustificare le colpe dei tanti crimini commessi da militi della RSI, “buoni padri di famiglia”, costretti solo ad obbedire a ordini superiori”.
«Assassini», «vigliacchi», «terroristi», «colpevoli sfuggiti all’arresto»: così i revisionisti hanno da sempre definito i partigiani, accusati d’irresponsabilità per non essersi costituiti ai nazisti in modo da evitare rappresaglie. Ma si tratta di una questione tirata fuori in maniera consapevolmente faziosa da chi, allora e in seguito, fu incapace di considerare il profondissimo dilemma umano e intellettuale che i partigiani di tutta Europa si erano posti, con estrema serietà e coscienza. Al fatto, cioè, che proprio l’antifascismo, in tutte le sue componenti politico-culturali, si era da sempre ispirato all’idea di un’Europa in cui le nazioni potessero convivere pacificamente; ma con l’irrompere della guerra l’idea della pace non poteva indurre alla soluzione d’arrendersi, di cedere al ricatto delle rappresaglie.
L’assenza di processi contro criminali di guerra nazifascisti ha nel tempo alimentato l’odio verso i partigiani, permettendo ai carnefici di rimanere impuniti. Migliaia di documenti e fascicoli processuali illecitamente archiviati con nomi di vittime e carnefici, con testimonianze e luoghi di migliaia di eccidi in tutta la penisola. Documenti occultati per oltre 50 anni in nome delle ragioni della guerra fredda rinvenuti solo nel 1994 presso la sede della Procura militare di Palazzo Cesi a Roma. Un tragico Atlante delle stragi nazifasciste, con oltre 5000 episodi di violenza contro i civili commessi dall’esercito tedesco e dai suoi alleati fascisti, per il quale ben pochi hanno pagato.
Gli storici hanno recuperato fonti, scavato fra gli atti processuali, ascoltato memorie e testimonianze, fino a entrare negli abissi della mente di chi decise quei massacri. E oggi grazie alle sentenze pronunciate dalla magistratura militare italiana per i nazisti non è più possibile nascondersi dietro al dito degli ordini ricevuti: non solo i comandanti ma anche i soldati semplici hanno delle responsabilità. Perché per sterminare centinaia di persone inoffensive non è sufficiente dire ho obbedito a un ordine; bisogna credere a quell’ordine, bisogna essere disposti a considerarlo legittimo.
La Resistenza ha affermato il diritto di un popolo a non farsi massacrare, a non farsi annientare senza muovere un dito: il diritto di lottare (con e senz’armi) per riprendersi la libertà e restituire dignità al paese in cui il fascismo aveva avuto origine nel 1922.
Il 25 aprile è il simbolo di una libertà riconquistata a caro prezzo. Una giornata chiamata a celebrare il ricordo, per le generazioni future, di quei mesi di guerriglia, trascorsi clandestinamente sulle montagne, tra «agguati, rastrellamenti, e imboscate», dove ognuno, a modo suo, aveva imparato a combattere «per l’indipendenza della patria e per la dignità di uomini liberi».
In tutte le sue forme e ovunque si combattesse, nelle città presidiate dai Gap o a Nord della linea Gotica, tra gli Appennini e il Po, e ancora con la mobilitazione sociale nei luoghi di lavoro, nelle fabbriche e nelle campagne, la Resistenza rappresentò il senso più profondo della lotta contro questa politica criminale. Donne e uomini, partigiani e civili, internati e deportati: persone che, con modalità e tempi diversi (e per diverse ragioni) avevano contribuito a riscattare l’onore della Patria, gettata nel fango dal fascismo e dai suoi miti guerrieri. Alcuni trovarono la morte, altri divennero sopravvissuti, ma per tutti l’amore per la libertà aprì un nuovo sguardo al futuro. Ha scritto così Rosario Bentivegna, ricordando quei giorni:
«Capimmo allora, poco più́ che ventenni, che la pace tra uomini liberi era la cosa più́ bella del mondo e quella lezione non l’abbiamo mai dimenticata, noi che abbiamo dovuto batterci nella più́ feroce delle guerre e abbiamo visto cadere, al nostro fianco, tanti amici, compagni, tante persone che ci erano care. La guerra è la cosa più́ sporca, più́ ignobile che all’uomo possa capitare di vivere, anche se i fascisti la acclamavano e la invocavano come “unica igiene del mondo”».
Civitella, questo luogo della memoria ci parla oggi del senso di quella scelta antifascista; la scelta maturata da un’intera generazione costretta a battersi, come scrisse Piero Calamandrei «per necessità, non per odio», nell’idea di un possibile riscatto dell’Italia «dalla vergogna e dall’orrore del mondo».
Buona Liberazione Presidente.

Per una di quelle sincronie che lo affascinavano tanto, Paul Auster è morto nel giorno in cui la polizia in tenuta antisommossa ha assaltato la Columbia University occupata dagli studenti, come nei tumultuosi giorni del 1968 che ritornano in molti dei suoi libri: allora protestavano contro la guerra in Vietnam e il reclutamento dei Marines all’interno dell’università, oggi contro il massacro di civili inermi a Gaza. Nel 1968, studente della Columbia, Auster era un contestatore svogliato e non troppo convinto, e il suo impegno politico (si definiva “molto più a sinistra del partito democratico”) trovò poi nella letteratura uno strumento forte attraverso il quale esprimere il proprio dissenso. La sua opera è attraversata da una riflessione radicalmente pessimista sulla natura del potere, ed è sufficiente leggere alcuni dei suoi libri più noti, La musica del caso, Leviatano, Uomo nel buio fino al più recente 4321, per rendersene conto. Mi piace ricordare questa versione battagliera di Paul Auster (che fu tra l’altro a lungo impegnato in prima fila con il PEN Club), perché nei trent’anni in cui l’ho frequentato ho parlato con lui molto di letteratura, ma altrettanto spesso di politica: gli argomenti non mancavano da entrambi i lati dell’oceano. Il libro con cui si congederà dal pubblico italiano si intitola Un paese bagnato di sangue (uscirà il prossimo autunno da Einaudi) ed è uno straordinario pamphlet contro la diffusione delle armi da fuoco negli Stati Uniti e le fondamenta di violenza che reggono la storia americana.
In una frase di Peter Brook che Auster citava spesso, è nascosto forse il segreto della sua scrittura: “Nel mio lavoro cerco di combinare la vicinanza del quotidiano alla distanza del mito. Perché senza vicinanza non ci si può commuovere, e senza distanza non ci si può meravigliare”. La vicinanza del quotidiano si manifesta nei suoi libri nell’attenzione al dettaglio banale e nello stile realistico della narrazione. I romanzi partono talvolta dal micromondo della scrittura stessa: un taccuino intonso, una penna stilografica, oppure una macchina per scrivere, una scrivania in una stanza chiusa, isolata dal mondo. Poi arriva l’ondata di marea delle storie che investe il lettore e lo trascina per pagine e pagine, lontano. Auster ha trovato un modo unico per inserirsi nel solco della tradizione novecentesca di sovvertimento dei dogmi della letteratura, coltivando nello stesso tempo il gusto per un’arte antica, preromanzesca della narrazione. Ho sempre ammirato i suoi libri più famosi, da L’invenzione della solitudine a Trilogia di New York, ma il libro a cui sono più affezionato e in cui riaprendolo ritrovo lo scrittore che conoscevo, è un suo romanzo meno noto, La notte dell’oracolo. Raccontando l’avventura del giovane scrittore Sydney Orr, Auster porta a zonzo il lettore, apparentemente con lo scopo di fargli perdere l’orientamento, seguendo una linea narrativa ondivaga e tortuosa, e poi con un virtuosismo stupefacente riesce a trasformare quella stessa linea in una retta impeccabile, e il romanzo divagante in un intreccio perfetto.
Andrea Canobbio da «doppiozero», link



