L’uomo che trema
PREMIO NAPOLI PER LA NARRATIVA 2019



Ancora oggi, quando mi capita di riaprire il libro in un punto qualsiasi, quella tenerezza la sento ancora. E forse è questo il motivo per cui, malgrado abbia quasi diciott’anni, Rosario continua a sembrarmi piccolo.
Come si calcolano gli anni di un romanzo? Corrispondono ai nostri o – p. es. – per un’opera narrativa si potrebbe applicare il rapporto uomo-cane, che moltiplica per sette ogni anno canino, sì che un romanzo che ha, metti, dieci anni di vita, se ne ritroverebbe sul groppone settanta reali? Se così fosse, non saprei dire se la prospettiva dovrebbe entusiasmarmi o deprimermi, visto che Certi Bambini ha quasi diciott’anni e dunque dovrebbe dotarsi come minimo di un paio di stampelle. Considerato però che il libro è ancora fra noi, che il mio editore l’ha appena ristampato (con una copertina nuova, oltretutto: una bellissima foto scattata per l’occasione dal mio vecchio amico Mario Spada detto Spadino, che è stato anche il fotografo di scena del film tratto dal romanzo), direi che il mio Rosario (il nome del protagonista, per chi non l’avesse letto) si porta proprio bene i suoi anni.
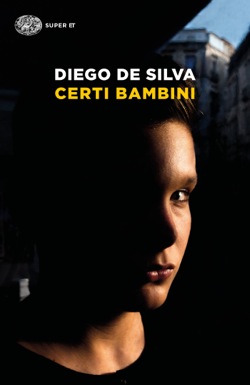
Ricordo esattamente la mattina in cui, in un’aula di udienza penale del tribunale che frequentavo da praticante agli inizi degli anni ‘90, questo bambino molto poco immaginario mi s’incistò nella testa, dettandomi nei mesi seguenti la sua storia. La camorra, all’epoca, non aveva ancora cominciato ad arruolare i minori (almeno, non sulla larga scala che conosciamo oggi), sicché imbattermi in un processo che vedeva coinvolto un undicenne in un’esecuzione criminale mi fece l’effetto di una scoperta, il sospetto di aver colto un passaggio epocale, una sorta di disgraziata avanguardia che negli anni seguenti – come poi è puntualmente avvenuto: non certo per mia capacità profetica ma perché era criminologicamente ovvio che così fosse – sarebbe diventata una regolare strategia di reclutamento di risorse (non solo umane, ma) bambine, particolarmente appetibili dalle mafie perché dotate della prerogativa della non punibilità.
Il primo titolo del romanzo (che inizialmente scrissi in forma di racconto) era Le istruzioni di Rosario. L’idea era di raccontare un bambino programmabile come un elettrodomestico (pensavo infatti a una lavatrice), una sorta di piccolo automa a cui impostare il programma e ordinare l’esecuzione del compito. Un bambino, perciò, che non avesse alcun senso etico delle proprie azioni, che si limitasse a ricevere un addestramento e ubbidire a un comando. Realizzare questa suggestione narrativa dipendeva essenzialmente dalla lingua che avrei scelto. Avrei dovuto parlare come lui, guardare le cose con i suoi occhi, descrivere la sua compassatezza davanti all’inguardabile, la sua ferocia improvvisa figlia dell’istinto di sopravvivenza e i suoi accessi di dolcezza, senza alcuna tentazione moralistica, alcun giudizio, quasi senza partecipazione.
Per quella via, però – me ne sono accorto fin dalle prime pagine, – Rosario acquistava una tenerezza, un candore che non avevo sospettato, quasi che il bambino negato dalla narrazione asciutta che avevo scelto finisse per riemergere a ogni pagina, rivendicando sottovoce la sua innocenza.
Ancora oggi, quando mi capita di riaprire il libro in un punto qualsiasi, quella tenerezza la sento ancora. E forse è questo il motivo per cui, malgrado abbia quasi diciott’anni, Rosario continua a sembrarmi piccolo.
Diego De Silva
---
Certi bambini è uscito nel 2001. Ha vinto il Premio Selezione Campiello, il Brancati, il Fiesole, il Bergamo, ed è stato finalista al Viareggio. Nel 2004 i fratelli Frazzi ne hanno tratto un film che ha vinto l’oscar europeo e due David. Questa è la sua sedicesima edizione.

«Lo senti il rumore di questa carezza?
Lo so che avverti il tocco, il passaggio lieve della mia mano sull’incavo del fianco, dal basso verso l’alto affinché la leggerezza sia bilanciata dal contropelo. Lo so che senti il movimento dei polpastrelli e del palmo, anche se hai gli occhi chiusi e il mezzo sorriso che ti increspa le labbra quando capisci i miei pensieri e ascolti le mie parole sussurrate.»
Iniziare un romanzo nero, di quelli che vanno a cercare le ombre nel buio delle anime, col rumore di una carezza può sembrare forse strano. Ma se si tratta dei Bastardi di Pizzofalcone, che con le ombre proprie e altrui combattono sempre, forse tanto strano non è.
Un affettuoso abbraccio a tutti i visitatori del nuovo sito Einaudi, e un arrivederci dal commissariato più scalcinato della città. Vuoto per i Bastardi di Pizzofalcone in arrivo. Presto, promesso!
Maurizio de Giovanni

«Nella vita di uno scrittore ci sono libri che nascono seguendo quasi un flusso naturale, restando fedeli, con nuove storie e nuove parole, al proprio mondo di riferimento. Ce ne sono poi altri, più rari e sorprendenti, che lasciano interdetto lo stesso autore. Non erano previsti, eppure esplodono, ti prendono per mano e ti portano in mondi che mai pensavi ti riguardassero. È questa la sensazione che ho avuto leggendo il nuovo libro di Paola Mastrocola» (Susanna Tamaro, «Corriere della Sera»).
Leone è un bambino come tanti, vive in un'anonima periferia, tra città e campagna, come tanti è figlio di genitori separati, e come tanti tiene ben chiuse in sé le sue inquietudini ed emozioni. Vive senza un binario da percorrere, senza che nessuno intuisca le sue prime domande sulla vita, sulla morte e sulla perdita. La madre, Katia, lavora in un supermercato e ha sempre fretta, il padre, Oscar, fa il camionista e lo va a trovare due volte al mese: i due sono separati.
Un giorno, all'improvviso, invece di fare i capricci, si mette a pregare, in mezzo alla strada, davanti ai passanti stupefatti.
L'anima dei bambini è bisognosa di affetto e di attenzioni, deve essere nutrita, invece Leone sembra essersi perduto, si sente un cestino portato qua e là. E un giorno, all'improvviso, invece di fare i capricci, si mette a pregare, in mezzo alla strada, davanti ai passanti stupefatti. La mamma cerca di convincersi che la cosa non sia mai successa, ma le preghiere continuano e lei non si capacita di vedere suo figlio inginocchiato per terra a pregare «come un santo», non in chiesa,in silenzio, ma davanti a tutti.
Dove ha imparato quel gesto? Non dai genitori, sposati in chiesa sì ma senza fede. Forse dalla nonna materna che lo aveva introdotto al mondo misterioso della fede.
Paola Mastrocola racconta una storia sorprendente, e attraverso gli occhi di una madre affaticata ma amorosa e di un bimbo che non si ribella come gli altri, richiama il lettore al senso del sacro e del mistero che sembrano essersi eclissati dal mondo. L'autrice, «con una sobrietà tanto accurata da ricordare Natalia Ginzburg, ci offre una grande metafora del nostro tempo. Delle nostre vite costrette a terra, senza possibilità di volo. Nemmeno come aspirazione» (Lidia Ravera. «Tuttolibri - La Stampa»).

Il 18 ottobre esce nelle sale italiane Il verdetto, film tratto dal capolavoro di Ian McEwan La ballata di Adam Henry. L’adattamento è diretto da Richard Eyre; nel cast, Emma Thompson, vincitrice del Premio Oscar nel 1993 come miglior attrice protagonista con Casa Howard, Stanley Tucci e Fionn Whitehead.
Fiona Maye, stimato giudice dell'Alta Corte britannica, che ha in carico le cause sui minori, deve affrontare un tema etico complesso: il giovane Adam Henry è un 17enne Testimone di Geova, malato di leucemia che, per ubbidire a un precetto religioso, rifiuta la trasfusione che può salvarlo. Stretta nella morsa di una vita privata fragile e di un ruolo pubblico che la vuole esempio di misura e distacco, Fiona dovrà dare un nuovo senso alla parola «responsabilità».
Il lato migliore della natura umana è l’armonia tra razionalità e compassione, logica ed empatia: tenerle insieme è difficile, così come capire la mente degli altri. Non sempre ci si riesce, ma è uno sforzo che ci rende umani. Ian McEwan, «il Fatto Quotidiano»
La storia affronta dunque anche il conflitto tra fede e ragione: «Mi piacciono romanzi, spettacoli e film che ci fanno pensare a come la gente conduce la propria vita. Non amo l’assenza di un universo morale complesso, anche se posso capire l’attrazione per le storie in cui tutto è bianco o nero, buono o cattivo. Ma la vita non va così. Mi appassiona l’arte che riflette il caos e l’ambiguità che ci circondano: per riuscire a farlo bisogna capire come si comportano le persone e in cosa credono. Questa, per me, è sensibilità morale» (Ian McEwan intervistato da Lorenzo Ormando, «il venerdì - la Repubblica»).

Dal 2 ottobre Einaudi ha aperto i suoi canali su Facebook e Instagram. Ad annunciarlo è stato il direttore editoriale Ernesto Franco: «La cosa che ci diverte di più è l'idea di portare la conversazione ininterrotta che è l'anima della casa editrice in questa più grande conversazione universale».
Dopo Twitter, YouTube e Pinterest si aggiungono dunque altre due vetrine importanti per dialogare con i lettori: tramite le pagine verranno condivisi gli highlights della rassegna stampa, gli eventi dei nostri autori e tutte le notizie più rilevanti riguardanti la Casa editrice.

Andrea Pomella
Ciao Nadia. Vorrei iniziare questa chiacchierata scoprendo subito le carte. Leggendo ciò che in molti hanno scritto a proposito del tuo romanzo, ho notato che le espressioni più frequenti sono: «ossessione di una perdita» e «assenza del padre». Sono i temi portanti non solo di Addio fantasmi, ma anche de Gli anni al contrario, ed è innegabile. Così come è innegabile che parliamo di eventi eccezionali nella vita di una persona. Eppure, noto una differenza nel modo di declinarli. Ne Gli anni al contrario ci conducevi nella storia che è all’origine dell’ossessione. In quel caso l’ossessione e l’assenza erano, per così dire, la conseguenza di fatti eccezionali, e forse anche il motore che ti ha spinto a raccontarli. Immergendosi tra le pagine del tuo nuovo libro, invece, ciò che salta all’occhio è il racconto non dell’eccezionalità, ma della normalità. L’assenza e l’ossessione ora si nascondono nelle pieghe del quotidiano. E il tutto è ben rappresentato dal titolo di un capitolo della seconda parte, Cose terribili come fossero normali e forse viceversa. Mi viene in mente che, se la letteratura di ogni tempo nasce dal racconto dell’eccezionalità – l’impresa, l’epopea, la saga, la morte, la terribilità dei fenomeni di natura – la tua attenzione sembra posarsi invece su ciò che resta quando le acque del diluvio si sono ritirate. Non è che, tutto sommato, l’eccezionalità del vivere sta proprio lì?
Nadia Terranova
Ciao Andrea. È coerente che tu, che hai fatto della narrazione autobiografica il fondamento del nuovo corso della tua letteratura, parta da queste considerazioni. Penso ad Anni luce, dove il racconto di una adolescenza come tante diventa lo specchio di tutte le adolescenze ribelli e inquiete del mondo. O a L’uomo che trema, dove attraverso visioni concrete (la malattia delle piante, il figlio piccolo che si arrampica sul corpo del padre depresso) dai senso narrativo a una malattia universale, trasversale e diffusa come la depressione. Tu parti da te e ti apri e chi legge vede sé, come nello specchio dentro l’anta dell’armadio. Non so se esiste un’eccezionalità del vivere, però esiste un’eccezionalità del raccontarlo, quella a cui chi scrive ambisce. Io ho imparato dai libri di Natalia Ginzburg e, dopo, da quelli di Annie Ernaux che gran parte delle storie che potevo raccontare stava dentro la mia infanzia e la mia famiglia. L’ho sempre saputo, ma è come se leggendo loro abbia sentito il permesso di farlo. Cesare Pavese e Giorgio Bassani mi hanno insegnato poi che da quel poco che avevo potevo partire per inventare e costruire e giocare d’inganno con la forma del romanzo. E usare i miei luoghi, la mia geografia, la provincia dove sono nata e cresciuta per farne il centro del mondo. Ho scoperto che non si tratta solo di cambiare nomi e situazioni, ma mettere un piede nell’immaginazione può aiutare il realismo più sfrenato. Quali sono gli autori a cui ti senti più debitore, in questo momento del tuo percorso?
Non so se esiste un’eccezionalità del vivere, però esiste un’eccezionalità del raccontarlo, quella a cui chi scrive ambisce. Nadia Terranova
A.P. Non ho autori a cui mi sento debitore, o forse ne ho talmente tanti che a elencarli tutti non basterebbe lo spazio che ci è riservato per questa conversazione. Potrei dirti il Brodkey di Questo buio feroce, ma non tutto Brodkey. Il Tondelli di Camere separate, ma non tutto Tondelli. Il Berto de Il male oscuro, e sarebbe fin troppo facile. Credo più nei singoli libri che nell’intera carriera letteraria di un autore. Pur avendo scelto la via del realismo autobiografico sono convinto che restiamo sempre, come dici tu, con “un piede nell’immaginazione”. Insomma, per quanto possiamo ridurre la distanza tra la realtà e il racconto che ne facciamo, rimane sempre un margine. Non si descrive la realtà, la si narra. Perciò è sempre fiction. Tu ed io siamo un po’ un esempio di come a partire dalla propria storia privata si possano prendere strade diverse. Perfino le ossessioni, l’assenza del padre, la malattia, l’infinito vagare nel proprio passato e in quello della propria famiglia, sono i moli comuni da cui siamo salpati. Eppure i nostri libri hanno preso forme diverse, com’è normale che sia. Io mescolo la narrazione pura al reportage, e in qualche caso all’indagine speculativa da saggio filosofico; tu resti fedele alla forma romanzo, allo schema logico della fabula. In questa tua scelta credi che possa rientrare in parte l’aver lavorato tanto a lungo nell’ambito della letteratura formalmente più esigente e rigorosa, quella destinata ai più giovani?
N.T. Direi che è il contrario, ho cominciato a scrivere prima per gli adulti e poi mi sono accorta di poter parlare anche ai ragazzi. Prendo molto sul serio l’attenzione del lettore, cerco di non dimenticare mai che sto ospitando qualcuno fra le mie parole, e che dietro quel qualcuno c’è una persona che fondamentalmente vuole sapere “come va a finire”. Sono stata una bambina e un’adolescente famelica, accumulavo romanzi su romanzi e non sbirciavo mai prima l’ultima pagina. Sono rimasta così. Credo che la letteratura ti modifichi profondamente mentre non te ne accorgi. C’è sempre un bambino anche nelle mie storie per adulti. A volte è il bambino che un personaggio è stato. A volte è un bambino fantasma, come nell'ultimo romanzo, quando Ida vede accanto a sé la creatura ferma a tredici anni, mai cresciuta dai tempi della scomparsa del padre. Anche tra le tue pagine c’è un bambino: è il figlio della voce narrante, e ci rivela una cosa terribile e ovvia insieme, ovvero che i bambini vedono tutto, anche la depressione. È curioso, perché anche Ida ha avuto un padre depresso. E così abbiamo entrambi accostato una malattia adulta a uno sguardo che si vorrebbe innocente. Io credo che non ci sia innocenza e non ci sia riparo neppure nell’infanzia. Soprattutto nell’infanzia.
A.P. C’è una concomitanza minore tra i nostri libri che però mi ha colpito molto, ha a che fare con le rondini. In Addio fantasmi c’è una scena in cui Ida bambina spera che una rondine elegga la sua casa a luogo di transito, e quando chiede: “Perché non si fermano pure da noi?”, la madre risponde: “Si nidifica solo dove è sporco”. Ne L’uomo che trema c’è la rievocazione di un nido che fu popolato dalle rondini solo nei tempi remoti dell’infanzia, prima di essere definitivamente abbandonato; un comportamento, quello delle rondini, che per i Greci aveva una connotazione profetica, perché evitavano le dimore votate alla rovina. È davvero singolare che per introdurre il tema della rovina abbiamo entrambi fatto ricorso alle rondini. Mi viene in mente una frase di Wittgenstein: “Il passato diventerà un mucchio di rovine e alla fine un mucchio di cenere, ma sulla cenere aleggeranno degli spiriti” (ecco che tornano i tuoi fantasmi!). Perché in senso stretto i nostri sono libri che raccontano rovine: le conseguenze di un trauma, di una malattia, di un abbandono, quell’oscuro angolo del passato che spesso nella storia di una famiglia diventa la-cosa-che-non-si-dice.
I nostri sono libri che raccontano rovine: le conseguenze di un trauma, di una malattia, di un abbandono, quell’oscuro angolo del passato che spesso nella storia di una famiglia diventa la-cosa-che-non-si-dice. Andrea Pomella
N.T. Gli anni al contrario finiva con un nido di rondini, quando scrivevo quella scena che è quasi all’inizio di Addio fantasmi volevo mettere un filo rosso fra i due libri, la fine che è un ricominciamento. Quando ho trovato le rondini nell’Uomo che trema ho sussultato, ho pensato: ma tu guarda se Andrea e io senza saperlo ci siamo scambiati pure le visioni. In fondo non abbiamo fatto altro che ragionare delle cose che nelle nostre famiglie non si potevano dire. Prima citavi Questo buio feroce di Harold Brodkey: lo hai letto prima di me, e io che non avevo il coraggio di leggerlo perché parlava di aids, la malattia di cui è morto mio padre e di cui non parlo mai ma invece scrivo negli Anni al contrario, ho trovato forza nello specchio della tua lettura. Questo forse non te l’avevo mai detto. Oppure penso a quando ti costringo a leggere Conversazione in Sicilia di Vittorini perché mi convinco che in quel momento possa servirti, con quei dialoghi fra il protagonista e la madre, si dicono tante cose ma a lungo evitano abilmente il cuore della loro ferita. Sentivo che stavi lavorando intorno a quel tema e volevo che lo attraversassi. Forse nella letteratura italiana moderna il racconto che meglio sintetizza questo scrivere intorno a una parola che non si può pronunciare è un racconto di Dino Buzzati, Una cosa che comincia per elle. La cosa che comincia per elle è la lebbra, è la vergogna, è la parola infetta che non si può dire. Come la tua pagina sulla parola padre: «La malattia in me, quindi, originariamente si è manifestata nella sfera del linguaggio. Mi autocensuravo, sopprimevo dal mio vocabolario alcune parole, parole che se pronunciate ad alta voce mi si conficcavano nella pelle come spine, parole che non riuscivo a tollerare e che se fossi stato il più spietato dittatore a capo di uno stato totalitario avrei abrogato dall’uso comune. Papà era ovviamente la più insopportabile di tutte. Una parola così leggera, impalpabile, che presuppone confidenza, scherzo, affetto, una parola che dentro di me risuonava sgradevole come un insetto in un occhio. Se mi trovavo costretto a pronunciare la parola papà, ero capace di vergognarmi per ore, di avvertire un malessere sordo e prolungato».
A.P. In effetti no, non mi avevi mai detto di Brodkey e di come il mio avertene parlato avesse provocato in te questo effetto-specchio. Qualche giorno fa ho partecipato a un incontro pubblico durante il quale, a un certo punto, si è parlato della capacità terapeutica dei libri. In linea di massima sono contrario all’idea della scrittura come autoterapia, credo che lo scrittore quando si mette al lavoro debba innanzitutto compiere un gesto di altruismo. Scrivere è parlare agli altri. La mia scrittura può essere semmai terapeutica per il lettore (non per me, o quantomeno non in via programmatica), ma spero sia anche tanto altro. Quando sono di umor nero penso addirittura che scrivere sia spargere un contagio. Nell’incipit di Diceria dell’untore, Bufalino, che so essere uno dei tuoi autori più amati, scrive: «Degli alberi non riuscivo a sognare che i nomi, ho imparato solo più tardi a incorporare nei nomi le forme». Se ci pensi è un potere enorme quello di saper incorporare nei nomi le forme. E da un potere enorme deriva un’enorme responsabilità. Una delle cose attraverso cui, da lettore, giudico la riuscita di un libro, è proprio il modo in cui l’autore dimostra di avere coscienza di questa responsabilità. Spesso i libri meno buoni sono libri irresponsabili, libri in cui si sente che l’autore non ha cognizione del proprio potere.
N.T. Quando ero più giovane e più spietata sostenevo a occhi chiusi che la letteratura non avesse il dovere di curare. In realtà lo penso ancora, la parola dovere vicino alla parola letteratura mi fa orrore (l’unico dovere che ha la letteratura per me è di essere interessante) però sono diventata diversamente indulgente: non posso non riconoscere che certi libri mi hanno aiutato a superare momenti difficili, di grande buio. L’anno del pensiero magico di Joan Didion non è solo un libro sulla vedovanza, è un libro sull’addio e sul tempo dei riti simbolici della sepoltura: può far bene perfino se a morire è una parte di te. I buoni libri li riconosci perché il loro effetto va al di là delle intenzioni dell’autore, in questo senso mi trovi d’accordo sulla potenza della perdita del potere. Se perdi il controllo su quello che hai scritto, aumenti la possibilità che altri ci leggano dentro le loro vite. Sempre Bufalino diceva «ho imparato a non rubare ascoltando Mozart»: sono le passioni, le distrazioni a renderti involontariamente una persona migliore (l’accento è su involontariamente) più che l’educazione civica. Se leggi Delitto e castigo come fai a essere razzista? C’è tanta esplorazione della complessità che poi non può mai venirti in mente una cosa cretina come il razzismo. Però poi mi rendo conto che neppure questo è vero, perché appunto le persone sono complesse, e la storia è piena di feroci sanguinari dalle inappuntabili ottime letture.
A.P. Viviamo un tempo di farneticazioni e d’odio, e la letteratura sta rispondendo come può e come deve, pur nell’oggettiva debolezza del suo peso sociale. E tuttavia i libri non smettono di essere anticorpi formidabili, come giustamente sottolinei tu citando Delitto e castigo (di questi tempi, con lo stesso spirito, invito chiunque a leggere Luce d’agosto di Faulkner). Molti scrittori italiani sono in prima linea nella lotta contro i respingimenti in mare e contro lo smantellamento in atto del sistema di accoglienza dei migranti, per non dire della difesa della 104 e dell’attenzione sempre alta su ogni tipo di manovra oscurantista messa in atto dall’attuale governo. Gli scrittori lo sono molto più di quanto non lo siano, per esempio, gli esponenti politici dei partiti d’opposizione. Questo è un dato oggettivo. In un paese in cui si lamenta da decenni la scomparsa di un tipo di figura intellettuale che faccia da guida ai processi di riforma e da argine alle barbarie, oggi scopriamo che a mancare in realtà è proprio la politica. E tutto questo accade in un’Italia in cui si legge pochissimo e in cui le istituzioni scolastiche sono al collasso. Voglio vederlo come un piccolo ma concreto spiraglio. Allora l’utopia che si rinnova è che, prima ancora delle ferite interiori, con i libri si possano lenire i mali del mondo.
N.T. Io sono molto arrabbiata con il vuoto lasciato dallo smantellamento politico e istituzionale perché sta costringendo tutti noi a far passare per rivoluzionari l’antirazzismo o l’accoglienza, che dovrebbero essere alla base della nostra società. Il rischio, presi dal dovere di colmare quel vuoto, è di ridurre la complessità: stare dalla parte del bene è una scelta civile, non per forza poetica. I libri che mi lasciano qualcosa sono una spina del fianco non di un comune nemico, ma mia. Io se leggo un romanzo, una poesia, se vado a teatro il male lo voglio riconoscere dentro di me, come nella tragedia greca. Cronistoria di un pensiero infame di Edoardo Albinati denuncia qualcosa di indicibile dentro di noi, è interessante perché viene da una persona che nella vita e nelle scelte concrete, anche di lavoro, è sempre stata dalla parte degli ultimi. Eppure, una volta, è caduto dentro un pensiero infame. Non importa dire se quel pensiero ha attraversato anche noi oppure ci ha risparmiato: importava indagarlo perché esiste, è nell’aria. Albinati, offrendo la sua indicibilità, ha fatto a pezzi l’immagine dello scrittore-guru. Continuo a credere che la letteratura abbia una possibilità superiore, una prospettiva diversa, fastidiosa, pungolante. Quando Sandro Veronesi propone agli scrittori di portare i propri corpi sulle navi in mezzo al Mediterraneo e Elena Stancanelli scrive un diario che è qualcosa di più di una cronaca siamo in presenza di qualcosa di fortissimo, c'è uno sguardo che si è fatto fisico e letterario insieme. Se uno riesce a scrivere un trattato sull’accoglienza che è pura poesia come l’inizio dell’Odissea, quando Telemaco vaga di corte in corte alla ricerca di notizie del padre, o quando Ulisse viene ricevuto dai Feaci, ecco, allora resterà davvero per sempre.
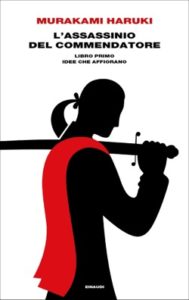
Sono sedici anni, dunque, che pagina dopo pagina, volume dopo volume, porto le opere di Murakami nelle mani degli italiani, le sue storie nelle loro vite e nei loro cuori. Andrea Pomella
Per ricordare in che anno ho iniziato a tradurre Murakami Haruki, ho dovuto andare a ripescare, tra i vari documenti che conservo nel mio archivio, il contratto che stipulai a suo tempo con la casa editrice che mi commissionò la traduzione del primo volume di L’uccello che girava la viti del mondo: 30 luglio 1997. Il titolo del romanzo era scritto in inglese − The Wind-up Bird Chronicle −, quello italiano glielo misi io, cercando di rendere nel modo più adeguato quel nejimakidōri kuronikku (cronache dell’uccello-giraviti) di cui compresi il significato soltanto dopo aver letto alcuni capitoli del libro. Sono sedici anni, dunque, che pagina dopo pagina, volume dopo volume, porto le opere di Murakami nelle mani degli italiani, le sue storie nelle loro vite e nei loro cuori.
Il mio incontro letterario con questo scrittore − uno scrittore che avrebbe occupato un posto tanto importante nella mia attività lavorativa −, è avvenuto verso la metà degli anni Ottanta, quando vivevo in Giappone. Stavo andando in treno da Osaka a Tokyo, e per la prima volta mi cimentavo nella lettura di un libro giapponese in lingua originale: quel libro era Nel segno della pecora. Se avevo scelto proprio quel romanzo, era perché degli amici mi avevano garantito che una volta iniziato, non sarei riuscita a staccarmene, che il desiderio di andare avanti mi avrebbe aiutato a sormontare tutte le difficoltà. E le cose andarono esattamente così.
La traduzione letteraria non è un lavoro da cui si possa “staccare” chiudendo il computer, continua a occupare in modo più o meno conscio la mente anche quando si sta pensando ad altre cose. Andrea Pomella
Mentre in treno leggevo dunque Hitsuji-o meguru bōken − “Avventura alla ricerca della pecora” −, non immaginavo nemmeno lontanamente che molti anni dopo l’avrei tradotto nella mia lingua. Che di Murakami Haruki avrei volto in italiano diverse opere − romanzi, racconti brevi, saggi − tanto che quest’autore è diventato ormai una presenza periodica nella mia vita professionale, vale a dire nella mia vita tout court. Perché la traduzione letteraria non è un lavoro da cui si possa “staccare” chiudendo il computer, continua a occupare in modo più o meno conscio la mente anche quando si sta pensando ad altre cose.
Tradurre, si sa, è un lavoro che si fa per passione. Non ci può essere un altro motivo al mondo per indurre una persona a dedicare mesi e anni a un’attività mal pagata che dà pochissima visibilità. Proprio perché lo si fa per passione, però, la condizione sine-qua-non è che si traduca un autore che piace, altrimenti il risultato sarà deludente. Se non si crea una simbiosi con l’autore, nessun traduttore − per quanto buona sia la sua conoscenza della lingua d’origine di un’opera, e la sua padronanza della propria −, riuscirà a far rivivere un libro in un’altra lingua.
Ora, tradurre Murakami a me piace. Mi piace perché racconta il Giappone quale l’ho conosciuto io, parla di persone come quelle che ho incontrato durante i sedici anni che ho trascorso in quel paese e fra le quali mi sono fatta degli amici, descrive la vita d’ogni giorno; e in questo modo avvicina il lettore italiano a un popolo in apparenza tanto lontano, gli permette di scoprire che i Giapponesi fanno più o meno le stesse cose che la gente fa in Italia e ovunque nel mondo industrializzato, che comprano più o meno gli stessi prodotti, ascoltano la stessa musica, addirittura mangiano spesso le stesse cose. E hanno lo stesso nostro bisogno di evadere con la fantasia dalla routine quotidiana. Perché è questo che Murakami permette al lettore di fare: lo introduce in un’atmosfera in apparenza banale, nella vita di un personaggio anonimo che potrebbe essere ognuno di noi − un vicino di casa, un collega di lavoro −, e lo porta a poco a poco in una dimensione fantastica. Quasi inavvertitamente i suoi protagonisti varcano una soglia proibita al di là della quale si apre un mondo diverso, irreale eppure descritto in maniera dettagliata e verosimile − verosimile perché dettagliata −, credibile perché trova riscontro nei fantasmi, nelle paure, nei desideri presenti nel nostro inconscio. Di conseguenza, tradurre Murakami significa seguirlo in un viaggio straordinario − in una dimensione solo in apparenza al di fuori della realtà, perché è dentro di noi che si trova −, con la consapevolezza di trascinare con sé il lettore. Ogni sua cosa che ho tradotto − dai romanzi lunghi come L’uccello che girava le viti del mondo o La fine del mondo e il paese delle meraviglie, a quelli brevi come After dark, ai racconti −, mi ha dato quest’impressione.
A volte mi sento chiedere se preferisco tradurre Murakami Haruki o Natsume Soseki, altro scrittore di cui ho tradotto molte opere. E ogni volta rispondo che è una domanda cui non so rispondere. Si tratta di due generi di scrittura così lontani l’uno dall’altro − nei temi, nelle atmosfere, nello stile − che un confronto non è possibile. Soseki è un autore classico dei primi del Novecento, considero tradurlo un privilegio, entro nella sua scrittura con devozione, sedotta dalla sua ironia e dalla sua poesia. Murakami, che appartiene alla mia generazione, è come un amico di vecchia data, dopo anni di frequentazione assidua ne conosco i pensieri, le abitudini, le debolezze e le manie; ne intuisco le motivazioni e i fini, ne condivido le idee su molti argomenti, ne apprezzo le intenzioni, mi sento vicina a lui anche per carattere. Come lui, amo la solitudine, e questo mi aiuta a calarmi nei panni di tanti suoi personaggi: di una persona che si cucina cene semplici ma buone ascoltando la radio, che ama la musica jazz, che guarda videocassette di vecchi film e aspira a vivere tranquilla, ma in seguito a qualche evento in apparenza banale − una telefonata, la scomparsa del gatto di casa − viene coinvolta in una storia assurda. Come accade con i vecchi amici, a volte succede che Murakami mi irriti, o mi stanchi. Non perché i suoi testi siano particolarmente difficili, al contrario: scrive in un lingua piuttosto semplice che riproduce quella parlata, e non usa molti ideogrammi. Ma quando ripete quattro volte l’espressione “fazzoletti di carta” in una pagina, quando descrive maniacalmente i gesti che un personaggio compie nel lavarsi e nel vestirsi, o fa una dettagliata lista della spesa, confesso sinceramente che qualche improperio glielo lancio. Ma perché non taglia, mi chiedo spesso, perché non stringe? Tanto più che a tradurre si impiega molto più tempo che a leggere, e certe pagine mi sembrano interminabili. Poi, quando rileggo quello che ho scritto, mi rendo conto che invece ha ragione lui: perché nella vita succede proprio così, la gente dice e ridice sempre le stesse cose, ripete gli stessi gesti, cede alle proprie manie, e il fatto di rappresentare la realtà senza abbellirla è quello che rende i personaggi di Murakami così vicini al lettore, così umani e veri, le sue atmosfere così familiari e intime.
Ci sono poi momenti in cui il coinvolgimento emotivo col testo che devo tradurre è talmente forte, che per poter lavorare devo prendere le distanze. Questo mi succede soprattutto quando mi trovo davanti a descrizioni di violenza: donne stuprate, uomini scorticati vivi e altre amenità del genere. In questi casi, superato l’impatto emotivo suscitato dalla prima lettura, mi occorre fare come il chirurgo davanti al tavolo operatorio, mettere da parte la mia sensibilità per concentrarmi sull’accuratezza della traduzione. Tanto so che la violenza, nelle opere di Murakami, non è mai fine a se stessa, ma fa parte di una trama il cui senso profondo esprime una concezione dell’umanità e della società che condivido pienamente.
Ci sono poi momenti in cui il coinvolgimento emotivo col testo che devo tradurre è talmente forte, che per poter lavorare devo prendere le distanze. Andrea Pomella
L’unica volta in cui non sono riuscita a prendere questa distanza dal testo, è stata quando ho tradotto Underground, il racconto dell’attentato al sarin avvenuto nella metropolitana di Tokyo nel marzo del ’95. Il fatto che non si trattasse di fiction, ma di storie vere di sofferenza, mi commuoveva al punto di impedirmi ogni distacco professionale. Nel volgere in italiano le parole del fratello di Akashi Shizuko, gravemente danneggiata in tutte le funzioni vitali a causa dell’intossicazione, o della moglie e dei genitori di Waka Ichirō, morto in ospedale senza aver ripreso conoscenza, non riuscivo a reprimere la tristezza e lo sdegno. Tristezza e sdegno che sentivo di condividere con Murakami. Per questa ragione, di tutte le sue opere, Underground è quella che mi è più cara.
Se poi dovessi indicare quella che più mi sono divertita a tradurre, sarei in difficoltà. Più che dei libri interi, mi hanno stimolato alcuni passaggi di certi romanzi, o alcuni racconti. Per quanto strano possa sembrare, rendere in italiano la nefandenzza del laido personaggio di Ushikawa, in L’uccello che girava le viti del mondo, è stato un vero spasso, così come mi ha affascinato riprodurre l’atmosfera spettrale della città-fantasma in La fine del mondo e il paese delle meraviglie, o il carattere leggendario della storia dei coloni in Nel segno della pecora. Quanto alla vivacità e al ritmo incalzante di Una ragazza perfetta al 100%, uno dei racconti che fanno parte della raccolta L’elefante scomparso, credo sia stato uno dei momenti di maggior entusiasmo nel mio rapporto con la scrittura di Murakami Haruki.
Entusiasmo che ho ritrovato pienamente nel tradurre L’assassinio del Commendatore, l’ultimo suo romanzo, appena uscito nelle librerie italiane.
Antonietta Pastore, articolo pubblicato su «L'Indice dei Libri del Mese» (luglio 2013)

Da quasi un decennio la Xylella fastidiosa sta uccidendo gli ulivi in Sud Italia. L'epidemia è scoppiata nella zona di Gallipoli, portata dal mare, da chissà dove, e da lì non ha fatto che allargarsi. Fin dall'inizio, è stato proposto un piano di eradicazione degli esemplari infetti, così come di tutti quelli sani nel raggio di un centinaio di metri, al fine di contenere la malattia: alberi di quattro o cinquecento anni amputati, scalzati dal suolo e bruciati in un pomeriggio come misura di emergenza. Una strage, insomma.
Alberi di quattro o cinquecento anni amputati, scalzati dal suolo e bruciati. Una strage, insomma. Andrea Pomella
Se non avete mai visto gli ulivi secolari della Puglia, statuari nelle distese di terra rossa, è probabile che non capiate di che cosa io parli, né del perché ne stia parlando. Ma se li avete visti, se vi siete avvicinati anche una sola volta alla loro corteccia tortuosa e grigia, alle fessure e ai nodi del tronco, allora sapete che non c'è bisogno di essere dei mistici o dei fanatici dell'ecologia per accorgersi che in quegli alberi vi è qualcosa di diverso. Che sembrano senzienti, e non in modo vegetale ma come sono senzienti gli animali. Sebbene io non l'abbia mai fatto, non mi stupisce che ci siano persone inclini ad abbracciare quei tronchi per riceverne forza. E tantomeno mi stupisce che, di fronte a una minaccia, non solo gli agricoltori e i proprietari terrieri, ma anche ragazzi di vent'anni, animati da un senso istintivo di ciò che è giusto, possano fare cordone intorno a quelle sculture viventi perché vengano risparmiate.

Era l'estate del 2014 quando ho sentito parlare per la prima volta del presidio di Oria. Mi ero sposato da poche settimane e in quel periodo non mi sentivo attirato dal alcun genere di battaglia. Mi sembrava un intervallo della vita dedicato legittimamente alla calma, alla contemplazione, a un po' di felicità superficiale. Ma il presidio era lì, a pochi chilometri da dove trascorrevo le vacanze, quasi un affronto non considerarlo. Così un pomeriggio, di ritorno dal mare, mi sono inoltrato nelle strade di campagna, lungo gli sterrati protetti dai muri a secco. Il presidio era isolato, c'è voluto un po'. Infine ho trovato una dozzina di ragazzi, accampati tra alcune tende e un rudere, bevevano birra, fumavano, alcuni di loro giocavano a carte. Mi sembravano annoiati eppure in allerta, come pronti ad attivarsi per un'urgenza che prima o poi sarebbe arrivata. All'inizio mi hanno trattato con sospetto, poi devono avermi valutato innocuo e hanno acconsentito a mostrarmi gli ulivi abbattuti, coricati a terra in attesa di essere bruciati, e gli altri intorno, marcati con una X di vernice rossa, in attesa della stessa sorte. Avrebbero difeso quegli alberi a ogni costo.
Avevo intenzione di scrivere un articolo su quella visita, ma alla fine non l'ho fatto. Mi ero già messo a lavorare a un romanzo e tornando verso casa – il sole basso sull'orizzonte e l'immagine insistente di quei ragazzi e degli ulivi condannati –, ho avvertito come l'incontro di quel pomeriggio avesse già modificato l'evoluzione della storia nella mia mente.
Sono passati quattro anni e nel frattempo la situazione in Puglia è precipitata. Il guazzabuglio d'informazioni contraddittorie sull'infestazione, di tesi scientifiche e pseudoscientifiche affiancate senza ritegno, di teorie complottiste, d'interessi economici, d'intimidazioni, d'inefficienza politica e di tipico lassismo italiano, hanno determinato una paralisi che ha lasciato il batterio libero di diffondersi di pianta in pianta, verso nord, come una cancrena inarrestabile. Oggi il Salento è gravemente compromesso. Guidando lungo la superstrada che collega Brindisi a Lecce il disastro è visibile a occhio nudo: alberi maestosi che l'estate prima avevano al più qualche ciuffo di foglie ingiallite sono ormai degli scheletri, gli oliveti delle distese spettrali. È un panorama che stringe la gola di commozione.
Alberi maestosi che l'estate prima avevano al più qualche ciuffo di foglie ingiallite sono ormai degli scheletri. È un panorama che stringe la gola di commozione. Andrea Pomella
In una certa misura, credo che si possano considerare i presidi corresponsabili del disastro. Senza ostruzionismo il programma di contenimento della Xylella avrebbe funzionato? Se il problema fosse stato affrontato con freddo senso di realtà, senza patetismi, senza un briciolo di cuore, lo avremmo risolto in tempo? E tuttavia, neppure con le conseguenze davanti, le risposte mi sembrano così semplici, univoche. Abbattere degli ulivi per salvare gli ulivi? Oppure, al contrario, proteggere pochi ulivi condannando così tutti gli ulivi? È quel genere di paradosso etico stritolante nel quale la vita ci getta spesso. Un paradosso che tocca le coscienze individuali in modi così diversi che, tenendo conto di tutto, non possiamo che ammutolire. Non a caso, il pasticcio della Xylella ha polarizzato violentemente l'opinione pubblica, spaccandola in due fazioni che si rifiutano anche solo di accogliere le ragioni opposte. Il pensiero nella sua interezza, troppo complicato, viene reciso di netto e ci si lascia prendere da qualcosa di meno razionale: l'indole, le impressioni, ciò che si sente dire in giro. La politica non fa che aggravare la situazione, sposando con la stessa spregiudicatezza una causa o l'altra per pura convenienza, fino a negare, com'è successo a luglio scorso, l'esistenza stessa dell'epidemia. E così, nell'irrigidirsi delle posizioni, nell'alzarsi costante dei toni, il batterio continua silenzioso a riprodursi, a divorare, a soffocare i vasi linfatici degli ulivi.
Scrivendo un romanzo si mettono il più possibile a tacere le proprie opinioni per non corrompere quelle dei personaggi. Quando ho seguito Bern e Teresa e Danco e Giuliana al presidio e poi in cima agli alberi, l'ho fatto con totale disarmo e tuttavia con la consapevolezza sottostante che difficilmente mi sarei trovato insieme a loro in una lotta come quella. Ma il fatto stesso di aver scelto la loro storia fra le infinite intorno tradisce, mi sembra, una possibilità della mia anima: quella possibilità che ho intuito ascoltando, dapprima pieno di scetticismo, i ragazzi di Oria, registrando la loro indignazione per quelle X di vernice rossa. Una possibilità di resistenza, che l'immensità della campagna piatta intorno rendeva ancora più futile, e quindi più romantica, più eroica. Oggi, ogni volta che ascolto qualche aggiornamento a proposito dell'epidemia, oppure qualche storia analoga – la protesta di Hambach, le manifestazioni contro l'aeroporto a Nantes –, quella possibilità si riattiva in me. È sotterranea eppure vigile, e non vuole sentire ragioni, non vuole più ascoltare o negoziare. Scalpita per arrampicarsi sui tronchi invece, su fino ai rami più alti e da lì, in mezzo a questa guerra ambientale persa ormai da tempo, da generazioni che hanno preceduto la nostra, il mezzo della desertificazione che avanza inarrestabile; da lì vuole gridare: «No. Almeno qui no. Questo singolo albero, no».
Paolo Giordano
